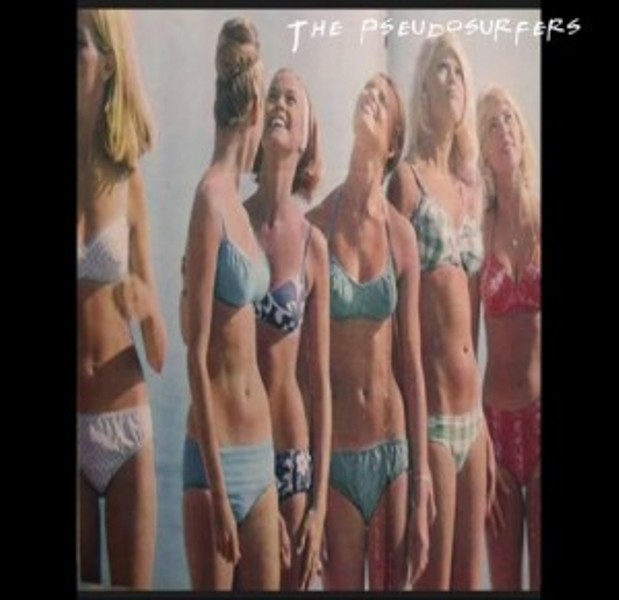Daniel ed Eleni Benjamin, lui tedesco che canta e suona chitarra, batteria, campane e piatti ma non sa leggere la musica, lei greca, voce e suona clavicembalo, batteria, organo bass pedal, sono compagni di vita e d’arte riuniti sotto il moniker “naturalistico” di Sea + Air e arrivano al fatidico esordio con l’album “My heart’s sick chord” come fossero calati dentro una bolla di vetro, fauni di un folk-pop arieggiato, un cantautorato silvestre e boschivo che rammenta gli Arborea dei tempi migliori e gli afflati espansi degli Appalachi, ma anche una certa agevolezza sperimentale rock messa a confronto con liscive Seventies teutoniche (Popol Vuh) e stranezze sfaccettate alla Flaming Lips; tredici tracce che movimentano un album suonato con quattro/cinque strumenti e che mette al centro anche un amore per il barocchismo Bachiano, il clavicembalo e artifici cromati abbaglianti.
Però come in tutte le cose, “il troppo stroppia”, troppa carne messa sul fuoco a cuocere, molte strade sonore che fanno perdere l’equilibrio stilistico dell’ascolto e che generano un complessivo musicale che corre subito via, che si dimentica facilmente e senza lasciare una traccia indelebile nella memoria; un disco che raccoglie movimenti orchestrali congelati dal tempo, coperti sì da una coperta tenera e morbida, ma che non hanno una precisa identità, caratteristica o tic contagiosi che li faccia fermare e rintracciare dal tasto repeat. Pop, sinfonismi, forme canzoni alla Ghost “la titletrack”, i citati Arborea “Mercy street”, “Safe from harm” il pop versato alla Sting “The sea after a storm”, “Do animal cry? , i sintomi elettrici dei Flaming Lips “Yeah I know” e quelle tubolarità soft ottime per spot pubblicitari di dolcezze o affini “Ist life”.
Il duo di Stoccarda degli Sea + Air iniziano bene questo loro primo progetto ma poi si perdono in mille rivoli, nelle mille intrecciate arterie che non fanno altro che confondere il vero intento della loro prestanza sonica, forse è la necessità di dare tutto e subito, ma facendo così Mare + Aria non hanno mai fatto = Fuoco.
Un disco a metà aspettando tempi migliori.