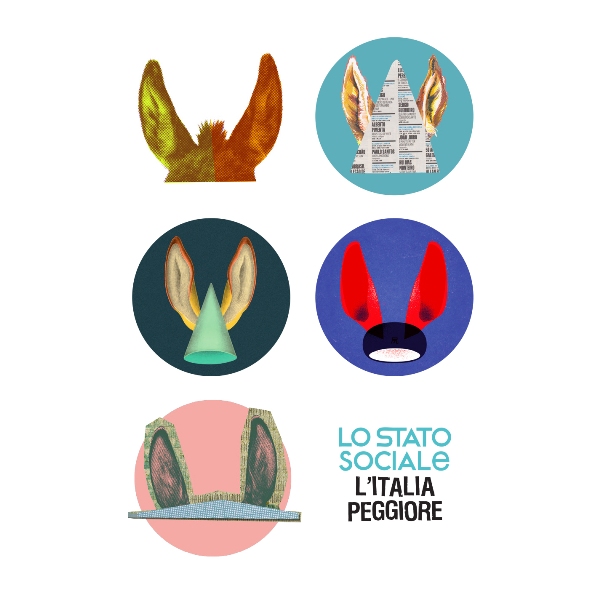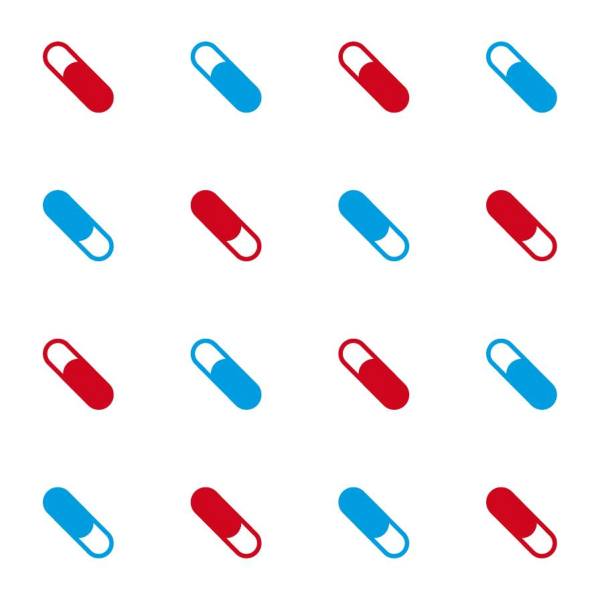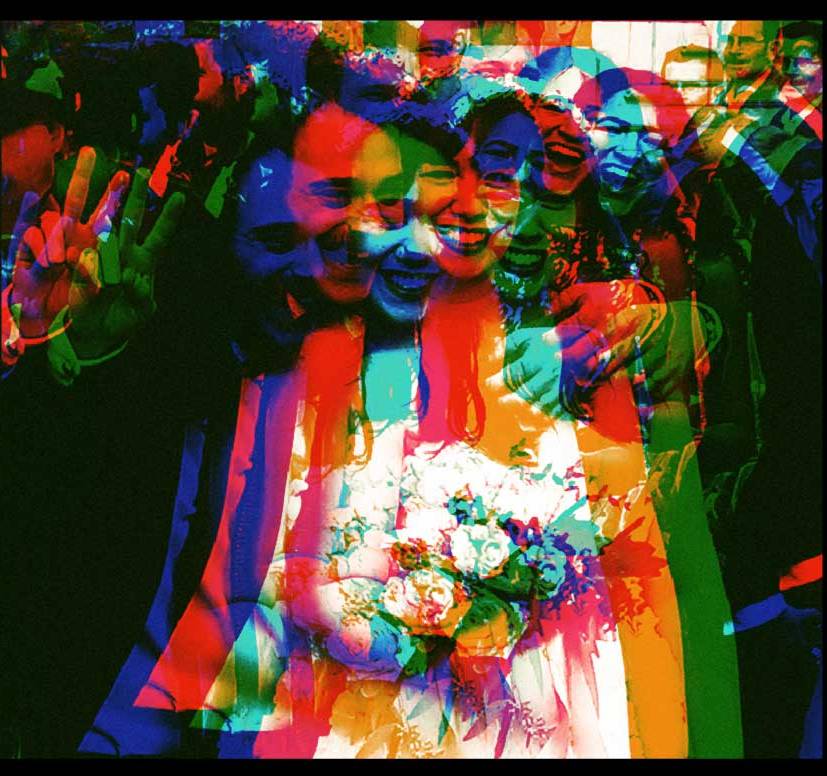Continua il Theatre Quinto Festival e continuano i nostri report dalla cara vecchia Rozzano. Questa volta parliamo di rap anomalo, di pubblico variopinto, di atmosfere festanti e non prive di contenuti…ma soprattutto parliamo di Dargen D’Amico, vero e assoluto protagonista della serata. Una serata che si prospettava sui generis già dalla partenza. Il riscaldamento del pubblico in attesa di DD è stato infatti affidato a tre act molto diversi, che però hanno saputo intercettare il favore del pubblico, interessato fin dalle prime note della chitarra acustica di Bandit, cantautore accompagnato da altre due chitarre – sempre acustiche – a fargli da supporto. Evitato con grazia l’effetto mariachi, Bandit è riuscito a far interessare di sé le tre/quattro file di pubblico già presente, complice l’immediatezza e la simpatia ironica dei suoi brani. Il suo essere seguito con attenzione da un pubblico che ci si poteva aspettare più hip hop-centrico è stato il primo indizio della qualità e della eterogeneità dei fan di Dargen. Sceso dal palco Bandit, prendono il suo posto i Rigor Monkeez, gruppo Hip Hop che è una vera fucina di progetti. I tre corrono come treni, e cercano di scaldare la sala – sempre più piena – con entusiasmo (forse troppo). Il pubblico inizia lentamente a rispondere: i brani dei RM sono densi ma orecchiabili, anche se le basi non spingono quanto dovrebbero. Complessivamente un’ottima prova, che lascia la sala carica e pronta al set dell’ultima apertura, quel Mistico di bocciofiliana memoria, che alza il tiro sparando a tutto volume tre/quattro brani danzerecci e mediamente disimpegnati, per poi, con grande senso della misura, ritirarsi, lasciando spazio all’attesissimo Dargen.
Iniziamo col dire che il grande talento di Dargen D’Amico è saper ammaestrare le folle come un domatore consumato (talento che è secondo solo alla sua maestria nell’uso della parola). Già dai primi momenti, il pubblico è nelle mani del rapper, che, in piedi dietro alla consolle (gestisce da sé le basi e il mixer), pare una figura messianica, un santone, venerato e adorato al ritmo di bassi tribali e mani che si muovono alte nell’aria. È una figura affascinante, che già dall’aspetto non suggerisce la chiusura che ci si aspetterebbe, da profani, nei concerti hip hop: camicia blu, occhiali a specchio, snocciola rime con una voce inconfondibile e una semplicità disarmante. Lo accompagnano, accentuando la sensazione di trovarsi fuori dal circuito hip hop più chiuso, i Fratelli Calafuria, uno per lato, come chierichetti rock ad officiare una messa crossover con chitarre elettriche sopra basi energiche e trascinanti. Dargen inanella i pezzi con sapienza, li introduce con semplicità e simpatia: sa far ridere il suo pubblico, e sa farlo stare attento quando serve. D’altra parte, i fan rispondono benissimo: lo adorano, e si sente. La scaletta è costruita per essere rapida e piacevole, anche per chi, come me, non segue assiduamente Dargen e non conosce a menadito tutta la sua discografia: ingrediente fondamentale è la scelta di eseguire, anche solo per una strofa e un ritornello, molti dei featuring che hanno contribuito a far conoscere Dargen anche al di là della cerchia dei suoi ascoltatori abituali (penso a “Festa Festa” con i Crookers e Fibra, a “Un Posto per Me” di Andrea Nardinocchi, a “Quella Giusta per Te” con Stylophonic e Malika Ayane, ma anche a “La Cassa Spinge” con Dumbblonde e Lucky Beard). Per il resto, la scaletta pesca a piene mani dall’ultimo Vivere Aiuta a non Morire, senza lasciare dietro altri classici come “Sms Alla Madonna” o “Odio Volare”. Non ci si fa mancare neanche un omaggio ai Calafuria con “Bisogna Fare Casino” e, ovviamente, una “Bocciofili” esplosiva con Mistico di nuovo sul palco.
Un concerto intenso, insomma, che, come tutta l’opera di Dargen, può essere vissuto su due livelli: un primo, più immediato, di divertimento e danza, di ritmi e risate e festa, e un secondo, ancora più soddisfacente, fatto di parole e significati, di tecnica acuta e di suggestioni profonde, che però non tolgono nulla alla piacevolezza dell’ascolto e alla tensione del pubblico (“Il Presidente” e “V V”, nonostante lo stile e gli argomenti, hanno elettrizzato tutta la sala, me compreso). Dargen D’Amico è un’artista che si conferma più che capace, un personaggio veramente unico nel suo genere, in grado di unire la profondità del Rap più artistico e per certi versi letterario all’immediatezza anche “cazzona” dell’aspetto ludico e festaiolo dell’Hip Hop, riuscendo a convincere anche chi, come me, nel rap non sguazza troppo spesso. Da vedere se vi va di passare una serata divertente senza offendere la vostra intelligenza: si può fare, e Dargen D’Amico ne è la prova. Appuntamento alla prossima settimana con il report dei Nada’r Solo sempre dal Theatre Quinto Festival, sempre su Rockambula!