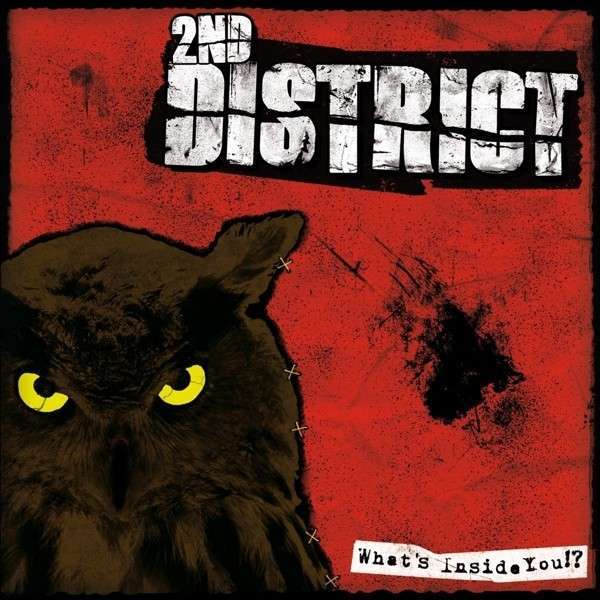Due premesse sono dovute. Punto primo: sono un fan del Boss dal 2009 (ovvero dalla prima volta che l’ho visto dal vivo) al punto da esserne quasi patologico. Quattro concerti (solo?) in stadi che quella notte sembravano il salotto di casa mia pieno di 70.000 parenti e amici del cuore. Un inequivocabile tatuaggione tamarro sul polpaccio a citare “Born To Run” (con tanto di font uguale al disco). E soprattutto non passa giorno della mia vita che non ascolti almeno una sua canzone, come una medicina contro qualsiasi accenno al mal di vivere o semplicemente per amplificare qualunque piccola o grande emozione. Punto secondo: ad essere onesti, su questo disco di “grandi aspettative” non ne avevo proprio. Non sono per nulla un sostenitore del chitarrismo di Tom Morello, soprattutto in tutto ciò che va fuori dal suo seminato (che a mio avviso si limita ai Rage Against The Machine e poco altro). La notizia della sua presenza in quasi tutti i brani di un album costruito da canzoni rispolverate dal passato non mi convinceva per nulla. Lo ammetto mi puzzava di un disco di auto-cover, registrato in tour con take recuperate dagli archivi. E non ne capivo la necessità. Ma Springsteen non fa nulla a caso e sapevo che la sorpresa sarebbe stata dietro l’angolo.
High Hopes infatti è un buon lavoro, incredibilmente compatto nella sua disomogeneità. Un blocco unico nonostante il minestrone di canzoni pescate qua e la nel tempo. È solido ed è il disco più Rock’n’Roll del Boss dai tempi di Lucky Town/Human Touch. Meno ispirato del rabbioso e corale Gospel di Wrecking Ball, da cui eredita però un pugno chiuso e il muscolo teso. Ma quello quasi mai è mancato nella discografia dell’eterno ragazzo del New Jersey. Anche la produzione, mescolata pure quella tra il superbig Brendan O’Brien e Ron Aniello, segue comunque una linea ben definita con la chitarra di Tom Morello che spinge tutto sull’acceleratore e la voce di Bruce, sempre più in forma e sempre più espressiva. A tracciare una strada che non presenta alcuna incertezza. E poi c’è tutta la E-Street Band, comprese registrazioni dei compianti Clarence Clemons e Danny Federici. Sentirli suonare (anche su disco) è sempre un brivido sulla pelle. La title track è una cover dei californiani The Havalinas. Rullante incalzante, percussioni, chitarre acustiche, cori e fiati a profusione. Poi l’inconfondibile chitarra di Morello, forse non quello che ti aspetteresti, ma il corpo si muove senza freni: ottimismo e fede. “Harry’s Place” è scura con basso e synth in primo piano, il sax di Clarence Clemons porta la canzone ad un altro livello. “American Skin (41 Shots)” è un brano del 2001 e rinasce in chiave più rabbiosa e moderna con tanto di bit campionati. Perde però un po’ l’umanità e il melanconico incalzare presente nella versione del “Live in New York 2001”. In ogni caso registra il miglior assolo di Tom Morello in questo disco. Non c’è dubbio che il suo modo di suonare (a meno di sbrodolamenti eccessivi) sia a dir poco geniale. Anche “Down The Hole” parte su suoni campionati poi ruba il ritmo a “I’m on Fire”, non risulta memorabile nonostante la splendida voce di Patti Scialfa, l’organo di Danny Federici e il testo di una spiazzante semplicità e che (come al solito) trafigge il cuore: I got nothing but heart and sky and sunshine, the things you left behind. “Heaven’s Wall” risolleva decisamente il morale: cori Gospel, temi biblici e l’assolo di Morello anche qui superispirato. La speranza si trasforma in allegria dentro la pazza storia di Shakespeare e Einstein che si bevono una birra insieme e discutono sull’amore in “Frenkie Fell in Love”.
Discorso a parte per la stravolta “The Ghost of Tom Joad” che provoca in me sentimenti contrastanti. Ad accompagnare Springsteen c’è la voce dell’onnipresente Tom Morello. Ottimo interprete vocale, ma ora la sua chitarra è troppo. Molto più vera e sentita la versione acustica del 1995. Certo, anche ora l’odore della strada e della lotta non vengono meno. Il sali-scendi da manuale è dopotutto firmato della magica E-Street Band. Il brano più toccante è il Valzer dal sapore dylaniano “Hunter of Invisible Game”, colma di richiami religiosi, di forza, di ricerca della pace e di futuro. Strength is vanity and time is illusion, I feel you breathing, the rest is confusion: pezzo che vale il disco. Anche “The Wall”, ballata dedicata a un soldato scomparso in Vietnam, è da pelle d’oca, già solo per l’arrangiamento e per le corde vocali del Boss. Lui è proprio il capo. Il capo capace di incanalare le nostre emozioni più forti e sbattercele in faccia con quella facilità del nonno che ti racconta la storia al bordo del tuo letto. E non ha paura a parlarti di morte e distruzione, perché sa benissimo che tu saprai essere più forte di tutto questo.
Insomma dopo innumerevoli ascolti non posso certo dire che questo sia un disco inutile. Per fortuna il mio pessimismo in partenza era eccessivo. Come tutto ciò che Springsteen fa, anche questo disco risulta essere necessario. Almeno per la mia salute.