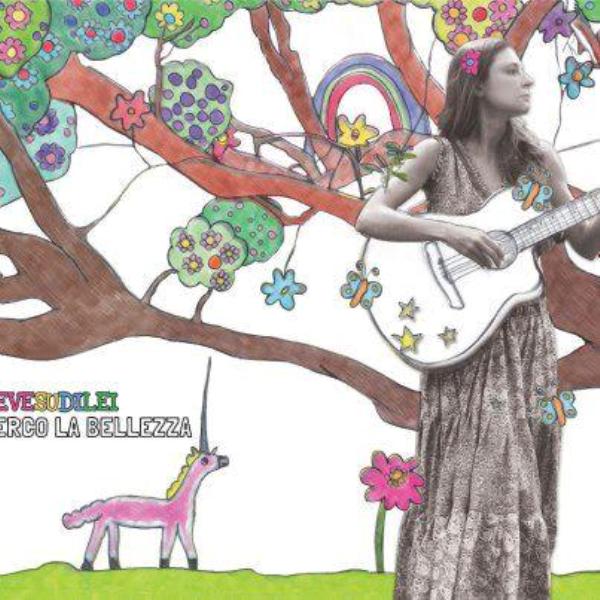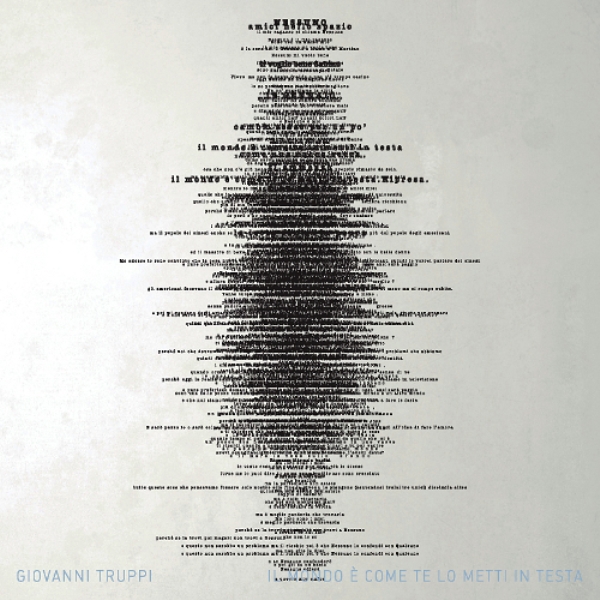Sensazioni contrastanti. Quelle che provo quando annuso l’intrigante quanto malsano odore della benzina oppure quando bagno le labbra nel ruvido sapore de whiskey o quando guardo un film di fantascienza. A mezz’aria tra l’inutile e il divertente, tra il piacere e la smorfia. Ecco e questo sentimento altalenante e di umore lunatico sbuca improvviso all’ascolto del nuovo disco dei Swell99.
Nati nel 1999 a Macerata, arrivano al loro quattordicesimo compleanno senza nessun cambio di formazione, una famiglia a loro detta e sono convinto che sia così. Il suono in effetti è compatto, unito, sicuro. Fin troppo sicuro da risultare poco intrigante. E la scelta di usare l’inglese, tranne che nella prima e nell’ultima traccia cantate in madrelingua non solo fa storcere il naso ma obiettivamente non può che far perdere omogeneità e significato ad un album registrato e prodotto in modo impeccabile. Nulla ha da invidiare alle mega produzioni statunitensi in termini di qualità sonora e di impatto, ma in tutti gli aspetti questo disco pare troppo inquadrato e privo di quel brivido, di quell’imprevedibilità che nel Rock non guasta mai.
Il singolo “Urlo” parte spavaldo con chitarroni metallusi. Hard Rock in italiano, due mondi che quasi sempre si scontrano senza provocare nulla di buono, salvo in rari casi come questo. La voce di Carlo Spinaci però non lascia grandi tracce, sebbene ben impostata e precisa rimane molto fumosa. Anche quando tenta di graffiare (“Bloody Knife”, “Real Friend”) non è acqua e non è fuoco. Molto meglio con le ballate che con i pezzi più aggressivi e vince più con la lingua italiana che con quella anglosassone. “Boot” vanta la presenza del blasonatissimo Andrea Braido, ma il fumo purtroppo rimane tanto e di carne se ne addenta poca, come anche in “Screaming to The World” dove anche l’assolo poteva essere gestito meglio, invece inciampa in freddi tecnicismi che sfociano però in una simpatica citazione di “Beat it”. Certo la botta e la carica non mancano, ma tutti questi brani sembrano essere un cannone che spara palle di gomma.
Ai pezzi più arrabbiati si alternano ballatoni più o meno articolati: si passa dal suono molto Nickelback di “Mistake”, alle melodie tortuose di “Talk” (miglior pezzo e una delle migliori interpretazioni del cantante), dalle sbavature elettroniche di “Angels” (sembra un pezzo dei Plan De Fuga) alla piatta e banalotta “Life”.
L’ancora di salvataggio ricade nell’ultima traccia (guarda caso in italiano). “Non è la fine” parte acustica per scaldarsi negli ultimi dieci secondi di puro delirio. Una pazzia. Quella che ho aspettato tutto il disco.
Spero che i ragazzi la prossima volta rompano più spesso questo orologio troppo preciso, per far cadere l’ago della bilancia verso la loro causa e rompere questi miei fastidiosissimi dissidi interni.