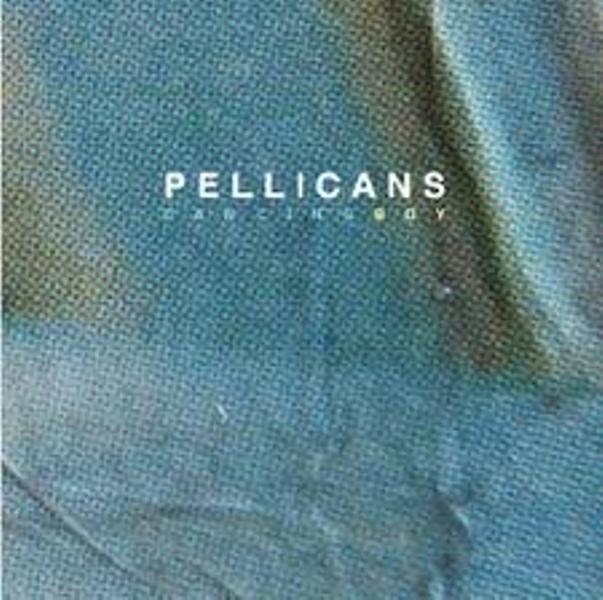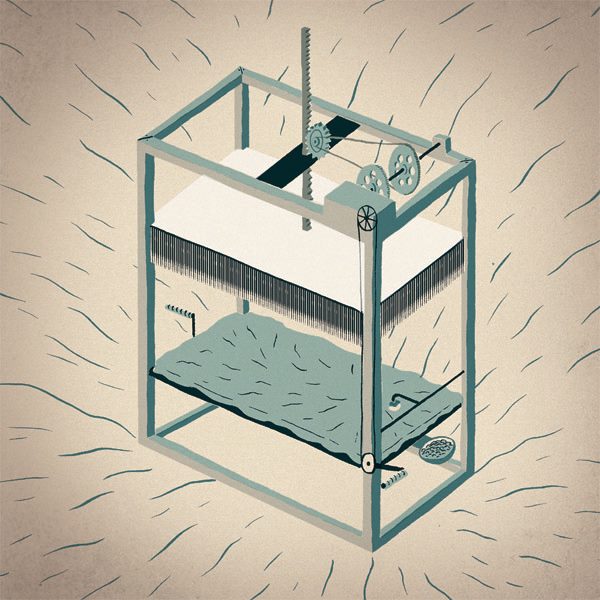Jonathan Clancy, canadese trapiantato a Bologna, è un girovago. Nel suo peregrinare ha visto tanti luoghi diversi, assorbendone le influenze culturali e musicali. Già in tour con Settlefish e A Classic Education, ha uno stile riconoscibile e allo stesso tempo riconducibile a centomila altri artisti. C’è un cantautorato alla Neil Young, tanto per cominciare, incupito da un costante rimando al Glam Punk e alla New Wave e reso moderno nel senso indie del termine. Quindi chitarrine plin plin e voci spesso e volentieri sullo sfondo del pezzo. Al primo ascolto sembra un’irritante accozzaglia di roba registrata alla perfezione. Al secondo giro del disco, piace. Vicious si apre con “Safe Around the Edge”, uno scanzonato brano Post Punk dal sapore più americano che inglese. “Miss Out These Days” è sinteticissima, a causa delle tastiere in apertura. Ha un tono molto più meditativo e riflessivo della precedente e si trasforma presto in una canzoncina super Indie tenuta in piedi solo da voce e chitarra. “Gold Diggers” è vintage: gradevole nella resa, sembra un rivisitazione della musica leggera anni 50, confluendo quasi per direttissima in “Hunting Men”, più quadrata e dritta delle precedenti, banale, se vogliamo, ma caratterizzata da un bel dialogo intessuto tra la componente ritmica e quella melodica. Il disco cambia di nuovo tono con “Slash the Night”, in cui Clancy strizza l’occhio ai Radiohead. Come un cerchio, si torna alle sonorità Glam dell’inizio in “Run Wild”, a cavallo tra la scanzonatura Punk e le atmosfere decadenti della New Wave. “Machines” è costruita in modo volutamente artefatto, con un’introduzione eterea che dà l’impressione che il brano evolverà in una certa direzione quasi Trip Hop: la sensazione iniziale viene subito disattesa però e la canzone si trasforma in una ballata veloce di stampo cantautorale, ma su un tappeto elettronico. Vicious prosegue piacevolmente, ma senza lasciare particolare traccia dietro di sé. “Avenue” si rivela da subito per essere la canzone depressa del disco: voce e chitarra creano un’atmosfera parecchio buia e malinconia su cui si muove un testo essenziale e ripetitivo, come conducesse a una sorta di trance. “Crystal Clear” è un vero e proprio tributo agli anni ’80, mentre “Zenith Diamond” è puro Punk. “Castle Sand Ambient” è la traccia che più mi ha colpito: qui le sperimentazioni si esasperano e le iniziali sonorità acustiche si espandono a macchia d’olio tra riverbero e noise, elegantemente dosati, come se si applicasse alla lettera la lezione dei Sonic Youth. Il disco poteva finire qui, ma Clancy si gioca un’ultima traccia (a mio avviso sbagliando): è la debolissima “Progress”, caratterizzata da un ritornello ben poco incisivo e pregevole forse per la sonorità Garage inglese che appare per la prima volta in questo lavoro discografico. Nel complesso è un disco che si sente, ma molto probabilmente non si compra. Si scarica, ma si ascolta una volta e si cestina per non occupare spazio nell’hard disk. Ben fatto, indubbiamente, ma incapace di aggiungere nulla di particolare a quanto è già stato detto in musica. Almeno negli ultimi quarant’anni.
Marialuisa Ferraro Author
Múm – Smilewound
Il panorama musicale islandese, mai come negli ultimi anni, ha attirato così tanto l’attenzione su di sé. Sulla scia dei successi internazionali di Björk prima e di Sigur Rós dopo, sono emersi band della forza di Amiina, Agent Fresco, FM Belfast, Of Monsters And Men e i Múm. Pur con declinazioni molto diverse in ogni esito, la formula che sta alla base delle composizioni di questi artisti sembra essere sempre la medesima: una commistione di Pop, musica colta, folklore, elettronica, ciascuna in percentuale diversa a creare un panorama musicale variegatissimo ma anche immediatamente collocabile sul piano culturale-geografico.
Uscito il 6 settembre scorso, Smilewound, l’ultimo disco dei Múm, sembra essere una summa di tutte le precedenti esperienze della band. Il disco si apre col singolo “Tootwheels”, un brano dal sapore particolarmente trip-hop, con un contrappunto di archi pizzicati e pianoforte che lascia lo spazio a sonorità elettroniche da carillon. “Underwater Snow” è una ballad con un’introduzione pianistica alla Yann Tiersen e il cantanto alla Julia Stone (o Emiliana Torrini, se vogliamo pescare fra i connazionali della band). Una rivisitazione degli artifici elettronici anni 80 sembra essere la base di “When Girls Collide” (come della successiva “Candlestick”, in fondo), con un motivetto in loop ipnotico e quasi fastidioso, che però ben si amalgama con le voci spesso in deelay. “Slow Down” ricorda particolarmente Björk ed è forse la traccia più studiata e costruita, con un continuo slittamento di accenti ritmici e l’uso massiccio di rumori coloristici. “One Smile” è il brano che più si discosta dall’omogeneità stilistica del disco: la melodia principale, affidata a un metallofono, rimanda all’estremo oriente e la freddezza del timbro di questo strumento viene subito scaldata dalle chitarre e dagli archi, in un crescendo ritmico-dinamico che diventa una specie di cavalcata nervale frenata solo dalla delicatezza vocale. Per “Eternity Is the Wait Between Breaths” sembra che i Múm si siano rivolti nuovamente a Tiersen: il brano sarebbe perfetto per una sonorizzazione cinematografica, con il mix di rumori sintetici e patina vintage con cui è costruito. “The Colorful Stabwound” è probabilmente la traccia più Pop di tutte, sia per la linea melodica, ben più lineare e convenzionale, sostenuta solo dal basso che scandisce l’incalzante ritmo della batteria, sia per la costruzione strofica.
“Sweet Impression” sottolinea moltissimo la precedente impressione sulla parentela fra la voce dei Múm e le rese canore di Emiliana Torrini e Julia Stone. La mia traccia preferita, comunque, è “Time to Scream and Shout”, meravigliosamente ossimorica, visto che invece di essere urlata, l’esecuzione è placida, greve, con atmosfere trasognanti alla Himogen Heap. Piccola chicca del disco è la collaborazione per “Whistle” con Kylie Minogue che, chi l’avrebbe detto, si amalgama perfettamente col sound della band e non solo non disturba, ma conferisce addirittura un certo tocco di grazia al brano. Smilewound è un album veramente da ascoltare, un bello spaccato della produzione di una band e un gradevolissimo susseguirsi di ispirazioni e suggestioni.
Goldfrapp – Tales of Us
Incredibile. Sono tornati i Goldfrapp. Chi l’avrebbe mai detto. Proprio quando non ci si sperava più e neanche ci si pensava più, il duo pubblica Tales of Us e già dal titolo si potrebbe capire di che disco si tratta. Sicuramente un concept album, non tanto nel senso Prog del termine, quando nella profondissima omogeneità di mood, contenuti, tono e filo conduttore narrativo. Il disco si apre con “Jo”, molto cadenzata, ripetitiva, ossessiva, con un delay vocale che crea un incredibile effetto pioggia battente, perfetto per l’autunno in cui Tales of Us fa la sua apparizione. “Annabel”, nonostante l’andamento flemmatico e arpeggiato non è mai scontata: molto cinematografica, con cadenze armoniche e melodiche del tessuto strumentale che spesso e volentieri ingannano sulla loro risoluzione. La malinconia e l’inquietudine proseguono in “Drew”, apparentemente leggera con quel suo inizio da scherzo pianistico che viene subito appesantito dalle sferzate tonali minori. “Ulla” è delicata e sensuale, mentre “Alvar” è un brano onirico e senza tempo, a cavallo tra la ballata medievale e le sonorità Folk nord-europee. Forse l’unico brano del disco a tradire sinceramente una nota positiva. Non mancano neppure gli anni 90, che in “Thea” acquistano quasi un gusto vintage. Purtroppo arrivati a questo punto ci si è un po’ stufati. Il cantato è complessivamente monocorde. L’omogeneità di cui parlavo prima e che, per certi aspetti, potrebbe essere un dato incredibilmente positivo sul piano compositivo e stilistico, finisce per annoiare l’ascoltatore almeno: finisce per annoiare me e ci si rende conto che Tales of Us potrebbe essere perfetto a piccole dosi, a sezioni interrotte e usate come soundtrack per qualche film, ma non certo per un ascolto da cima a fondo di un full-length. Perfetta a scopo cinematografico sarebbe proprio la “Simone” che passa quasi inosservata, così come la fumosa “Stranger”, che pare arrivare direttamente dagli anni 50, perfettamente identica per toni a tutti i brani precedenti ma forse con quel tanto appeal che basta a renderla più catchy. “Laurel” vive della luce riflessa della precedente, mentre con “Clay” si ritorna a sonorità vagamente più Folk: la chiusura è fresca, positiva, inaspettata. Forse un messaggio di speranza? Forse la fine della stagione fredda che porterà alla rinascita della primavera? Chissà. Nel frattempo i Goldfrapp ci danno un disco che non è assolutamente un capolavoro, né sembra avere alcuna velleità di esserlo. É una narrazione di ciò che è (autunno, malinconia, precarietà), con un piccolo barlume finale di quella speranza che è sempre l’ultima a morire.
Pig Tails – So What
Due ragazzi di Mantova. Solo due. Niente basso, niente seconda chitarra. Un organico ridotto all’osso, col cantante che suona anche la chitarra e il batterista. Questi sono i Pig Tails, che hanno dato alla luce So What, il loro full lenght composto di dieci tracce, oscillanti tutte tra il Punk americano e il Grunge anni ’90. Energia da vendere, indubbiamente, come si intuisce già da “Spitfire”, brano modellato sulle sonorità Garage con chitarre anni ’70 e un retrogusto pop, un po’ alla White Stripes.
È con la title-track “So What”, però, che si delinea meglio lo stile del duo: un bel Punk’n’Roll graffiante, su cui si muove la linea vocale dalla timbrica chiara seppure urlata. Particolarmente interessante in questa traccia è la perizia strumentale: i due ragazzi sono davvero molto bravi anche nella ricerca timbrica. “Papercut” e “The Revolution” sono profondamente in debito con i primissimi album dei Green Day quelli delle distorsioni, dei pantaloni al ginocchio e delle scarpe da skater, non certo quella copia patinata di loro stessi che sono ora. Con l’intro di “I Promise”, invece si evidenzia un certo gusto per la dissonanza che ricorda le esperienze del Grunge dei Nirvana di Incesticide, con un cantato più trascinato che lanciato: la ballad finisce però presto per diventare un po’ noiosa e ripetitiva, meritandosi in poco tempo l’etichetta di pezzo meno riuscito del disco.
Per fortuna parte “Stonecutter II” con il suo bel riffone Seventies: il brano potrebbe non essere davvero nulla di speciale, ma gli effetti usati alla voce allontanano dall’Hard Rock tradizionale e lo stacco improvviso che muove verso il Grind rendono la canzone ulteriormente originale. Lo stesso si può dire della successiva “We Can’t Fall”, mentre con “Too Bad” si torna al classico Punk-Rock. La chitarra di “Reptiles” richiama di nuovo il Grunge, ma quello degli Alice in Chains questa volta, e il disco si chiude con un nuovo richiamo ai Green Day, con la tripartita “I’ll Be Here”.
I Pig-Tails giocano con la forma canzone, scombinando le canoniche relazioni e apparizioni delle strutture strofiche e dei ritornelli, mescolando i generi, allargando le maglie di compenetrazione degli stili. Solo sono due e sembrano tanti e hanno i numeri per poter dire qualcosa. L’impressione è che, al momento, stiano esplorando un terreno in cui già molto è stato detto così tutto suona già sentito, ma l’augurio è quello di individuare un taglio più personale, che, supportato dall’indubbia capacità tecnica, non potrà far altro che portare un po’ di fortuna.
Sigur Rós – Kveikur
Questa recensione non è assolutamente semplice. Ho dovuto ascoltare Kveikur, l’ultimo disco dei Sigur Rós, uscito praticamente un anno dopo Valtari, almeno sette volte in giorni diversi e momenti diversi, prima di potermi avvicinare al foglio di Word. E ho letto in giro cosa se ne pensasse per capire se ero io che non coglievo certe sfumature o se semplicemente tra i fans e tra gli esperti non ci fosse un po’ di sano servilismo. Come a dire: questi sono dei grandi, non possono che sfornare l’ennesimo capolavoro. “La sferzata Rock degli Islandesi”, “Dopo aver indagato il cielo eccoli che scandagliano l’inferno”. Ne ho lette veramente per ogni colore, ma ancora adesso non riesco a districarmi tra la mole di informazioni raccolta e l’impressione diretta che ne ho io all’ascolto. “Brennisteinn” semplicemente non sembra farina del loro sacco: la struttura è molto più canonica, le singole componenti (e soprattutto la batteria), sembrano prese da un qualsiasi gruppo indie-rock che non si scula nessuno o quasi. Manca quella sensazione di artificio elettronico comandato dall’uomo, quella sacralità di ogni movimento melodico a cui ci hanno abituato con i lavori precedenti. Persino la voce di Jonsi non sembra più la stessa. “Hrafntinna” è semplicemente debole e fortuna che “Ísjaki” e “Yfirborð” sembrano riportarci in un universo sonoro più noto e sicuro, per quanto il ritornello della prima suoni troppo troppo Pop. Anche “Stormur”, non fosse per una tendenza danzereccia che proprio non è da loro, potrebbe essere un bel brano, ma, davvero, sono le percussioni a essere strane in questo disco. E non ci trovo niente di terreno, non sento il tentativo di un’esplorazione del basso, dell’infernale, dell’interno, in contrapposizione ai voli pindarici ed eterei precedenti. Sento una patina Indie-Pop che stride con le mie aspettative. Solo la title-track, “Kveikur”, sembra confermare la lettura di chi sente una virata Rock nel disco. Più industrial, a dire il vero. E anche un industrial piuttosto malato e visionario. “Rafstraumur” è scontata, “Bláþráður” è sintetica, “Var”, invece, è meravigliosa, la prosecuzione ideale dell’ “Ég anda” che apriva Valtari. Ce l’hanno lasciata lì, al fondo, come la promessa di un ritorno, come a dire che questa era una prova, una parentesi, un esperimento e che torneranno. Senza farsi schiacciare dai loro stessi strumenti, senza bisogno di appigli pulsionali e scansioni ritmiche così rigide, senza dare l’impressione di essersi persi nei confini netti di strofa-ritornello.
Pellicans – Dancing Boy
Mai quanto in quest’ultimo periodo il panorama musicale sembra ispirarsi al passato. Ciclicamente ritornano in voga generi che sembravano destinati a sparire, sonorità che non si sentivano da tempo (spesso con un motivo) vengono ricercate spasmodicamente, si inseriscono strumenti che il corso della storia aveva relegato ai margini, restituendo o conferendo loro per la prima volta il ruolo del protagonista. Il Reggae è un caso a parte: insieme allo Ska e a tutte quelle forme che hanno un legame con la danza, non sono mai davvero passati di moda, ma la band di cui sto per parlarvi si riappropria in modo fedelissimo e al tempo stesso personale di un sound che avrebbe ben poco di europeo.
Arrivano da Pinerolo i Pellicans, una formazione che definisce il proprio genere Queer Reggae perché strizza spesso e volentieri l’occhio all’omosessualità, in aspra critica ai fatti di cronaca che vedono ancora la nostra penisola macchiarsi di atti di violenza dettati da ignoranza, pregiudizio e discriminazione. Dancing Boy, il loro secondo album, è prodotto da Ru Catania degli Africa Unite. Il disco apre con la title-track, “Dancing Boy” e, per me che sono piemontese, è immediato il richiamo ai primissimi Subsonica, mentre il cantato, urlato e lanciato dalla gola, richiama particolarmente quello di Bunna. Si tinge di sonorità pulp direttamente dagli anni ’70 “Vampire”, mentre la dub spadroneggia in “He Cannot Handle it” e in “But we Can Dub it”, una l’ideale prosecuzione dell’altra attraverso lo sfruttamento di un medesimo inciso melodico-ritmico. Più classica è “A Last Gaze of my Dad”, in cui i cori femminili conferiscono un sapore disco anni ’70. La chitarra acustica con cui apre “A Word up There” conferisce a brano un carattere particolarmente fresco, pop, estivo, subito bilanciato dalle atmosfere riflessive e sospese di “Shortcut Circuit”. Particolarmente riuscita, a mio avviso, soprattutto per quanto riguarda gli arrangiamenti, è “Short Dub”, una delicata ballata dub contornata da brevi interventi dello xilofono. “Turmoil” è profondamente imparentata con l’elettronica, mentre “It’s Raining” privilegia di nuovo l’elemento cinetico, sottolineato da un cantato che si libera dalla rigida scansione sillabica solo nel ritornello.
Il disco chiude con “Move on”, una sorta di esortazione, uno sprone: a ballare sì, ma soprattutto a tenere la testa alta, ad andare avanti. Non so quanta fortuna possano avere i Pellicans con questo secondo lavoro, ben realizzato, composto, meditato. Il genere è variegato e ricco di adepti e addetti: si prospetta una grande concorrenza. In bocca al lupo.
Cabeki – Una Macchina Celibe
Cabeki è compositore d’altri tempi, uno di quelli che riesce a concepire la musica anche senza il bisogno di un testo letterario che supporti il significato. I brani di questo lavoro, Una Macchina Celibe, sono tutti quadri di pura musica strumentale, che si susseguono senza soluzione di continuità in un unicum guidato solo dal programma, per usare un termine più vicino alla musica colta che a quella Pop, esplicitato nei titoli. Frasi ispirate al dadaista Alfred Jarry, con frequenti riferimenti alla tecnologia, che, a dire il vero, forniscono più suggestioni che spiegazioni. Come del resto è giusto che sia.
L’intro orchestrale e arioso di “Se Quest’Uomo Diventasse un Meccanismo”, aleatorio nella scansione temporale e impalpabile, con un rimando immediato ai Sigur Ros, lascia spazio a chitarre acustiche rese caldissime dalla percezione dello scorrimento delle dita sul manico dello strumento. “Il Necessario Ritorno” è prepotentemente cinematografico, un omaggio a Nino Rota, con uno sguardo oltralpe alle composizioni di Yann Tiersen. La terza traccia, “Verso il Ronzio Remoto”, è una delicata e didascalica composizione in cui la chitarra, ancora una volta, spadroneggia con echi della sua tradizione classica. “Di un Ingranaggio Che si Perde” arriva da lontano e sa di Medioriente, a tratti Rock, mentre sembra il Sud l’ispirazione di “Fra Elettrodi di Seta Blu” e l’estremo oriente invece pare guidare idealmente “Negazioni che si negano”, seppure i cori ariosi che seguono immediatamente l’introduzione, suggeriscano ispirazioni carioca. Cabeki ci accompagna in un viaggio che è geograficamente orientato e che lascia trapelare tutta la gamma emozionale che il cammino porta con sé, come nel caso del tono riflessivo di “Alla Banalità di un Valore” o dello smarrimento psichedelico -e molto didascalico considerato il titolo- di “La Bellezza Pura e Sterile Della Semplice Ruota”. “La Diapositiva si Ricorda” richiama i Beirut e i Mogwai, mentre “L’Ultimo Degli Uomini” allontana nuovamente la percezione ritmica per concentrarsi tutta sulla melodia, strizzando l’occhio con veemenza a Ennio Morricone. Un disco per tutti, elegante, raffinato e mai scontato, veramente da sentire.
Craxi – Dentro il Battimento Delle Rondini
Niente a che vedere col politico, i Craxi sono il genuino progetto parallelo di musicisti noti del panorama alternative nostrano, considerando che stiamo parlando del vocalist Alessandro Fiori dei Mariposa, di Andrea Belfi, ex-Rosolina Mar e attivo negli Hobocombo (batteria), di Luca Cavina dei Calibro 35 e Zeus! (basso), di Enrico Gabrielli, ex-Afterhours e ora Calibro 35, Der Maurer, Mariposa (chitarra). Un progetto ambizioso, dunque, che si apre con “Rosario”, brano caratterizzato da una lunghissima introduzione noise alla Marlene Kuntz che apre lentamente, tenendo l’ascoltatore in tensione, in attesa dell’esplosione (che di fatto, non arriva), mentre la voce, sforzata e declamata, più che cantata, arriva direttamente dalla gola. Non sono depressi, non sono incazzati, ma hanno quell’agitata impazienza new wave che si avverte nelle sonorità cupe di “E tu Non ci Sei”, dove gli sfasamenti tonici e l’accompagnamento ipnotico catturano e soffocano.
Il basso spadroneggia in “I Diari Del Kamikaze”, mentre il panorama industrial sembra essere il faro di “Drive In”, con il suono penetrante (un fischio, una sirena, una sveglia insopportabile di una mattina di hangover) che caratterizza intro e interludio. La lezione degli Afterhours, invece, si sente in “Le Ali di Alì”, mentre in “Si Appressa la Morte, Non ci è Dato Sapere” sono le avanguardia la vera ispirazione: una matrice quasi Folk, ma vagamente riconoscibile, alterata, distorta, digerita elettronicamente per un risultato visionario e psichedelico, poco gradevole all’ascolto, forse, ma molto pregevole sul piano sperimentale-compositivo. “Santa Brigida” è la più ritmata e coinvolgente fisicamente, mentre “Se me lo Chiedi Dolcemente” si pone a cavallo tra le sperimentazioni internazionali hippie del Rock anni ’60-’70 e un sapore intellettualoide hipster di ben più recente foggia: il trattamento melodico-timbrico richiama l’oriente mistico indiano, mentre la voce declamata riporta alle letture degli scrittori della Beat Generation. La title-track, “Dentro il Battimento Delle Rondini”, invece, è un visionario testo decadente alla Teatro Degli Orrori.L’impressione generale è che la band incarni bene tutto ciò che non vorremmo essere ma siamo, tutto lo squallore di una generazione precaria, corrotta dai media, costretta a guardare indietro anziché avanti. Un moto di ribellione, però, quasi nel tentativo di restituire speranza e vigore, viene dato da “Sono il Mio Passeggero”, dove finalmente la voce prende il volo in un recitato con urletti dal profilo melodico incerto, che, ancora una volta, mostrano l’implicita cupa inquietudine che i Craxi ci raccontano. Il disco chiude con “Le Mostre di Pittura”, una critica ben poco velata alla società finto-intellettuale odierna, ironicamente arrangiata con violini e battiti di mani che decorano il tappeto Grunge aspro di sottofondo.
I Craxi non sono piacevoli e non vogliono esserlo, perfettamente inseriti in quella nicchia di musicisti italiani che non hanno intenzione né di divertire, né di sensibilizzare, ma solo di mostrare tutto il loro profondo disgusto per la situazione vigente. Tecnicamente bravissimi, assolutamente non orecchiabili, new wave quanto basta per soddisfare i fautori del ritorno in auge del genere, avranno sicuramente fortuna. A me non hanno fatto impazzire, ma de gustibus.
L’Orso – S/t
Sta decisamente capitando qualcosa. O c’è stata un’inversione di tendenza nella mia mala sorte postale, perciò continuo a ricevere solo album che si lasciano ascoltare con piacere, o -e mi auguro con tutto il cuore che sia questa seconda opzione- il panorama musicale nostrano si sta risvegliando da un letargo artistico e creativo che possiamo sperare di lasciarci presto alle spalle. Se così fosse, bisognerebbe solo augurarsi che qualcuno investa in questi progetti emergenti. Ma, comunque, veniamo a noi. L’Orso è il disco d’esordio dell’omonima band milanese. Un progetto Folk che prende a larghe braccia dai precedenti illustri del genere, in cui la band si muove senza particolari innovazioni o tocchi individuali, ma con una cura, una precisione e una disinvoltura davvero pregevoli. “Ottobre Come Settembre”, in apertura, chiarifica subito la cifra stilistica della formazione: le sonorità acustiche e la naturalezza, quasi dilettantistica, con cui la voce viene lanciata nel fraseggio, ricordano i Beirut, così come accade durante l’ascolto di “Tornando a Casa”, caratterizzata proprio da quella tendenza alla de-localizzazione geografica del Folk internazionale, dove si perdono gli agganci percettivi delle proprie radici, per affondare invece in un terreno timbrico più ampio che universalizza il messaggio. L’Orso, però, va oltre e non affida solo ai timbri la connotazione dei propri brani: il cantato italiano è un intelligente costrutto per immagini giustapposte che raramente si concede rime banali o sfalsamenti di accento: in “Il Tempo Passa Per Noi” e in “I Nostri Decenni” le liriche conferiscono ai testi una freschezza Pop che maschera una riflessione sull’individuo inserito nella nostra società moderna. E, infatti, è a questo punto del disco che ci si rende conto che i ragazzi non ci stanno offrendo solo un album gradevole, ma anche un lavoro da meditare, dove i protagonisti sono una Milano che inghiotte i singoli, il tempo che scorre e il necessario dovere di invecchiare e crescere, con una nostalgia per il passato della propria adolescenza che nulla però ha a che vedere con una certa attitudine emo alla Dari, ma viene vissuto e raccontato con tutta la forza di chi realizza il trauma per la chiusura di un capitolo della propria vita e guarda incerto a un futuro in cui tutti si aspettano che sia in grado di camminare da solo. Ed è di questo che parlano, con declinazioni diverse, “Con i Chilometri Contro”, “Certi Periodi Storici”, “La Meglio Gioventù”, “Acne Giovanile” e “Baci Dalla Provincia”.
Oscillazioni continue tra il Pop più leggero d’ispirazione belcantistica nostrana – per quanto il cantante non brilli per virtuosismo- e Beirut, Tiersen, Perturbazione. La traccia meno riuscita è, a mio avviso, “James Van Der Beek”, forse a causa di un inserimento rap tanto inaspettato quanto immotivato e piuttosto sterile a livello comunicativo. “Invitami Per un té”, invece, è il brano più complesso, che nasconde più chiavi di interpretazione: su un tappeto ritmico leggermente sambato e sull’immediatamente chiarificata critica alle relazioni interpersonali nei social network, si inserisce una riflessione sull’artista-compositore-scrittore, i suoi blocchi, le sue difficoltà. Un disco omogeneo, netto, preciso, di chi ha intrapreso con grande trasparenza e genuinità una strada, consapevole delle proprie capacità (cosa non da tutti): se questo è solo l’inizio…
Granturismo – Caulonia Limbo Ya Ya
Ci sono voluti tre anni dall’esordio discografico, Il Tempo di Una Danza, perché i Granturismo tornassero sul mercato con un disco nuovo. Caulonia Limbo Ya Ya è un crogiolo di generi, ispirazioni, commistioni. C’è l’occidente precario, afflitto, abbattuto e introspettivo, ma c’è sopratutto la leggerezza, il calore, la giovialità del sud, dei Tropici, delle danze istintive e pulsionali. Un mix di generi musicali che va dal Punk al Mambo, dal Cantautorato all’Indie Rock, dal Rock’n’Roll alla Bossa Nova. “Me ne Vado al Mare” apre l’album con una serie di rime e distorsioni controllate che si lasciano andare in un bel riff incisivo che riprende il tema del ritornello, mentre “Vieni a Dormire Con me” è una deliziosa canzone dal sapore tropicale, fresca per sonorità e termini impiegati, dal ritmo cadenzato e ironicamente scanzonato. Un bel gioco di voci e cori caratterizza invece “Meraviglioso Errore”, con un arpeggio delicato e atmosfere a tratti fumose, pulp, seducenti. Quattro mele hai lasciato nel frigo è la frase chiave di “Domenica”, in cui il tema dell’amato abbandonato è pretesto per comporre liriche pungenti e sarcastiche, con numerose citazioni Pop e rime baciate. Ma è da “Canzone di Parole” che mi sono resa conto che avevo a che fare con un trio davvero geniale, sia per la capacità di giostrare la forma-canzone, sia per la cura naturalissima degli arrangiamenti: il brano è fondamentalmente un Rock’n’Roll, a tratti debitore del Surf dei Beach Boys, con un bridge lento e sospeso alla Procol Harum e una lallazione nonsense profondamente percussiva. La costruzione del testo è particolarmente cantautorale, ma il vomito-elenco di parole prese dall’universo culturale Pop la rende sperimentale, come confermato dalla chiusura Noise, assolutamente inaspettata. “Inno della Repubblica di Caulonia” è uno strumentale di andamento mosso e sonorità latine, ripreso alla metà della velocità, o quasi, in chiusura del disco. Ed è sempre il Sud a farla da padrone in “Può Darsi Sia l’Autunno”: non c’è il Sud delle migrazioni, delle fronti sudate per il lavoro, dell’arsura che attanaglia la mente, ma solo quello dell’acqua fresca, dei frutti esotici dai succhi dissetanti. La bravura tecnico-strumentale dei Granturismo emerge in “Distanze”, con il suo intro alla Kings of Convenience, il cui stile viene ripreso anche in “Dubbi Dubbi”, una Bossa Nova che ricorda molto la “Misread” dei norvegesi. E se vi foste convinti di aver di fronte un terzetto di burloni, “Non Essere Triste” completerà il quadro della maturità di questi ragazzi, capaci anche di scrivere una ballata riflessiva, dondolante, esistenzialista.
Che dire? Io 5 su 5, prima d’ora, non l’ho dato mai…
Officina della Camomilla – Senontipiacefalostesso
Quando ti sei fatta la fama di smonta-cd a forza di rifilare dei 2 e invece inizi a ricevere dischi veramente pregevoli, aspetti l’inversione di tendenza da un momento all’altro. Non è ancora arrivata l’ora di ricominciare a sbuffare e storcere il naso e faticare per arrivare al fondo di un album, però, perché mi arriva questo irriverentissimo Senontipiacefalostesso, creatura dei milanesi Officina della Camomilla. Un ascolto solo e già li si ama per la loro abilità nel mal celare volontariamente tutta la profondità di cui sono capaci. Amore, disillusione, solitudine metropolitana e quella costante sensazione di asfissia dell’uomo soffocato da se stesso, sia psicologicamente, sia concretamente, tra l’architettura urbana che non ha nulla a misura d’uomo, questi ragazzi ci offrono canzoni in cui si parla di una bruttezza preconfezionata, venduta e servita come bellezza. Fanno i punk e piaceranno anche agli hipster. Il disco si apre con sonorità alla Strokes, con echi di quei gloriosi Sixties che per noi hanno un sapore così fresco e pop, che tanto emerge in “Dei Graffiti al Mercato Comunale” e in “Morte Per Colazione” e il suo eco geghegé e la frase, che colpisce per gli accostamenti, «Nell’azzurro dei cazzi miei». La scanzonatura prosegue in “La Tua Ragazza Non Ascolta i Beat Happening” (con quel «Siamo pieni di droga la la la la» che tradisce una sofferenza sociale profonda, affrontata con un’ironia graffiante resa ancora più densa dalla lallazione non sense, che invece che alleggerire il tutto fa scuotere la testa). “Agata Brioche” è quasi Folk, con un certo gusto francese per le sonorità, che si riscontra anche in “Un Fiore Per Coltello”, con molti riferimenti testuali pop (da Monica Vitti al Walkman, dal frigorifero ai quadri di piante) e autoreferenziali, in cui l’autore dice di ascoltare musica orrenda, di ribaltare i poeti e di non avere voglia di vedere nessuno, in una romantica ricerca di rifugio nella solitudine. “Città Mostro di Vestiti” è, invece, un divertissement con un’introduzione pianistica che ricalca un carillon, mentre in “Lulù Devi Studiare Marc Augé” la de-identificazione dell’individuo moderno è richiamata dall’antropologo maestro del Nonluogo, che distingue spazi realizzati intorno all’uomo e spazi, al contrario, che non hanno nessun riferimento storico, nessuna funzione aggregativa, nessuna particolare identità. Torna il rock’n’roll anni ’60 in “Le Mie Pareti Fluorescenti di Nord-Africa”, che cede di tanto in tanto il passo a una marcia, in stile Beatles. Il degrado urbano è il protagonista di “La Provincia Non è Bella da Fotografare”, mentre squisitamente Punk adolescenziale è “Ho Fatto Esplodere il Mio Condominio”. “Pegaso Disco Bar” inizia con uno sfruttamento del rumore alla Sonic Youth che cede il passo in breve a sonorità liquide, con un cambio di ritmo che diventa pesante e dilatato. “Ti Porterò a Cena Sul Braccio di Una Ruspa” ironizza sull’amore, sui ruoli, sulle convenzioni sociali ne rapporti di coppia, mentre la traccia di chiusura “Senontipiacefalostesso”, che nulla ha a che vedere col titolo, è una ballata tradizionale con tanto di archi, una sorta di delicata confessione sentimentale («Ti ho sempre chiamata, senza sapere il tuo nome»). Nessun lamento sterile, nessun compianto, nessuna autocommiserazione. In tutto il kitsch che viene descritto nel disco, in tutta la disillusione che porta a desiderare la solitudine in cui in fondo già si è, si sente una voglia di vivere con un’energia genuina e un’attitudine Punk che non cede mai, però, alla volgarità gratuita, alla provocazione tout court come negli ultimi esiti nostrani del genere (e mi riferisco al Management del Dolore Post-Operatorio). Ascoltatevi questi Officina della Camomilla perchè meritano davvero un po’ del vostro tempo.