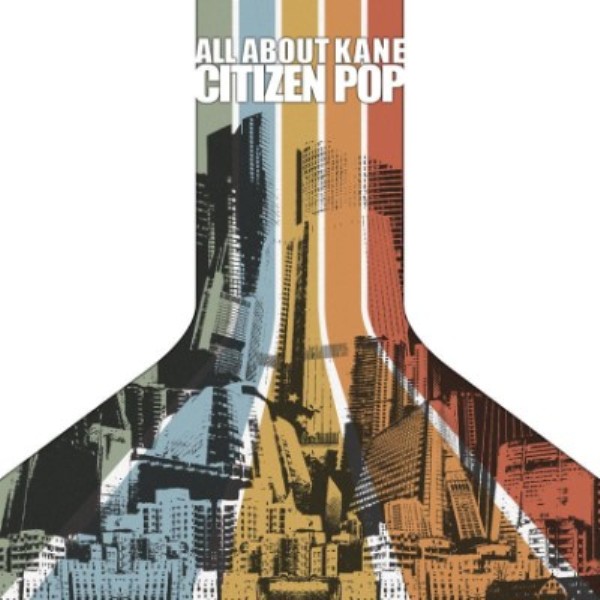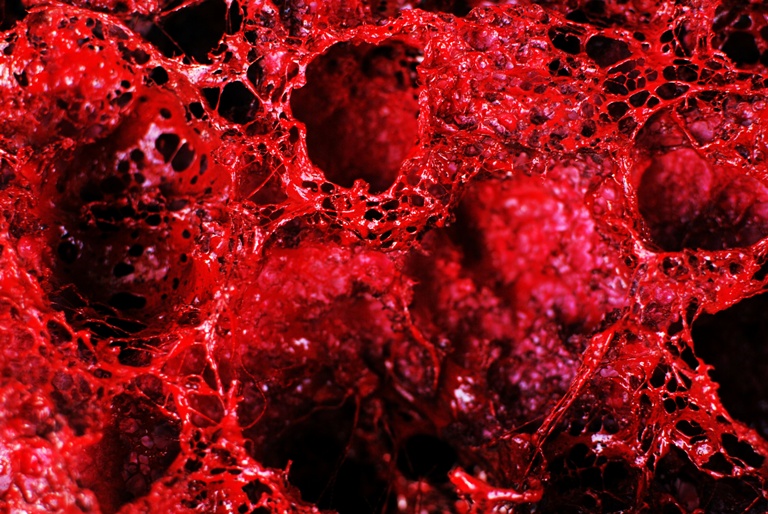Vi ricordate quando vi abbiamo detto che Rockambula sarebbe andata in vacanza? In realtà non era proprio vero. Perché la festa di Goriano, di cui vi racconto oggi, è un po’ la nostra festa, di Rockambula, l’unica webzine che non riposa neanche quando dorme. Non sarà il MiAmi e noi non saremo RockIt (la cosa non è tanto un male visto che i “piccoli” hanno meno da perdere e tanto da dire) ma resta una festa da urlo, da veri amanti del Rock, quello brutto, sporco, cattivo, sudato e pure con la panza, visto il menù della serata. Vi avverto subito che se noterete un costante, inesorabile ed esponenzialmente crescente appannamento nelle mie parole, non è per la stanchezza di una giornata davanti al pc ma la precisa iperrealista rappresentazione dell’evoluzione alcolemica subita nell’arco di quella giornata, cosi indimenticabile che mi sono scordato quasi tutto. Ma farò uno sforzo.
Era il ventotto di Luglio e la personale quarta edizione del Goriano DiVino inizia nel mio paese, in un pomeriggio spettacolare. Molto caldo e un paio di birrette e quattro chiacchiere ci aiutano a resistere fino a quando calerà il sole. Si parte verso Goriano (patria del nostro Riccardo) e per una mezz’ora di viaggio tra le splendide montagne dell’Appennino Abruzzese, ci fanno compagnia curve da brividi, paesaggi mozzafiato e qualche canzone, di quella gradevole spazzatura italiana. Finalmente siamo in cima (per modo di dire, visto che in fondo siamo solo a 720 metri slm, a sud della Valle Subequana) e ad aspettarci non c’è il fresco tanto desiderato ma un borgo bellissimo e tanta allegria. Quella dei bimbi che giocano nel prato che costeggia la piazza dove ci saranno i concerti e quella dei tantissimi ragazzi dello staff che smuovono il culo per dare vita a questo paesino di seicento abitanti. La festa ha inizio.
Il palchetto di Rockambula è ormai pronto, Cd introvabili, spillette, maglie, figurini, tutto a un prezzo simbolico. Vicino al palco è allestita la mostra vivente di Luca “BaraBBa” Colaiacovo, artista di strada pratolano che si mette presto all’opera per mostrarci la nuova strada intrapresa verso la Spray Paint. Un altro artista lo affianca presto. Viene da Pescara, si chiama Massimo Desiato alias Teschio Urbano e potete leggere una sua intervista proprio su Rockambula (https://www.rockambula.com/anche-l%E2%80%99-arte-vuole-la-sua-parte-con-massimo-desiato-alias-teschio-urbano/). Arte oscura, tenebrosa che qualche ora più tardi incontrerà i paesaggi solari di BaraBBa in un’opera a due realizzata in tempo reale.
Il pomeriggio passa svelto, tra qualche saluto ai tanti amici, le solite birre, uno sguardo alle opere esposte e un altro al palco che prende vita. Vicino allo stand di Rockambula è stato piazzato il percorso enogastronomico. Genialata a metà tra il sarcastico, l’ironico e il serio. Il tutto è presentato dai ragazzi come un iter fatto di una decina di vini tutti della zona, ai quali non è assegnata un’etichetta, rigorosamente di produzione propria, e soprattutto spesso pessimi. Ci scherzano anche loro, a volte consigliando di saltare un certo bicchiere perché “benzina” o sfidandoci a berne un altro sorso. Si mangiano stuzzichini di mortadella e formaggio, durante il percorso e ci si diverte tanto, anche a compilare la lista dei vini, dove andiamo a indicare un voto e un giudizio (totalmente libero e giù con gli “aceto, imbevibile, devastante ecc…). Qualcuno capisce lo spirito e si atteggia con aria poco credibile a sommelier di grande esperienza. Nel complesso, una trovata che di certo non apprezzeranno i “grandi intenditori di vino” ma che, in una festa come questa non certo per gente snob, ci sta da Dio. Ed io alla fine, come gli altri, di percorsi me ne sparo più d’uno. È tempo di cena e il menù, quest’anno, presenta una sorpresa. Oltre ai soliti arrosticini c’è la mortadella arrosto, che si dimostrerà ottima oltre ogni aspettativa. Ovviamente annaffiamo il tutto con birra e vino, stavolta in bottiglia e le cose cominciano a decollare. Si avvicina l’ora della musica.
La prima band a salire sul palco è Christine Plays Viola http://www.christineplaysviola.it/. Probabilmente la migliore band della Valle Peligna è composta da Massimo Ciampani (voce), da Teramo, Fabrizio Giampietro (chitarra) da Sulmona (AQ), Desio Presutti (basso) e Daniele Palombizio (Batteria). Come al solito la loro esibizione è pressoché impeccabile. Unione di tecnica e teatralità, influenze multiple che confluiscono in una dark wave mista a elettronica. Un chitarrista da far invidia a Glen Johnson, un bassista storico della scena Rock e Punk pratolana, un cantante che a vederlo ti aspetteresti leader di una band Thrash Metal e un batterista da paura, un ragazzone enorme, che pur potendo non si dà delle arie neanche quando scoreggia (citando Otello). La band è probabilmente più adatta a scenografie cupe e tetre ma la loro qualità esce sempre allo scoperto. Non sbagliano un colpo. Istrionismo e spiritualità, abilità e pathos, passione e melodie nere come il vento di notte. Questo sono i Christine Plays Viola, questo sono stati. Ancora una volta i migliori, anche se in troppi non se ne accorgono (https://www.rockambula.com/christine-plays-viola/).
Ora tocca alle donne. Le scatenate Wide Hips 69 http://www.facebook.com/pages/-Wide-Hips-69-/190213751014648 da Teramo più il batterista Luciano “HalfSpoon”. Loro sono Daniela “Locomotion” al basso, Lorena “SlimHips” alla chitarra e la mitica “Cristina TitsQuake” alle urla. Una botta di energia che non ti aspetti, Garage Rock allo stato puro. E come faccio a non mettermi sotto il palco a saltare e urlare con loro come una squallida groupie? Obbligato. Ci voleva. Una botta di energia. Eccezionale il contrasto musicale tra le due prime band salite sul palco. Ora solo Albano potrebbe scombussolare ancor più le mie cervella in ebollizione.
Invece si avvicinano strani tipi di una certa età. Vecchi poliziotti in borghese a una festa di svitati? I pazzi del paese? Tossici in gita? Chi saranno mai. Lo scopro presto. Sono la storia del Punk Hardcore abruzzese, Digos Goat (sempre zona teramano) nati nel 1984, hanno spaccato palchi per otto anni prima di sciogliersi per poi tornare insieme dopo venti anni. Avete capito più che bene. Avete capito che gente c’era sul palco? Tra l’altro dopo “Il Delirio” e “Testimoni Del Silenzio” quest’anno hanno anche inciso il nuovo lavoro in studio “Stille” che vi consiglio di non perdere (https://www.rockambula.com/digos-goat-stille/). Ormai è tutto pronto, s’inizia a fare hardcore sul serio e mi scaravento sul palco a pogare, barcollare, fare casino, urlare, invitando gli altri a fare altrettanto e qualcuno sale con me. Non ricordo quanto è durato ma sono arrivato alla fine sfinito. Come loro del resto. Ma cazzo se n’è valsa la pena. Senza sprecare troppe parole, senza fare troppo gli alternativi, Marko Sigismondi (voce), Gix Guerrieri (chitarra), Ghevara Paolone (batteria) e Raimondo D’Orazio (basso) ci hanno ricordato cosa significa suonare hardcore, ci hanno insegnato cosa doveva essere il punk di venti, trent’anni fa e ci hanno dato una lezione di vita. Spettacolo.
La parte live è finita. E’ ora di vagare tra la gente, fare conoscenze e condividere un bicchiere di vino. L’atmosfera è assolutamente rilassata e festosa oltre che brilla come ogni Goriano DiVino deve essere. Ci spostiamo davanti allo stand alcolico e qui cala il sipario della nostra mente. Cominciamo a cantare cori da stadio, pro Pescara, anti Sulmona, per Pratola o contro Chieti. Di tutto, basta che si riesca a sfogare tutta la carica e l’adrenalina accumulata.
Ora è proprio tardi e i ricordi diventano surreali. I più sobri, i temerari e gli incoscienti ripartono giù per i tornanti. Alcuni vanno a dormire al dormitorio che è messo a disposizione dal comune per le band e chiunque non avesse dove restare (trovata da standing ovation). Ma la festa continua. Si sale al bosco, dove Salvatore Carducci alias Dr Greenthumb ha attrezzato tutto per una notte all’insegna del Dj set più devastante. Alberi, musica, notte nera e birra.
E la notte a Goriano, la notte di Rockambula, la notte dei Christine, dei Digos Goat, Di Teschio Urbano, delle Wide Hips 69, di Barabba e del Dottore, la notte del vino e della musica, dei ragazzi e dell’Abruzzo. La nostra notte, la notte del Goriano DiVino contro gli assassini della giovinezza e della follia, della vita, sembra non finire mai e almeno fino a quando non apriamo gli occhi continuiamo a sognare l’irresponsabile e negativo desiderio di, almeno, non essere uguale a loro.