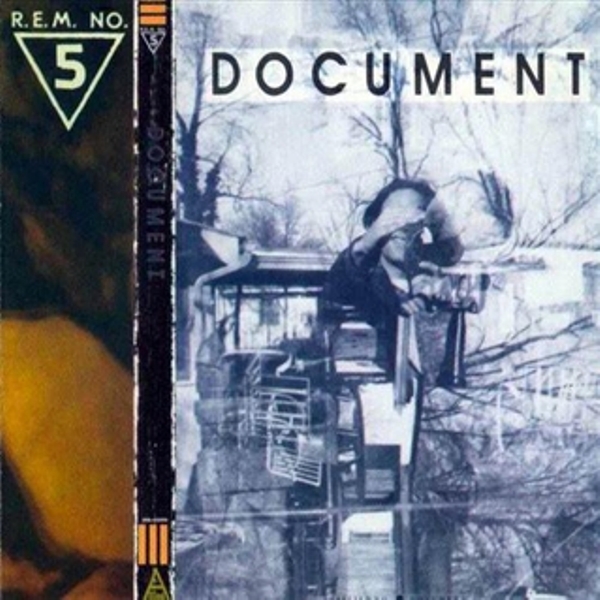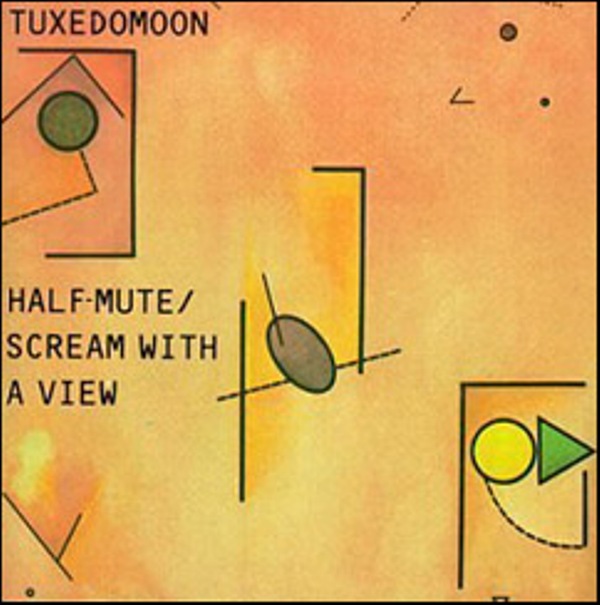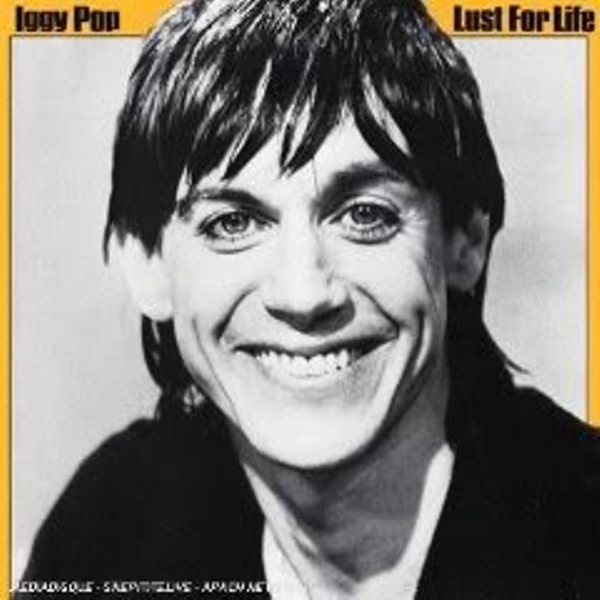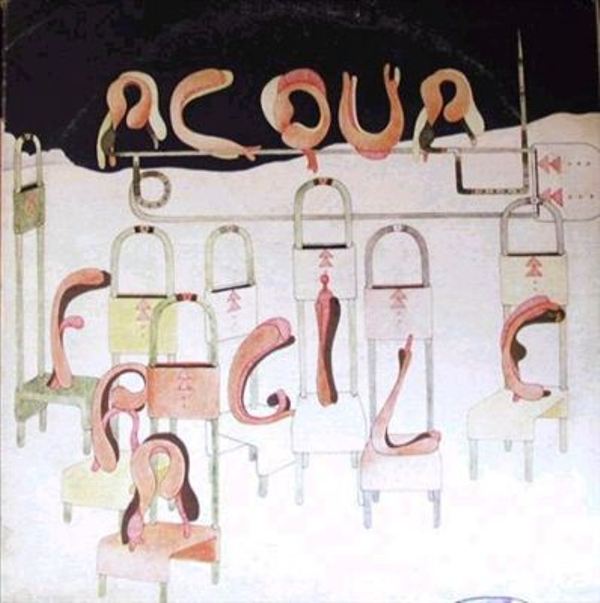I REM, band capitanata da Stipe, ha già forzato i pareri critici del popolo underground americano, è riconosciuta in tutti gli stati ove ci sia un ballroom per suonare rock, in ogni piazzale di un college dove poter giostrare in santa pace accordi e melodie elettriche, ma si rimaneva comunque nel seminterrato della notorietà, ancora aggrappati al mondo degli outsider, e occorreva un qualcosa per fare il grande salto, il passo grande verso l’uscio “di casa”.
Prova e riprova arrivano ad incidere dischi di ottimo livello, ma sempre lì ad un centimetro dal tutto; l’occasione gli viene data dal produttore Scott Litt, e nasce “Document” il quinto di carriera e picco discografico che li catapulta immediatamente nel giro che conta, un disco che non suona solamente ma parla di politica e di diritti civili, un registrato che fece e fa spessore culturale oltre ogni limite di ascolto, e che tutt’ora rimane il manifesto “programmatico” dei REM per tutti gli anni a venire. Canzoni che rimangono appese alla storia del rockerama mondiale, canzoni destinate a cambiare per sempre gli obiettivi sonori dell’accademia alternativa di milioni di altre band e che praticano la libertà ed i sogni di generazioni che vogliono finalmente esibire i loro ideali di autodeterminazione.
Michael Stipe alla voce, Peter Buck chitarra, Mike Mills basso e Bill Verry alla batteria, sono un “quadrilatero” di poesia che si aggancia immediatamente ai refrain, quelle quasi filastrocche che si attaccano all’orecchio come un tic e che non se ne vanno più, e con queste nove tracce realizzano un disco il cui suono diventa il marchio e il modo di dire “suono alla REM”, il simbolo universale di una classe unica e mai contestata; pop alternativo e nomade, rock espansivo e quadrato, tutte caratteristiche che porterà la band di Athens (Georgia) a vendere cifre da capogiro, ma non si montano la testa, riescono a rimanere loro stessi convincendo chiunque con quel mood di semplicità che li contraddistingue. Document è un disco di rinnovamento, un distacco sonoro dai precedenti lavori che apre un nuovo corso ed una nuova “inquietudine” per tanti rivali e per altrettanti detrattori, ma la storia cancella tutto e rimangono nell’aria gli inni contro i privilegi e le assurdità “Finest Worksong”, “Welcome to the occupation”, la rivisitazione del brano degli Wire “Strange”, oppure chi non ha mai versato una lacrima ascoltando “Fireplace” o cantato a squarciagola sudando e gioendo a mille con “It’s the End of the world as we know (and I feel fine)” e “The one I love”? Nessuno può dire di no.
Articoli
“Diamanti Vintage” Rem – Document
“Diamanti Vintage” Tuxedomoon – Half-mute / Scream with a view
Le metamorfosi creative oramai stanno impazzendo, tutte le pieghe della sperimentazione danno i numeri e scenografie neuroniche al limite dell’assurdo; dalla Bay Area Californiana, dopo aver imperversato in certi frangenti new-vawe, i Tuxedomoon cambiano letteralmente rotta sonora e si costituiscono parte integrante di un delirio immaginifico che pur conservando certi sciami canterburyani brandisce aspetti pazzoidi e acidi da lasciare il segno nella discografia americana di allora. “Half-mute/Scream with a view” è l’emblema di questo cambiamento, un bel calderone di free-jazz, elettronica-funky, tastiere enfatiche, visioni di luoghi lontani e declinazioni drogate, un disco che farà scuola e che nella sua materialità mutante, inciderà fortemente sull’allure intellettuale di quegli anni Ottanta sempre in cerca di cose da strapazzare e rendere poi in musica.
I Tuxedomoon, oramai calibrati nella formazione a tre (Steven Brown sax, Peter Principle basso e Blaine L. Reinenger al violino), producono una specie di avanguardia sonora che tra colto e ispirazioni galattiche, assume l’intraprendenza della distanza come fattore basilare della loro mira musicale, prendono in prestito arie cinematiche e le trasferiscono su letterature antiche, viaggi a ritroso nella storia di popoli e culture fino a tratteggiarne sensazioni, colori e velleità in una tracklist mirabolante ai confini della schizofrenia intelligente; con i Pere Ubu e Television ancora conservati nel profondo dell’animo stravagante, il trio americano si concerta su giacigli sonori che concedono volentieri licenze ed improvvisazioni cosmiche “Nazca”, “59 T 1”, odori e rimasugli di vawe che si distinguono in “Volo vivace”, sensazioni diaboliche che scandiscono il tempo di “Tritone (Music Diablo)” oppure la movenza distrofica dell’eccezionale “Loneliness” quattro minuti di robotica ossessa che tramanda tutte le posture di un Captain Beefheart all’apice della carriera.
Un disco istintivo, vero, matto quanto ci pare ma stupendo nella sua estensione distorta, un viaggio che si fa film o un film di un viaggio in quella parte di inizio degli anni Ottanta dove nulla era dato per scontato e tutto era dato oramai per perso, fintanto che la rivoluzione Tuxedomoon arrivò per dare un “contegno storto” che raddrizzò un milligrammo di storia rock & affini.
“Diamanti Vintage” Iggy Pop – Lust for life
E’ proprio vero, nei moment peggiori della vita, avere nel circondario un amico che ti può tendere più che una mano oltre che far comodo, è un miracolo dal quale devi rendere conto finche i tuoi piedi calcheranno vivi questa terra, e l’Iguana Iggy se ne ricorderà per tutti gli anni a venire. Il miracolo di cui sopra si chiama Bowie, amico da tempo di Iggy Pop, quest’ultimo drogato fradicio e in uno stato depressivo cianotico per via dell’assenza (da due anni) dei suoi sodali Stooges, allontanatisi per incongruenze e dissapori con lui stesso, e Bowie, colto da pietà artistica lo invita nel suo regno inglese e – dopo non poche storie – riesce a farlo contrattizzare in seno alla casa discografica Virgin.
Bowie in quel periodo era già attivo con lo stupendo album Heroes ed in pochissimo tempo scrisse quasi tutti gli arrangiamenti, le musiche e timbriche per l’album dell’amico mentre James Newell Osterberg Jr. (questo il vero nome di Pop) ne scrive i testi e le metafore bollenti in quello che sarà per la storia del rock, il caposaldo e faro per una marea infinita di band a venire; “Lust For Life” è il disco della rinascita personale dell’artista di Muskegon, il disco scuola del rock universale, la colonna sonora di una generazione di strapazzati e ai limits del bad thing lussurioso, tracce suonate dal fior fiore di musicisti che Bowie assoldò per l’occasione quali, oltre a Bowie stesso al piano, Carlos Alomar e Rick Gardiner alle chitarre ed i fratelli Sales alle percussioni, ed il resto è pura cronaca di storia.
Disco di blues sguagliato e tenace matrice garage che riemerge come sangue bollente; chi non si è mai eccitato o se ne è andato in giro fumatissimo con negli orecchi con le celeberrime “cattive compagnie sonore” di “Lust for life”, “Sixsteen”, la dinoccolata “The passenger”, tutto l’ìimpossibile di droghe, alcool e sesso depravato che scorrono in “Tonight” e nel blues sbavato di “Turn blue” o fatto l’amore con la ragazza del momento mentre sullo stereo scorreva la deviante “Fall in love with me”? Chiunque vedeva e vede in Iggy Pop l’arma ed il corpo contundente fatto uomo che – per antonomasia – il rock abbia mai creato, e questo fulminante disco non era altro che il primo gradino della rinascita di un artista che ancora oggi – a distanza di anni ed anni – incute rispetto e fa architrave dell “ascolto grande”
“Diamanti Vintage” Ivan Graziani – Ballata per 4 stagioni
Forte delle innumerevoli esperienze sui palchi di tutt’Italia al seguito di Lauzi, Lucio Battisti e Antonello Venditti, un giovane e concretamente sognatore Ivan Graziani, si “mette in proprio” accasandosi alla casa discografica Numero Uno del maestro Mogol, e, sempre accorto agli scambi artistici diretti e indiretti con l’amico e sodale Venditti, esce allo scoperto con questo ottimo disco “Ballata per 4 stagioni”, l’esordio ufficiale di un artista che in futuro colorerà la scena musicale italiana di canzoni simbolo nonchè scuola diretta per molti cantautori a venire.
Con una voce in falsetto, vero e proprio marchio dell’artista, Graziani è un personaggio di una genialità creativa non trascurabile, un talento poetico e diciamo anche chitarristico (anche se in questo album il suo amore primario sembra essere il pianoforte o le tastiere in generale, ma che in secondo tempo abbandonerà) che si fa notare subito e con interesse, la sua è una forma melodica malinconica e briosa nel contempo, amori, ricordi, trasparenze e brividi sono la costante delle sue opere/canzoni, e che in questo disco vengono fuori come gemme primaverili, quell’estetica cantautoriale che lo porterà tra i grandi della storia sonante italiana.
Dieci canzoni arrangiate anche da un valente Claudio Pascoli e che scorrono straordinariamente in una dolcezza di timbri e vezzi che in un certo modo rivoluzionano al contrario gli impeti della canzone contro di allora, praticamente ricollocando la poetica diretta sopra le metafore infingarde che si nascondevano nella protest song e che da li a poco andrà a scemare, e questo valore aggiuntivo proposto da Graziani viene premiato e salutato da stampa di settore e critica come una ventata di “tradizione in avanti” esemplare; canzoni tenere e luminose, canzoni a presa rapida come l’atmosfera slogata di “Dimmi ci credi tu?”, i ricordi in salsa progressive “I giorni di Novembre”, il folk-pop a giostrina di “Il campo della fiera”, o l’intimità di una donna “Come”, una tracklist pensante e ben costruita, subliminata nel finale dalla bella ballata lounge tra sax e trombe “E sei cosi bella”, traccia che chiude un primo successo discografico che ne aprirà altri, molti, nel dopo di carriera.
Disco basilare della discografia di un cantautore sfortunato ma che ha fatto luce – con la sua alchimia di semplicità e talento – su incomprensioni e marchette pop di cui la musica di allora godeva e ci si infagottava senza ritegno.
“Diamanti Vintage” Elvis Costello – This year’s model
Che caratteraccio e che prepotente che era Elvis Costello. E quella volta che nel porticato di un hotel di lusso in Ohio prese a battibeccare con la security di Stephen Stills che sosteneva la supremazia dei musicisti americani rispetto a quelli inglesi? Botte da orbi.
E quell’altra al Saturday Night Live quando volevano impedirgli di suonare Radio Radio, che era un inno di protesta contro gli Yankee? Lui se ne fregò, e quelli del programma televisivo lo aggredirono a sediate. Il suo sangue scorreva così, ribelle, stizzoso e iracondo come un punk, ma con un retaggio musicale che la maggior parte dei rocker di fine anni Settanta ignorava.
Nella sua testa solo Small Faces, Stones e Kinks: This year’s model è il parto fortunato di un’incontro con il produttore Nick Lowe e con la band degli Attractions e un grande capolavoro della storia rock cominciò a frignare per i quattro venti.
Un rocker con una somiglianza strepitosa a Buddy Holly e vetriolo nelle vene, musicista in perenne conflitto con tutto e tutti, in questo disco cambiò i connotati al beat sixteen e lo nutrì di scompensi punkeggianti tra Farfisa e melodie, pop slabbrato e marcette per organo Night Rally, ma è una destabilizzazione psicotica che farà ombra lucente regnante sulle ombre minori della new-wave già esistente e malata di suo.
Costello aveva il ritmo della new wave e il sarcasmo di un britannico rebelde astioso, dentato ma colto: lanciò un suono secco e spigoloso, erede del pub rock ma in linea con i tempi, pronto per essere inquadrato nella foto di gruppo di un’epopea di profondi e resettanti cambiamenti, non solo in fatto di musica.
La sua “back-wave” poteva essere melodica Little Triggers, deflagrante Pump It Pump, e anche dettata dalla stupenda grafìa Dylaniana Lipstik Vogue, ma restava comunque tagliente e lesiva.
In I Don’t want To Go To Chelsea sentenzia, sputa fiamme e “offende” il quartiere simbolo della Londra più elegante, ma lui era altrove a far conoscere alle platee questo capolavoro che divenne un manifesto della new wave e lui occhialuto cantautore scapestrato andò a firmare anche tantissime foto segnaletiche – per risse a catena – dalle polizie di stato americane.
“Diamanti Vintage” Litfiba – Desaparecido
Già da qualche anno la ribalta new-wave tutta italiana dava suoni e mosse scaltre con i Gaznevada, Neon, Denovo, quando i giovani Litfiba – sebbene con piccole esperienze alla spalle – affrontano la forza discografica con questo “Desaparecido”, un disco che contiene impronte stilistiche di stampo Ultravox, qualcosa dei primi U2, Japan per allargarci un po’, ma che comunque li posta, anche con l’aiuto di molta stampa alternative di allora, ad inaugurare una nuova e fresca stagione musicale che li vuole fautori di un nuovo rock tricolore e che da li a poco esploderà in tutto il suo splendore zingarato e mezzo sangue.
La formazione che vede Piero Pelù alla voce, Gianni Maroccolo al basso, Ghigo Renzulli alla chitarra, Ringo De Palma batteria e Antonio Aiazzi alle tastiere, assume tutte le caratteristiche di allora, si veste della wave oscura e decadente, abbraccia un mix di Inghilterra, oriente, torbidi sogni e nebbiose poetiche gotiche che vanno a costituire immediatamente uno status di massa, un simbolo di appartenenza giovanile, uno specchio riflettente che durerà nel tempo, fino ai nostri giorni; otto takes che la voce di Pelù – incontrastato personaggio della band – anche per via di una fisicità selvaggia e prestante, gestisce alla perfezione con timbriche retrò e spunti memorabili di tensione e dolcezza, mentre il resto della band si prodiga tra epicità, segmenti evocativi e una pianificazione di gruppo che rende il giusto, che evoca scenari di successo e una certa avanscoperta lungimirante.
Disco senza controindicazioni salvo la frenesia meticcia, otto tracce che tra sintetismi tattici e sonorità a caldo entrano prepotentemente a far parte della storia incandescente di questa formazione toscana, a partire dalla epicità inneggiante di “Eroe nel vento”, il buio atmosferico che veste “Lulù e Marlene”, il medioriente che avanza sinuoso in “Istambul”, i respiri zingari e il caliente sogno spagnolo “Tziganata” e “ Desaparecido”, tutti piccoli brividi che incalzano in un disco che rimarrà – e lo è – simbolo ed elegia di una stagione d’oro imbrunito che forse non si replicherà mai più.
Da li a poco il grande boom, grandi conferme e punto di riferimento per tutta la scena alternative italiana che ancora oggi, tralasciando rancori, dissidi, mani tese e riappacificazioni, guarda ai Litfiba come padri spirituali e tara dalla quale è quasi impossibile rendersi autonomi musicalmente.
“Diamanti Vintage” Acqua Fragile – Acqua Fragile
La Premiata Forneria Marconi, appena li ascoltò in un concerto durante un festival pop di avanguardie e nuove tendenze li presentò ad un allora giovane Lucio Battisti direttore e discografico della Numero Uno il quale non ci pensò su un attimo a scritturarli, mentre Mamone – allora il manager della scena live per antonomasia – dopo avergli fatto cambiare nome da Immortali in Acqua Fragile, li fece esibire come supporto in concerti memorabili con Curved Air, Gentle Giant, Soft Machine e vari altri, e la notorietà non si fece attendere, tanto che anche la critica – mai ampollosa e rassicurante come in quegli anni storti – ne scrisse grassettati ed euforici commenti.
Bernardo Lanzetti, Pier Emilio Canavera, Gino Campanini, Maurizio Mori e Franz Dondi, si fecero conoscere in tutta Italia, la loro musica – un condensato di Genesis, Gentle Giant e sprazzi chiaroscuri di Velvet Underground – diventò man mano la colonna sonora dei affollatissimi raduni di massa alternativi che in quei tempi si tenevano in ogni cm quadrato della nazione, e il loro universo sonoro approdò in questo primo lavoro discografico omonimo, un disco che mise d’accordo la critica formale, ma scatenò la reazione di quella underground che non gli perdonò mai – alla band emiliana – di fare la controfigura inverosimile dei Genesis e di Peter Gabriel in primis. Ora può essere anche vero che il sound d’oltre manica influenzasse morbosamente la costruzione parziale del disco, ma da farne una guerra ce ne correva, ed ascoltare quelle sette tracce che costituivano l’ossatura del disco non tutto è andato in malora, specialmodo nelle brezze west coast di “Science fiction suite”, “Going out” come nella dolcezza immutabile di “Morning comes”, inno agli svolazzi del progressive in alta uniforme.
Un disco che divise la controcultura, un disco che come arrivò non se ne volle più andare, ed ora un disco da ripescare e risollevare verso l’alto.
“Diamanti Vintage” Grand Funk Railroad – Closer to home
Durissimo, in quello spicchio di tempo, contendere una benchè minima visibilità o un quadrato di stage all’ombra di uno strano “dirigibile” di nome Led Zeppelin che si apprestava ad imbambolare l’America. Fortuitamente però nel 1969 si esibirono al festival pop di Atlanta davanti a 200.000 persone e finalmente il loro combustibile – fatto di volumi al massimo sporchi di hard-rock, soul e blues – s’incendiò di meritato interesse. Il trio del Michigan dei Grand Funk Railroad (Mark Farner chitarra, Don Brewer batteria e Terry Knight al basso, che poco dopo lasciò la formazione per diventarne manager, favorendo l’entrata a Mel Schacher), sulla scia dell’inaspettato successo incide il primo album “On Time” dove una “Heartbreaker” diventerà vangelo per moltitudini di bassisti. Ma è nello stesso anno – con il secondo “Closer to home” – che la scuola GFR si conferma come punto di riferimento basilare dell’hard-rock mondiale. Monster Magnet docet. L’Lp è un’indisciplinata regolazione di riff, assoli, deflagrazioni e ballad ricercatissimi, un rullo compressore che schiaccia e carezza simultaneamente gli impianti stereo comperati a rate; il calibro vocale di Farner “colloquia” in ottave roche e rabbiose con la sezione ritmica a maglio di Brewer e con il pump delle quattro corde di Schacher, creando un ritmo irrefrenabile, impattando Southernità e tendenze soul-blues importantissime nell’innesto e fusione di stilemi “nuovo corso” che la band imbastisce in ricami sorprendenti. “Sin’s a good man’s brother, Aimless lady e Nothing is the same” introducono alla potenza caratteriale del registrato, mostrando i muscoli corporali e d’intento protesi a svegliare l’ascolto dalle “eventuali distrazioni” che in quel periodo portavano ancora nei bagnasciuga della San Francisco Flower. La ballata sentimentale arriva con “Mean mistreater”, mentre con “Get it together e I don’t have to sing the blues” prende il sopravvento il rock-soul funkeggiante, spumoso e hook che fa “worm up” per le tracce finali di questo stupendo incunabolo discografico. Non particolarmente amati dalla maggior parte dei puristi musicologi di allora, i Grand Funk Railroad conquistano le nuove generazioni che vedono in questa orgia di sonorità calde-elettriche un power-trio di riscatto, di orgoglio “nazionale”, una guida “ruvida e ribelle” a stelle e strisce, e che in “Hooked on love e I’am you captain” trovano il loro inno da gridare. Seguiranno altre produzioni di successo: “Live album, Survival, il premiatissimo E Pluribus Funk” ma poi la vena pian piano si asciuga a favore di una commercialità vuota e da classifica, fino a diventare da cult band che era a mera “dollars machine” contesa tra Wal-Mart e la gadgettistica da Starbucks. Alla fine l’oblio e il declino totale. Closer To Home è uno spregiudicato vinile che ha stigmatizzato – come si dice nella filosofia attuale – l’ingranaggio dell’era dei distorsori del rock duro, hard.
“Diamanti Vintage” Rolling Stones – Exile on main st.
Mick Jagger , l’arrogante per eccellenza all’uscita di questo disco disse: “L’ho finito da solo, altrimenti, con tutti gli ubriachi e drogati che giravano in quel periodo..”. Odiava quel suono grezzo, ruvido e mixato indecentemente. Al contrario, a Keith Richard, piaceva moltissimo, amava la riconquista della selvaggia onda del rock e finì che si accollò i meriti e gli onori, portando il suono della sua chitarra sui massimi livelli espressivi.
Album doppio, diciotto tracce che lucidano a fondo l’anima sporca di Richard che, accantonate certe transizioni esotiche, rigurgita in queste outtakes ripescate da bauli segreti, tutti i demoni e i fantasmi “neri” che scalciano nella sua testa; “Exile on main st.” è il disco che “brucia la pelle” a suon di folk, rock’n’roll, boogie, blues, gospel, voodoo plateale e honky-tonky delle paludi del South, cardiopalma da 67 minuti che emana un’incredibile voglia di strada, un incessante fluido di feeling atavico e suoni di terra secca.
Si può benissimo cesellare tra le radici di un lavoro tradizionale – inteso come recupero estetico dei “rumori del diavolo” – in cui la chitarra la fa da padrone, annebbiando un po’ la fisionomia sexy di Jagger, che – ad un attento ascolto è messo in seconda fila dal suo amico-nemico-rivale.
Registrato a metà, tra gli studios Sunset Sound di Los Angeles, e la villa in Francia di Richard, questo caposaldo – a posteri – della discografia degli Stones, è un inno pazzesco al boogie di razza innalzato al massimo da pompate di fiati, scartavetrate di pianoforti e odi di slade e gospel che inducono al tremore; Casino boogie, Rip this joint, Tumbling dice, Rock off sono le piste che più di tutte scialacquano negli acquitrini salmastri dell’Old South of America – fenomenale la rivisitazione di Shake your hips del grande bluesman Slim Harpo – ma è tutta l’atmosfera che gira in questo album che fa agitare, in fondo, il vero spirito sonico/primordiale degli Stones.
Wyman, Jagger, Taylor e Watts, fanno miracoli a stare dietro alla forma smagliante, quanto diabolica, di un’impossessato Richard che tra sferragliate di chitarra e genuflessioni al sacro fuoco del gospel –blues Sweet Virginia, goliardie country Torn and frayed, scatenamenti woodoo satanici I just wont to see his face e solismi d’armonica, percussioni e acustica Sweet black angel, sfoga rabbia e divinazione che poi in seguito si dovranno cercare con il lumicino.
Lancinanti le performance di Bill Preston alle tastiere, Bobby Keys al sax, Jim Price alla tromba e Jim Miller – quest’ultimo alle percussioni roventi nel revisitez blues Stop breaking down di Robert Johnson.
Dopo questo disco “rotolante” come Dio comanda, l’inferno quello vero, la droga che si impadronisce di Richard e la caduta dei Rolling Stones nel torpore di una vana creatività che si prolungherà per molto.
“Diamanti Vintage” The Cure – Three Imaginary Boys
É storia appurata, se non ci fosse stato in giro in quegli anni, tra le masserizie squarciate del dopo punk, lo spirito allucinato degli Joy Division, di loro non ne avremmo saputo mai nulla, o forse non sarebbero mai esistiti.
Prima Easy Cure con il naso dell’istinto, poi Robert Smith alla chitarra e voce, Michael Dempsey al basso e Lol Tolhurst alla batteria fondano il nocciolo primitivo della più grande leggenda oscura del rock che prenderà il nome The Cure, l’emblema notturno del buio.
Ma qui siamo alle origini della loro novella, e sebbene Smith e soci si vestono di nero e si bistrano gli occhi di nerofumo, siamo lontani da come li conosciamo oggi; è l’esordio di una band che vuol fare ballare, divertire, saltare tra ritmi punk-reggae e baldorie beat anni 60, dove la malinconia fondamentale dell’epoca sale in gola solo in sparuti episodi disseminati nella tracklist.
“Three imaginary boys” arriva come a far pace – dopo il singolo dell’anno prima Killing an Arab che tanto aveva fatto infuriare le comunità islamiche per via del suo contenuto oltraggioso – col mondo intero, e colpisce subito nel segno per la vivace stravaganza ed eccentricità surreale di cui si colora.
I “giocherelloni del Sussex”, come saranno chiamati scherzosamente i The Cure, guadagnano le prime pagine delle riviste rock, fra i protagonisti della nuova corrente post-punk guidata appunto dai Joy Division e Siouxie & The Banshees. Il resto lo fa la bizzarria della proposta musicale: un suono magro, con la chitarra di Smith in primo piano e atmosfere diafane che prendono spunto dalla psichedelia Endrixiana quanto al glam di Bowie.
I ragazzi hanno vent’anni e il suono può sembrare ancora immaturo, abbozzato, ma fresco e irriverente 10.15 Saturday night, Object e So what, emozionante nella rivisitazione distorta e ubriaca di Foxy Lady di Endrix, terribile nell’urlo lancinante di Subway song e allucinato nello swing che si scalda per poi prendere fuoco in uno stranissimo reggae-free jazz Meat hook; il romanticismo nebbioso, che poi cova nel carattere dei musicisti, trapela nel gioiello del disco, quel Fire in Cairo dal ritornello lento e imbambolante in cui sono cantate le lettere in inglese dell’alfabeto – i, erre, effe ecc -, che lascia presagire – col senno di poi – la via maestra della band verso la “linea gotica” che li incoronerà – nel giro di due/tre album – portavoce ufficiali della nuova generazione di sconfitti.
Tuttavia rimane un esordio allegro e pimpante, ancora vergine e immacolato rispetto al tetro dark che abbracceranno in futuro, dove prenderanno coscienza che l’essere depressi è la vera realtà,. se non l’unica, per essere felici senza un sorriso e per sorridere senza una smorfia di viso. Disco essenziale come un’arcobaleno prima – e non dopo – la tempesta no-future che bussa all’uscio.
“Diamanti Vintage” Juri Camisasca – La Finestra Dentro
Anche l’affezione del pubblico, sempre più fitto, giovane, curioso confermò questo giovanissimo e introspettivo capellone milanese, Juri Camisasca, come una vera cometa oscura in quella scena contemporanea ed alternativa che poi erano i roventi anni Settanta; oramai la protest song, la canzone di protesta politicizzata, stava quasi per chiudere le ali, tanti erano gli eventi e le rivolte da indurla a smarrirsi da sola, avanzavano nuove necessità ma soprattutto nuove idee sonore e nuovi carotaggi interiori che si presero – a lato di un cantautorato visionario – una parte consistente della scena progressive imperante.
E appunto un eroe oscuro, delirante, sui borders dell’esistenzialismo minimale, si palesò in Camisasca con questo esordio discografico “La Finestra Dentro” – introvabile oramai – prodotto da Franco Battiato, allora filiforme sperimentatore metafisico, un disco che definire ossessivo è ben poca cosa, ricco, venato e svenato di pads atmosferici al limite della claustrofobia, interiore oltre le viscere, ma anche un profondo sguardo in tralice sulla fragilità dell’uomo e della sua precarietà di rapporti, tracce in cui sembra passeggiare un Kafka al limite di se stesso “Metamorfosi” fino a straziarsi “Scavando col badile” sul concetto che prima o poi l’animale (in primo piano sempre topi) avrà la dominazione sull’uomo; certo un disco per allora rivoluzionario nel senso stretto del contenuto, ma non di facile approccio se non dopo attenti ascolti, acustica ed elettronica si fanno la corte, poesia e analisi psicologica si contendono la tracklist come del resto l’intensità rovesciata di questo artista contende forse con sé stesso quella quadratura allucinata informale che si trasformerà in una nuova tendenza espressiva unica nella sua storia.
Nella penna di Camisasca gira molta disaffezione e non manca quell’autodistruzione morale tipica del disagio artistico, umano e sociale dei Settanta specie in “John” storia di un amico ritrovato e che la vita lo ha costretto a fare il travestito, in “Galantuomo” si cerca la negazione della vita e più sotto, nella finale “Il regno dell’Eden”, l’autore si “reincarna” in Dio, in un vero delirium tremens tra cori infantili, chitarre ed effetti elettronici che chiudono questo disco trasversale che già allora anticipava i tremendi tempi moderni della nostra mostruosa società. Un disco premonitore e a suo modo, esemplare, stupendo, che concede uno spicchio di sole in “Un fiume di luce”, unica traccia che ti fa alzare lo sguardo, lo stesso che appena finita ti ricade come ad un manichino senza più fili tesi
Amanti degli sconvolgimenti d’anima, spasimanti degli spiriti maledetti, fatevi avanti, questo disco è merce rara per chi è profondo.
“Diamanti Vintage” Radio Birdman – Radios Appear
L’Australia dei mitici Radio Birdman, folgori istantanee che durarono quanto una eclissi di sole, guarda all’America stupendamente laida del garage di Detroit, quella dei stordimenti elettrici di MC5, Stooges, ma la lingua popolare li vuole collocati tra le ortiche del punk sebbene i rifferama del chitarrista Deniz Tek lasciano all’immaginazione scenari molto più distanti dell’azzardata approssimazione; e questo bel disco “Radios Appear”, bardo assoluto della loro parabola, in pressappoco cinquantatre minuti di scalmane di gruppo, lascia il segno indelebile della grande nevrosi rock che correva in quel periodo già tanto agitato di suo, e che li colloca come agguerriti rivali dei newyorkesi Television, quelli di Marquee Moon, che da tempo graffiano la scena dell’East Side.
Chitarrismi forsennati, ansie, urgenze espressive e la vivacità di una epoca di rinnovamenti e scoperte culturali, sono le prerogative principali di queste dodici canzoni di una tracklist che rimarrà impressa per l’eternità, il manifesto musicale di questo sestetto indimenticabile che dall’altra parte del mondo fornì una risposta inequivocabile alle alte baronie elettrificate esistenti non con l’aggressività ma con la baldanza innica e corale di una gioventù ribelle che contrapponeva al tagliente e crestato cosmo punk sovraffollato di sputi e droga la sbavatura (a modo) di canaglie di (buona famiglia); un album in cui la band cita il sommo Edgar Allen Poe “ Descent into maelstrom”, traccia monumento ad un tocco di chitarra febbrile e ad una voce – quella di Rob Youngher – al top dell’immaginifico, poi una marea di solforazioni anni Cinquanta che si immolano in “New race”, “What gives?”, “Do the pop”, la bella arietta grigia che tira in “Man with golden helmet”, un trucilo di wave che si insinua dentro “Hit them again” per arrivare al pezzo forte contenuto nel numero dieci della scaletta, quella stupenda cover di “You’re gonna miss me”, grande successo di Roky Erickson ed i suoi 13th Floor Elevator.
Diabolico rock’n’roll, una vera celebrazione negli anni dei terremoti ideologici e di costume.