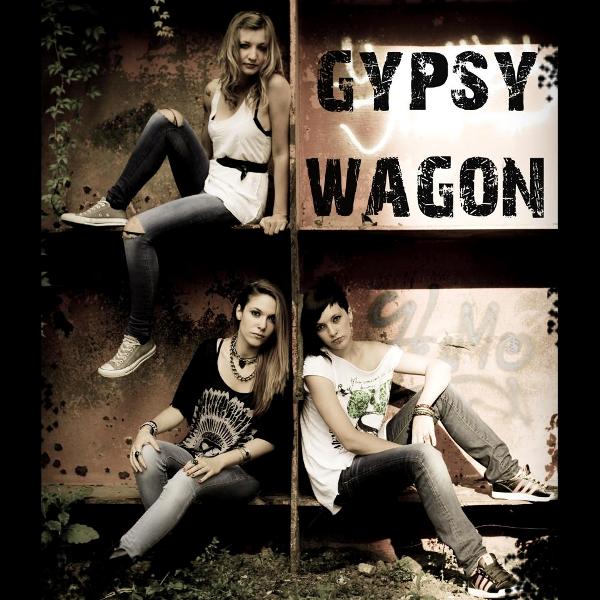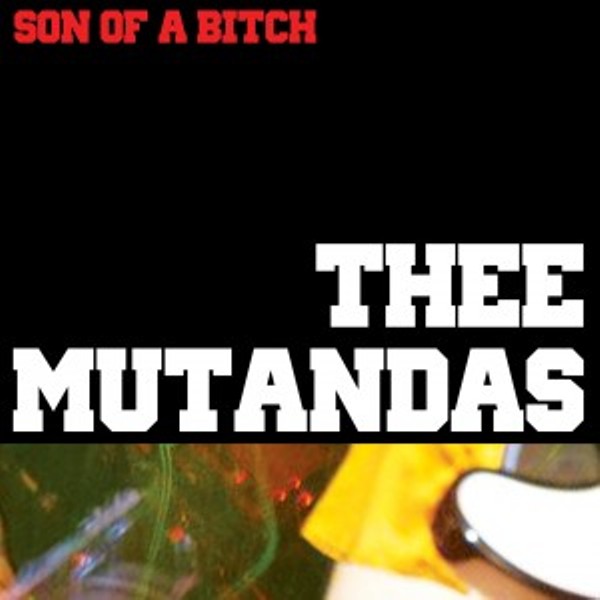C’è un paese, una città meglio, visto che conta cinquantaquattromila novecento otto abitanti ed è capoluogo di provincia, che ha generato in me contemporanee scariche d’intenso odio e amore, nel corso dell’ormai decrepito 2012. Da abruzzese, che per tutti i dodici mesi ha fatto la spola tra Pescara e l’entroterra (molto “entro”) aquilano, Teramo è stata sofferenza e diletto, tormento e soddisfazione. Ho visto una moltitudine di band emergenti nascere sotto le pendici del Gran Sasso mentre io, a Pescara, continuavo a vagabondare per locali danzanti, metallari e Dj Rock (sì, esistono i Dj rock, che cazzo credete?) cercando un gruppo che non c’è, o forse c’è ma ai pescaresi non gliene frega un cazzo. Tante manifestazioni sonore si sono tenute nel teramano, come le esibizioni live di Calibro 35, Bugo, I Cani, gli Offlaga Disco Pax. Cosi, se da un lato vedere l’esplosione di band come gli String Theory (che ho inserito nella mia top three annuale) stava facendo crescere in me l’amore e l’interesse per un territorio fino a ora quasi sconosciuto, dall’altro, vedere la facilità con la quale la gente del posto riesce a ignorare il dilagante fenomeno (il tutto si può notare con la scarsa partecipazione del pubblico ai diversi eventi programmati nella zona) mi fa una rabbia bastarda.
La mia ultima scoperta si chiama Starslugs. Ho il loro disco autoprodotto tra le mani, The Rite And The Technique e guardandolo mi rendo conto che quest’ammasso circolare di policarbonato non mi regalerà certo le dolci note di un pop cantautorale rassicurante e delizioso. Sotto il nome della band sono scritte in inglese le parole “One Straight Line -Do It Yourself” (una sorta di mini manifesto generazionale di una certa cultura punk underground nata negli anni ottanta e che mirava innanzitutto al rifiuto della major per poi diventare un vero modo di vivere) e più in basso, al centro della copertina, mi sembra di vedere un nero che con un ghigno a metà tra dolore e gioia, è intento a trapanarsi le cervella. Ancora più giù, sotto l’indicazione del nome dell’album, un altro sottotitolo nella lingua della regina d’oltremanica recita “una breve storia d’impressioni rubate da un ambiente ostile”. Diciamo che sembrano esserci tutte le premesse per non sperare di rilassarsi tranquilli durante l’ascolto.
Nella parte di dentro del libretto, a rincarare la dose, troviamo di fianco alla tracklist, l’immagine di un fucile smontato, di quelle che si trovano nei libretti d’istruzione, con tutti i numeri sopra ogni pezzo e in basso, ancora una volta in inglese, l’invito a copiare e diffondere l’opera ma non a rubare le idee contenute all’interno. Finalmente mi sento pronto a schiacciare quel pulsante e trasformare la guerra fredda della mia attesa in una pioggia di bombe soniche.
Intanto che ascolto, vi racconto chi sono gli Starslugs. Nati poco più di cinque anni fa in Abruzzo, sono semplicemente un duo (che si definisce Punk-Noise) composto da Danilo “Felix” Di Feliciantonio e Pierluigi Cacciatore, ai quali si aggiunge un batterista che viene dal passato chiamato drum machine Roland TR707 (il suo nome preciso sarà strettamente legato alla musica, come poi vedremo). Scrivono i pezzi nella lingua di Poe e Bukowski e la cosa è un bene (anche se i puristi, fascisti, nazionalisti magari, non la penseranno cosi) perché è il modo migliore di applicare la voce a questo tipo di suono in frantumi. La voce è come la tecnica e la bravura applicate a un qualsiasi strumento. Un chitarrista nel suonare mette insieme le sue capacità con la chitarra che preferisce per il tipo di suono che emette. Cosi chi canta, mette insieme le sue doti con lo strumento, rappresentato nel qual caso, dalla lingua scelta. Ogni lingua come ogni chitarra può essere più o meno adatta a un certo tipo di musica.
Ho finito di ascoltare il disco e lo riascolto ancora e ancora. Nel brano iniziale “Body Hammer” entra subito in scena la Drum Machine e lo fa in un modo che adoro. Martellate ossessive, ripetitive, lineari, quasi marziali preparano l’ingresso alle chitarre che sferragliano come motoseghe impazzite e alla voce che, per quanto possa essere lontana dal concetto platonico di bello assoluto, è perfetta nel suo trascinarsi contorta nello stile del grande Steve Albini. Ci siamo, ecco svelato il trucco. La presenza non della drum machine ma proprio di quella drum machine era un indizio troppo grande. Sull’opera degli Starslugs si staglia imponente l’ombra dei Big Black, la creatura Noise Rock, Post-Hardcore nata negli anni ottanta proprio dalla mente genialmente contorta di Steve. La sua creatura che più ho amato e apprezzato nel corso della mia vita. Aspettate, però, a giungere a conclusione. Non pensate di essere di fronte a una band di “copioni” che volevano provare a fregare un pubblico magari ignorante in materia. La storia è un’altra.
Il secondo brano “Nuke”, il mio preferito, è uno di quei pezzi che ti mette voglia di ascoltarlo ogni fottuto giorno che avresti voglia di spaccare il culo al mondo; inizia con echi vocali di stile industriale e il solito ritmo tormentato, ma quando entrano in scena le corde, ti rendi conto che questi ragazzi hanno capito come pugnalare le orecchie in modo masochisticamente piacevole. Mentre la voce si limita a urlare lamentosa, chitarra e basso creano melodie strepitose che ti entrano nel cervello come un cancro.
Se “Sad Sundays “ accelera il ritmo mantenendo intatta la natura Post-Hardcore degli Starslugs, con le successive “Sense Of Tragic” e ancor più “Betamax” e “Justice”, un sospetto diventa certezza. Dentro il tormento delle ritmiche di questo The Rite And The Technique c’è un’altra band che probabilmente, rispetto ai Big Black, saremo in meno a conoscere. Le atmosfere tribali rievocate nel disco sono le stesse già raccontate dai Savage Republic, band Post-Punk californiana contemporanea dei Big Black, autrice di uno dei migliori lavori nel suo genere chiamato Tragic Figures (la formazione è ancora in attività e lo scorso anno ha prodotto Βαρβάκειος). La cosa che fa piacere è che, dopo aver ascoltato il disco e aver notato i chiari riferimenti ad Albini e i più nascosti alla band di Bruce Licher e Jackson Del Rey, sono andato a leggere la biografia della band teramana e questi due nomi sono gli unici inseriti nei loro riferimenti. Ciò significa due cose. Che, innanzitutto, gli Starslugs dimostrano una notevole onestà intellettuale citando in maniera schietta i loro riferimenti (calcolando che probabilmente il grande e ottuso pubblico non li avrebbe neanche riconosciuti, potevano fare i furbi e sottintendere i riferimenti). Infine, che, se volevano rifarsi a due grandi nomi del passato, l’hanno fatto in maniera egregia, riconoscibile. Il loro sound sembra la degna prosecuzione dell’operato dei due grandi gruppi degli anni ottanta e non una loro pessima copia e tutto questo è dovuto non solo alla loro bravura puramente tecnica e compositiva ma anche a tutto il lavoro di ricerca della strumentazione vintage fatta dai due. Il risultato è perfetto.
In “Uranus” sembrano riaffacciarsi (vedi “Nuke”) delle reminiscenze industriali, dark ambient proprie del movimento nato dalla mente di Genesis P-Orridge e i suoi Throbbing Gristle. Circa cinque minuti di note lente e ripetitive, quasi come una messa funebre in una chiesa sconsacrata. Non c’è nessuna parola ad accompagnare la voce. Solo corde acide e stridenti che pesano come il peccato originale nel cuore del nostro spirito.
Una voce meccanicamente in loop apre “Willie”, altro brano in classico stile Big Black che presenta una melodia nascosta tra il rumore, di quelle che non si scordano facilmente, mentre chiude l’album “Mishima”, l’ultima esplosione atomica, l’ultimo tassello della mia guerra fredda interiore, la bomba H che ha distrutto l’umanità nella mia anima.
Gli Starslugs non hanno sono preso Big Black e Savage Republic per rielaborarli e proporli con fredda imitazione. Hanno invece continuato un percorso tribale e rumoristico iniziato con Atomizer e che non poteva evidentemente concludersi nel 1992. Hanno ripreso la strada di un sound cosi semplicemente straordinario da essere fuori dal tempo, da essere talmente immediato e identificabile anche nel suo essere elementare. Sono stati capaci di creare melodie da materia tagliente e sanguinante come il Noise-Rock. È per questo che gli Starslugs mi sono piaciuti cosi tanto pur essendo probabilmente la band meno originale ascoltata negli ultimi dodici mesi. Perché la loro è una sorta di opera di recupero di sonorità che altrimenti sarebbero andate perdute nell’oblio dell’ignoranza.
Gli Starslugs hanno deciso di continuare la strada ideale di chi al mondo ha risposto con un beato vaffanculo.