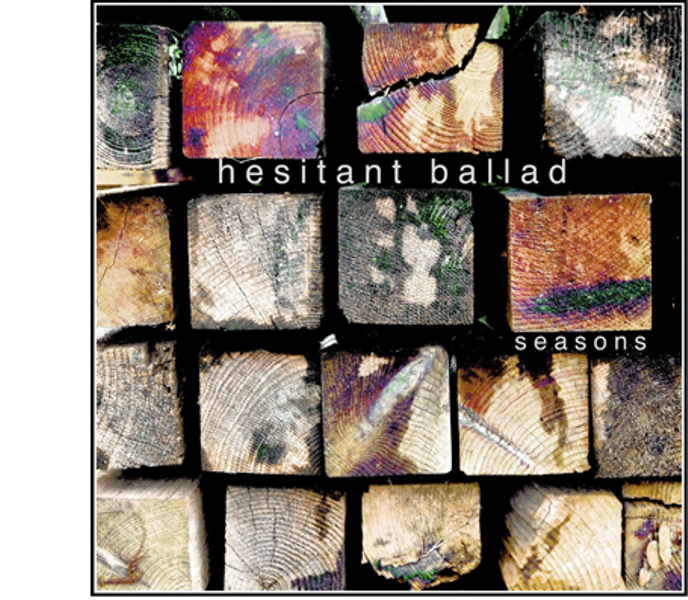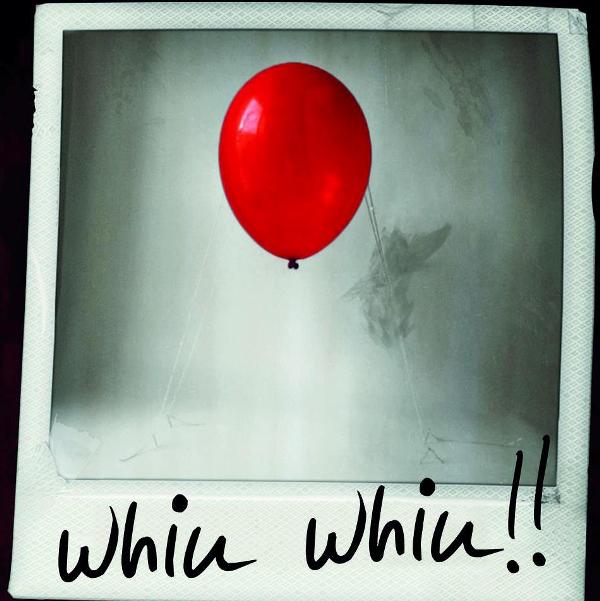Sabato 8 Dicembre.
Da ieri Pescara è invasa dall’onda anomala dell’Indierocket. Quest’anno niente location fisse. Una grandiosa festa itinerante come un serpente striscia per la città con la sua scia di ragazzini ubriachi, dal cuore di Manthonè fino alle discoteche (se cosi si possono definire) delle zone più periferiche. Per qualcuno sarà una serata memorabile. Altri si chiederanno chi cazzo sono Delawater, Sam Mickens, New Candys, Disquieted By, ecc… Molti rimpiangeranno quei bei sabato di merda passati a sbronzarsi, scazzottare, vomitare e ballare all’ombra di quattro Dj e basta. Io mi scolo l’ultima latta al sapore di piscio caldo e mi fiondo nella mischia. Stasera si va all’Orange, uno dei pochi locali di genere, di quelli da cui gli hipster, di solito ma non sempre, stanno alla larga, pieno di metallari incalliti, con barbe incolte e capelli unti tipo nani da Fantasy Movie. Non mi sembra di aver mai visto nessuno con grossi martelli medievali ma sono sicuro che nel bagagliaio delle loro belle monovolume debbano essercene. Mi fermo a pisciare sotto a un ponte, dove quattro ragazzetti ben vestiti, con petto villoso in vista nonostante il freddo, si fanno la loro sniffatina prima di iniziare la serata a caccia di figa con i soldi di papà. Li mando a cagare quando iniziano a sbraitare come cani che difendono le loro troie dalla vista del mio cazzo e continuo la mia odissea tra le anime dei dannati che lamentosi si accalcano all’ingresso di una discoteca Reggaeton dove rumeni strafatti in mutande litigano con sbirri annoiati e pieni d’odio. Io vado all’Orange.
Stasera tocca al duo trentino (Mirko Marconi a voce e chitarra e Lorenzo Longhi, sostituto di Marco Ricci, alle percussioni) Death By Pleasure. Arrivo davanti al locale e il pubblico è esattamente quello che ti aspetti. Metallari cronici che vanno al concerto, anche se dovesse suonare una cover band dei Pooh, qualche punkettone impenitente, universitari con pochi soldi in tasca, puttanelle dark, trentenni con la fobia di crescere ed Io.
È abbastanza presto e mi isolo cercando di fumare una Pall Mall 100’s e bere una Peroni comprata da un pakistano, senza che nessuno venga come al solito a rompere le palle per una sigaretta o per vendere un cazzo di accendino che domani avrò perso. Tutti sono in fermento ma non ancora abbastanza. È presto, vi dicevo e gran parte di questi sconosciuti compagni di sbronze è ancora troppo serio perché abbandoni le proprie timidezze disadattate. Un tossico (almeno cosi mi sembra) comincia a fare il gradasso, urlando e ridendo, sbraitando verso i deboli sobri convinto della propria essenza di unico essere libero della terra e della serata. Entra ed esce dal locale come il cazzo di un eiaculatore precoce e alla fine, proprio quando do i soldi al negro per l’accendino con un culo sopra (il mio l’ho perso, puttana Eva) quel cazzo di tossico mingherlino fionda un cazzotto a braccio teso sul volto di una tipa, di quelle stile universitaria che ce l’ha solo lei, la figa alla francese. È talmente moribondo e scheletrico che il dolore fisico non è niente. Deve averla ferita dentro però e lo manda a fare in culo in maniera molto stravolta. Lui si dilegua, ridendo, il coglione mentre spengo la centos e bevo un altro sorso di birra gustandomi la scena del ragazzo frocio di lei che non fa assolutamente nulla, finendo per farla incazzare ancora di più. In realtà nessuno ha fatto niente, non solo il frocio (che comunque probabilmente se la scopa, quando lei vuole e quindi avrebbe avuto motivi migliori per non farla incazzare). Voglia di sopravvivere, menefreghismo, la tipa sarà stata sul cazzo a tutti? Chi può dirlo. In fondo neanche io faccio niente, oltre che accendermene un’altra e stappare sessantasei. Bella serata di merda la loro. Stasera niente pelle per il frocetto.
Faccio un’ultima pisciata dietro al vicolo e sono pronto a entrare. I Death By Pleasure hanno appena iniziato. Una bomba; una cazzo di fottuta figata, porco il nostro grande signore delle tenebre Satana. Lo dico ad alta voce e sono costretto a scusarmi con gran parte dei suoi adoratori presenti. Il locale puzza di testosterone. Anche le fighe puzzano di testosterone e capisci perché il Rock non è roba da checche. Qui anche le donne sembrano avere le palle. Inizia un lento pogo violento e mentre cerco di prendere un bicchiere di vino a buon mercato (altro che prezzi da Milano da bere come per il corso) mi arriva un pugno dritto sugli occhi e ciao ciao.
Domenica 9 Dicembre.
Mi sveglio alle dodici nel letto di casa a sessanta chilometri dall’Orange e da Pescara. Che cazzo è successo? Non ricordo niente e non ho nessun livido se non allo stomaco. Forse al concerto non sono mai andato? Sono mai uscito da qui? Mi alzo dalla culla e vado direttamente in cerca di cibo. Prendo Wasted, Wasted, l’Ep dei Death By Pleasure e comincio a ingozzarmi di Garage, Lo-Fi, Punk, Shoegaze, Psichedelia Sixties che non ci metto più di quindici minuti a divorare tutto. Il mio corpo non regge ed esplode in un sound da paura, come se le budella mi fossero uscite dal deretano e si fossero infilate in un tritacarne. Wasted, Wasted è una cazzo di fottuta figata. Ho sentimenti discordanti verso le accoppiate solo chitarra/voce e batteria. Mi sono rotto le palle di cloni che scimmiottano White Stripes o Black Keys per fare poi la fine dei Bud Spencer Blues Explotion.
Ma loro sono di un’altra pasta.
Già l’inizio di “Spontaneous Combustion”, il suo intro Hard Rock acido, il proseguimento punk garage che sembra uscito da una vecchia cassetta anni settanta, la potenza della sezione ritmica minimale e devastante, mi aprono il cervello. Il cantato di Mirko per quanto tecnicamente non sia niente di eccezionale è perfetto nel suo essere volutamente anarchico. Le note si trascinano violentate dal fragore, ricalcando la nuova ondata rumoristica alla No Age o Clockcleaner senza dimenticare le influenze del buon vecchio shoegaze britannico, specie nella fantastica “Points Of View”. Se tutta la componente data dall’influenza dei suddetti generi è rimescolata con violenza nella prima parte dell’Ep, con “Shy, Shine”, i trentini riescono quasi a dare una struttura melodica al loro garage multicolore, partendo da un intro di scuola barrettiana per finire proprio rielaborando armonie tipiche stile The Piper At The Gates Of Dawn (il primo album proprio dei Pink Floyd) chiudendo in una valanga sonora devastante.
Con “Find A Fire That Burns” un sospetto precedente trova la sua conferma. Dentro questo Ep ci sono tanti ascolti dei grandissimi Nirvana. Più di quelli che chiunque abbia ascoltato l’Ep potesse immaginarsi. Come se quel Grunge primordiale fosse riproposto con ancor più grinta, mescolato allo Shoegaze e al Noise. Anche nella voce c’è una sorta d’involontario omaggio al modo di cantare di Kurt Cobain e all’esplosione del suo cervello. Le sperimentazioni sonore di “Waiting, Wasting” anticipano alla perfezione LBMB che, se non convince pienamente nella parte iniziale, poi diventa un ordigno vero e proprio nel finale. Nel complesso qualche assonanza con il Blues di White Stripes e Black Keys c’è ma non è mai egemonico rispetto al resto che è pura adrenalina!
Lunedì 10 Dicembre (forse)
Mi sveglio con un mal di testa da paura. Che cazzo. Accendo la luce e mi guardo intorno. Dove cazzo sono? Non è la mia camera, anche se la forma è la stessa. Fa un caldo infernale. Lo stereo non c’è più, non c’è il giradischi, nessun vinile, nessun libro, nessuna bandiera dei Sex Pistols, non c’è niente. Apro la porta della mia camera e mi accorgo che tutto sta bruciando. La casa è in fiamme ed io sono in trappola. Ed ho anche un cazzo di occhio nero.