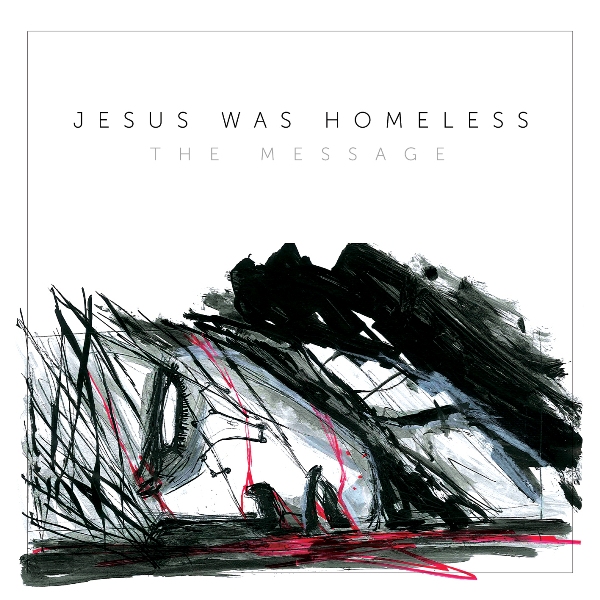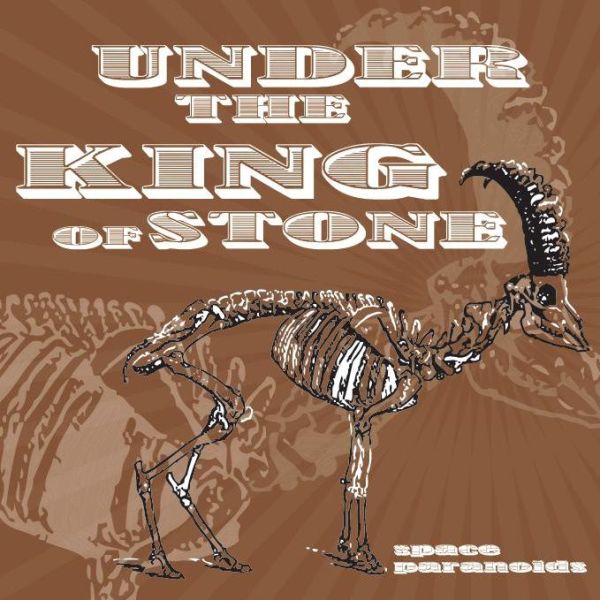Leggo: “nati in California, distribuiti in Giappone”, manca l’aggiunta che in Italia spaccano di brutto, ma a dirlo sono anche i numerosi commenti che si leggono ovunque circa la mole di suono e di scrittura che i romani Jesus Was Homeless documentano ogni qualvolta che escono con la forza di un power d’assalto, e “The Message” è l’ennesima prova di un talento oscuro che motiva e svezza l’ascolto alle poche cose che vale la pena di circoscrivere nel sostantivo underground.
Elettronica e rock uniti nel destino, estetica sonora che trasporta ogni secondo della sua corsa – tra stereo e fondi d’anima – la coerenza di essere sé stessa, in quella fluidità e personalità dalle colorazioni a volte striate di wave, a volte marcatamente libertarie, un vocabolario tecnico e di passione che porta i JWH tra le migliori pulsazioni underground che la nostra scena possa innalzare a vessillo di purezza e scrittura; un disco che suona e si riferisce “alle grandi platee” d’oltre frontiera, libero dai legacci del “deve convincere” per già grassettare pagine memorabili di suono ed impatto come pochi. Disco di hook radio, arie elettriche post-punk e la vivacità emo imbronciata degli anni zero, queste le credenziali di una band in rotta di collisione con le “sfigherie” di moltitudini e chiassose falangi indie-nerd che coprono il sistema emergente delle nuova musica, un terzetto che trascina l’ascolto in un pregevole limbo di scansioni e fotogrammi che tratteggiano il fervore canadese dei Simple Plan o le implosioni dei Ten Foot Pole.
Otto takes che hanno il potere di piacere, la cognizione di “girare bene” e la melodia scintillante di un cuore in costante mutazione color nero seppia, tracce che risintonizzano uno dei segreti meglio custoditi del rock, ovvero quello di praticare la libertà senza se, senza ma e senza paura di farsi chiamare “cloni” di qualcosa che comunque è sempre postato più in alto nella gradazione della creatività; ora vinta questa visione pragmatica, l’ascolto si libera per legarsi agli shuffle Ottantiani di “Violet line”, “The ride”, alle atmosfere striate dei Placebo che sciamano nelle volte della bella “So dirty”come nella concessione pop alla U2 di “In L.A.” e “Our eyes”, poi la,lucidità di avere tra le mani e negli orecchi un qualcosa di ottimo – senza gridare alla miracolistica – ma ottimo, fa il resto.
JWH, un gruppo su cui puntare, una band da non lasciar sfuggire come fanno le migliori menti che scappano all’estero
Recensioni
Soundrise – Timelapse
Come possiamo porci nei confronti di un’allergia? Beh io me ne porto dietro ormai parecchie, per fortuna nessuna grave, ma pare che il mio corpo rigetti sempre di più con il passare degli anni. Pelo dei gatti, paracetamolo, graminacee. Ma anche le versioni di latino, le serie televisive (Twin Peaks a parte), i Radiohead. E rimanendo in tema musicale il progressive rock.
Questa mia ultima irritazione forse deriva semplicemente da una scottatura. E’ probabile che a 17 anni quando ho iniziato a strimpellare il basso, tutti gli allievi della scuola di musica che frequentavo mi facevano notare quanto bravi fossero con i loro strumenti infittiti da un numero esagerato di corde a riprodurre fedelmente tutto Metropolis dei Dream Theater. Beh potete capire come si possa sentire frustrato un ragazzino che faceva fatica persino ad andare a tempo dietro Jailbreak degli AC/DC.
Da questa premessa si capisce quanto sia stato arduo l’ascolto di questo album dei triestini Soundrise. Timelapse si presenta come mix di hard e progressive rock della durata di 50 minuti.
Massaggio lentamente le mie orecchie e le getto in pasto ad un sound a loro avverso. L’attacco è deciso, non ci sono dubbi: rullatoni e doppia cassa, ritmiche storte, intrecci complicati e tastierismi esagerati. Ma anche una buona dose di melodia, ben interpretata da Walter Bosello (anche alle tastiere), che devo ammettere esegue un ottimo lavoro compositivo, oltre che nell’esecuzione vocale. Forse il mio cervello limitato non riesce ad apprendere, a viaggiare insieme a queste musiche così contorte. Si disperde in un sentiero pieno di deviazioni e curve, così irreale davanti miei occhi. Lontano dalla terra e dal cielo che conosco. Non riesco a toccare né con mano, né con l’aiuto dell’immaginazione i luoghi delineati nelle note dei Soundrise (“all that I can see, I try to keep it near and all the things I keep they seem to slip away” la prima frase di Time is mine pare capire il mio stato d’animo).
In Higher Ground la band conferma di essere strepitosa tecnicamente, ritmica funkettona stortissima e una tastiera molto misteriosa rimandano alle vecchie glorie dei Rush. Give Up è melodia pura e ha il sapore di un ballatone hard rock di fine anni 80 con un assolo bello ruffiano e piacevole. Sulla stessa scia procede Learning, la strada si fa meno faticosa la meta sembra ora meglio definita. Ma i ragazzi ad andare dritti non ce la fanno e l’inizio di More presenta già salite ostiche e prepotenti ostacoli lungo la strada, sempre più difficili da evitare in King Time’s Dilemma. Macigni pesantissimi crollano sulla mia testa, ma rimane la forza di una band che (al di la delle mia difficoltà) riesce ottimamente a intrecciare durezza, melodie, repentini cambi di tempo e di dinamica.
La band è ottima, dunque nessun dubbio. Ha lavorato tantissimo (quasi 10 anni!) su questo progetto e ha ottenuto un risultato straordinario: compatto, vario e deciso. Sicuramente un gran bell’esordio che sarà molto apprezzato dagli appassionati delle sonorità prog-metal. Certo, non è un disco da cui si possa salvare un singolo o un disco da ascoltare mentre si prepara cena o nel traffico di rientro da lavoro. Non è il disco che mi fa viaggiare sconnettendo il cervello o meglio connettendolo al cuore. Mi ritrovo costretto a prendere il binocolo per osservare lontano. Al di là delle montagne e delle nuvole, aguzzo la vista in cerca di qualcosa che alla fine dei 50 minuti non ho proprio trovato.
The Distractions – The End Of The Pier
Un bel disco che potrebbe anche essere nato postumo, un disco che può fare i conti con il passato e vincere al primo round senza tentennamenti, senza forzature di sorta. Gli inglesi The Distractions con Mike Finney al timone arrivano con “The end of the Pier” a santificare la scena old-british (trent’anni di carriera tra disfunzioni, liti e incomprensioni) con un formulato che cambia qualche virgola della loro identità sonora di sempre, sound e ballate malinconiche, uno spirito punk abbandonato da tempo immemorabile e la sincera onestà di stare sulle scene d’ascolto con la tranquillità di chi non ha più nulla da perdere, di chi si accontenta di essere arrivato fin qui.
Comunque la classe dei The Distractions è immutata, la consolidata vibrazione sonora che lasciano al loro passaggio è sempre viva e melodica, una band “con gli anni sulle spalle” che sembra ringiovanita a dismisura, carica di quella nostalgia positiva e mai piagnucolosa come potrebbe sembrare e che fa equilibrio tra romanticismo british compassato e quella verve dolciastra che scivola in gola e negli orecchi come un unguento di lunga vita, di ineludibile simpatia; dieci tracce per una scaletta omogenea e rilassante, rock agevole e non aggressivo, ballatone inclini al piacere solitario e che trovano nel calare della sera il loro momento migliore per essere gustate, per essere inserite nel tepore dei ricordi.
Tante le emozioni che ondeggiano qua e la, nelle – dicevamo – ballate senza tempo “Wise”, “When it was mine”, “Man of the moment”, vicino alla poetica soffusa di una confidenza tenera “100 times” o nell’eco melodico di una chitarra che suona lontana tra innamoramenti non corrisposti “Too late to change”; si, i primitivi rimbombi punk non ci sono più, ma covano nei sottoscala del passato di questa formazione che, nonostante l’età, rimane qui a battere cassa, non per arrancare hit parade ma per far presente che i vecchi leoni non sono da rottamare, ma assolutamente da rispolverare per saggezza.
INVERS – Dal peggiore dei tuoi figli
Il primo disco per i biellesi Marco Barberis (voce, chitarra), Mattia Iuliano (voce, chitarra), Enrico Barberis (basso) e Mirko Losito (batteria). Né belli, né simpatici. Elegantemente vestiti male. Dopo ogni concerto, sempre e comunque sudati marci. Spontanei e diretti nella presentazione come nella musica. Il classico disco di pancia, senza troppi fronzoli, che va avanti bello dritto unendo ritmi disco e post-punk. Sul charleston in levare testi in italiano. Parlano di un’attualità in crisi e del lato nascosto, quello più marcio, di situazioni comuni. Il tutto raccontato dallo sguardo di chi ci è dentro in prima persona.
Il punto di forza della band sono sicuramente i testi. Di facile comprensione, immediati e raramente scontati.
Musicalmente però la band è carente. I ritmi sincopati sono ridondanti e spesso troppo simili tra un brano e l’altro. Ripetitivi anche i suoni e gli arrangiamenti delle chitarre. La musica non è smossa nemmeno dalle melodie di voce che, al fine di raccontare le storie scritte dalla band, non si sbilanciano (giustamente) dal parlato. Nel disco anche un azzardato rifacimento di Mio fratello è figlio unico. Prese ad una ad una le canzoni sono piacevoli ma nel complesso il progetto non scorre, risulta pesante e monotono. L’unica svolta si ha in Nella stanza azzurra un misto di post-rock e sperimentale in stile Mogwai.
Dal peggiore dei tuoi figli è un album acerbo. Il genere scelto dagli Invers non è di facile ascolto e senza degli arrangiamenti più variegati la band rischia di risultare noiosa.
Rimane sicuramente un buon inizio, come l’evidente ricerca di uno stile personale.
Probabilmente è sul palco che danno il loro meglio sempre e comunque sudati marci.
Indastria – I Giorni Del Pelo
Gli Indastria sono una delle band più esplosive ascoltate in questo tremendo e nauseabondo anno, vi presento il loro disco I Giorni Del Pelo. I Giorni Del Pelo prende ispirazione almeno nel nome da una festa alcolica organizzata qualche tempo prima dal chitarrista mentore Francesco Casagrande, avere pelo significa essere molto resistenti alle ubriacature, infatti nella cover del disco è raffigurato un orso polare come simbolo più rappresentativo dell’avere “pelo”. Una festa a base di pelo potrebbe essere intesa in maniera diversa ma ognuno è libero di portare il proprio pelo come desidera. Ok, parliamo del disco. All’inizio avevo il sospetto molto concreto di trovarmi davanti al classico lavoro demenziale e coglione al quale dovevo dedicare anche del tempo per apprezzare la stupidità, per trovare un inesistente motivo per consigliare il disco, per fare il critico alternativo dei miei coglioni. Cazzo (e qui ci sta veramente tutto intero), I Giorni Del Pelo è una bomba! Gli Indastria sono troppo potenti, un lavoro direi quasi esemplare, quello che non ti aspetti di ascoltare tutto d’un tratto ti arriva addosso come un tir impazzito. Musica matta che ti conquista subito e ti spacca il cervello, testi spaventosamente geniali, provate ad ascoltare Orso Polare Droga e poi cercate di spiegare se l’alternativa e tanto super considerata scena italiana sarebbe riuscita a tirare fuori un pezzo così. Il disco composto da dieci pezzi certamente non riesce a reggere il ritmo per l’intera durata de I Giorni Del Pelo, non sarebbe umanamente possibile e loro sicuramente non sono i Tool ma evidenziano una naturale vocazione al caos. Sono molto stoner/punk incazzati e sono talmente fighi che quelle canzoni le potrebbe cantare anche mio nonno, sullo stile delle vecchie punk rock band italiane ma molto ma molto più duri, potrebbero aver preso lezione dal primo Teatro degli Orrori.
Cercateli su facebook e scaricatevi gratuitamente il disco, vi renderete conto che non si mangia solo merda in Italia. Adesso che la foga dell’impatto iniziale è passata lasciamo scorrere qualche minuto e rivediamo il disco degli Indastria con una migliore lucidità. Sempre la stessa cosa, un tir impazzito che mi passa sopra. Certamente più che alla tecnica gli Indastria devono ringraziare la potenza che riescono a sprigionare, non è poco e soprattutto non è da tutti e per questo motivo sono rimasto colpito in maniera positiva da questa band, spero di non sbagliarmi ma la semplicità quasi sempre è alla base delle cose belle. Loro attualmente sono tra i più belli e semplici che potevamo aspettarci di incontrare.
UFO Romeo – Divergenze Emozionali Ep
Qualche tempo fa i Velvet suonavano “Soffro lo strees, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma, suono in una boy band, suono in una boy band, ci deve essere un errore.” E chi pensa che il tempo delle boy band è finito deve ricredersi. Da Roma, freschi freschi con il loro nuovo EP Divergenze Emozionali, Marco Ambra alla voce, Antonio Di Girolamo alla chitarra, Valerio Galassi alla batteria, Fulvio D’Alessio alla tastiera e Flavio Quintilli al basso sono gli UFO Romeo. Dalla loro pagina FB si definiscono: “Folgoranti, ironici, leggeri,amabili, spumeggianti, assolutamente alieni”. Che dire gli ingredienti ci sono tutti e la carica non manca.
Con 5 pezzi, scattanti e vaporosi, questo EP mette fuori una sfera affettiva giovanile fatta di imprudenza e classica spensieratezza dove i rapporti perdono molta consistenza e viaggiano sull’onda delle emozioni momentanee e transitorie. Come accade in Sesso Take Away il primo brano dell’album che potete ascoltare su rockambula.com“…non voglio più perdere la ragione nelle tue illusioni… senza rimpianti e lacrime…. Divertiti e usami”.E così scorre tutto l’album, tra insicurezze, motti giovanili e chitarre distorte a un ritmo tutto da sBallo. Niente di eccezionale, 5 brani, 5 ragazzi che inseguono il sogno della rockstar e della dolce vita. Un prodotto standard, troppo POP. Ascoltandoli mi tornano in mente i Luna pop con la 50 special. @#°§;@[@#ò. Ma loro sono gli UFO Romeo. Oddio non ce la faccio mi serve il cesso…………
Flyzone – Hard Day’s Morning
E’ un dato di fatto: a Roma il rock è vivo e vegeto. La sua intenzione è potente, viscerale, avvolgente. Non esiste dunque solo l’artista semi impegnato e genuino arroccato alle osterie di Trastevere, ma esiste anche un’anima più animale, più rumorosa e più sfacciata.
Si forse un po’ troppo sfacciata se si guarda questo caso in particolare. I Flyzone sono un giovane quartetto ben determinato ma dalle idee un po’ confuse. Si presentano con questo EP dove mischiano senza troppo riguardo le atmosfere cupe e la disperazione del grunge, chitarroni crossover (dal suono molto discutibile), assoli mirabolanti e l’epicità del metal powerone. Il risultato in realtà non è tragico quanto potrebbe sembrare a parole, ma fa spesso storcere il naso per il catastrofico scontro tra correnti.
Il pastone si presenta subito dall’attacco di “Katrina” che più che un uragano che punta a spazzarci via sembra una palude di sabbie mobili nel quale ristagniamo. L’ingrediente più azzardato della ricetta è indubbiamente la voce di Danilo Garcia, poco graffiante e incisiva. Più attenta a raggiungere il sustain e la tecnica di Bruce Dickinson che arrivare a graffiare la nostra pelle. La convinzione non manca, ma le corde vocali non sono poi di certo coadiuvate dall’interpretazione, frutto anche di un inglese sfoderato in modo troppo scolastico, poco fluido e diciamo pure “maccheronico”.
“The qube” fa il filo agli Alterbridge più melensi, l’energia si mantiene potenziale ma non viene mai sprigionata con la giusta foga. Qualche faticoso passo in mezzo alla palude riusciamo a farlo grazie a “Black Blood”: si sentono in lontananza i respiri dell’ultimo grunge e il sapore di rivoluzione grezza e verace prende vita in un riff confuso tra doppia cassa e distorsione eccessiva. La speranza però in questo brano prende vita e delinea comunque un sentiero che la band dovrebbe intraprendere in modo da ottenere la sua entità.
Dopo questo felice episodio però si torna ad affondare e l’ultima parte dell’EP è alquanto noiosa. Pensavamo di essercene liberati e invece rispunta sorniona la strega epic, che prende le redini nei ritornelli di “Wake up” e “In my opinion”.
Il finale è invece dedicato a “A Clockwork Orange”, di cui la band è grande fan. Ballatone semi-acustico difficile da digerire nella sua integrità: stacchi elettrici improvvisi, dinamica totalmente dimenticata e disperazione lamentata per quasi 6 minuti di canzone. Nelle sabbie mobili qui veniamo inghiottiti totalmente e non arriva neanche più uno stimolo, un guizzo che possa farci vedere la luce.
Flyzone sono una band giovane, determinata e sicuramente pronta tecnicamente. Ed è proprio per questo che nell’immediato futuro aspettiamo da loro una mano che ci faccia riemergere da questa immobilità e ci porti in viaggio, molto lontano da questa palude.
Novadeaf – Humoresque
Humoresque oltre ad essere una raccolta di brani brevi per pianoforte del compositore Antonín Dvořák è anche l’album dei pisani Novadeaf capitanati dal cantante Federico Russo. A dire il vero sono rimasto un tantino spiazzato dalla presentazione del disco scritta proprio dal Russo, nel senso, non riuscivo a capire bene quali storie si intrecciavano dietro questo lavoro. In effetti la presentazione non risulta di facile comprensione, per fortuna noi dobbiamo parlare di musica. I Novadeaf suonano un buon indie pop prevalentemente di matrice britannica, ovviamente cantato in inglese e sicuramente pensato e registrato per dare questo effetto. Il secondo pezzo It Ends Whith A Smile sembra essere una vera e propria bomba scoppiata sulla faccia, adoro le aperture della chitarra e la voce sporca di new wave, un mastering di caratura più elevata avrebbe sicuramente migliorato e di molto l’effetto potenza sprigionato dal brano. Ma non si può certo avere tutto dalla vita. Subito dopo la bomba arriva inevitabilmente il silenzio raccontato nella canzone Man of Fire, ballatona troppo stile REM dedicata apertamente alla vera storia dello scrittore omosessuale Alfredo Ormando, ma una ballata è sempre una ballata nonostante i propri difetti.
Poi improvvisamente le chitarre diventano americane e Bon Jovi s’impossessa dell’anima dei Novadeaf in Axolotl e per l’intro e qualche parte di Fall From Grace Together che altrimenti sarebbe stata veramente un’ottima song tirata da un basso massiccio, una batteria impeccabile e una voce emozionale. Parecchie similitudini ritmiche con i primissimi Police e questo non è certo un difetto dal quale nascondersi piuttosto un punto fermo sul quale fare forza. Humoresque continua il suo percorso fino alla fine regalando bellezza e qualcosa di veramente brutto, un disco che non riesce a trovare il proprio equilibrio interiore nonostante le buone premesse ci sono tutte, tecnica e orecchiabilità sono la forza dell’intero concept. Ognuno di noi dovrebbe avere il coraggio di prendere delle decisioni convinte e determinate evitando di scendere a compromessi artistici privi di qualsiasi sostanza.
Dei Novadeaf ho saputo apprezzare la grinta che riescono a trasmettere e meno il sentimento interiore dei brani, non mi emoziono davanti a nessuna canzone di Humoresque ma sicuramente mi fanno venire voglia di far saltare il collo.
Divine Fits – A Thing Called Divine Fits
Tre nomi che nel circuito alternative Americano dicono molto. Dan Boeckner (Wolf Parade), Britt Daniel (Spoon) e Sam Brown (New Bomb Turks) danno vita ad una nuova combinazione sonora che prende il nome Divine Fits e “A thing called divine fits” ne è il logico debutto discografico, disco che scava nell’elettro-rock con brani stuzzicanti, cantati con il tic wave e suonati con piglio robotico, angoloso e di rimando Ottantiano, una tracklist dall’effetto sorprendente che sforna – a ritmo convulso e spasmodico – una personalissima originalità che regala punti a molti.
Non si sostituisce nulla di dimissionario, solamente una voglia matta di creare un “passato per il futuro”, ripercorrere storie, suoni e caratteristiche di una epoca seminale, portando a bordo le “fantasmerie” lussuose di Talkings Heads “For your heart”, nuvolette di Bolan “Baby get worse”, il Duca Bianco “My love is real”, “ Whats gets you alone”, e tutte le dominose sonorità mid-disco e rock piene di energia, glam e ricordi a go-go; un progetto questo dei tre musicisti che è già un fenomeno conclamato ovunque – forse qualche imprecisione nell’intelaiatura generale – ma è la spinta generale ha farla da padrona, ed allora tutto quello che viene è roba fine, roba su cui ballarci sopra è un bel gioco ringiovanente e tonicizzante.
Loro le liriche e l’ordito totale, una tracklist “mossa” al cento per cento che non da pace a muscolarità allenate e da incubi a giunture anchilosate, ma sono soprattutto gli episodi “lounge” a prendersi tutto per loro l’interesse dell’ascolto quando si giunge a metà scaletta, quelle ballate pop.field che rispondono al nome di “Civilian stripes” e “Shivers”, due rubini sonori messi a far riprendere fiato da tanto affanno dance e che impreziosiscono in surplus il già apprezzabile risultato di tutto il resto. Ma forse il bello di questa nuovissima triade deve ancora venire, per il momento in cui ascoltiamo questo bel giro di sonorità vintage, il futuro del passato pare già arrivare e non “ascoltiamo” l’ora di veder arrivare un nuovo disco che – come crediamo – spiazzerà ulteriormente la scena internazionale come pochi. Garantito!
S.M.S. – Da qui a domani
Torna sulle scene portandosi dietro tantissime aspettative l’ex frontman dei Diaframma Miro Sassolini, la band che lo accompagna in questa nuova vicenda si chiama S.M.S., un collettivo musicale formato da gente come Cristiano Santini (ex Disciplinatha), e la poetessa Monica Matticoli (dalle iniziali dei loro cognomi S.M.S.) e la collaborazione di Federico Bologna (Technogood e Armoteque). Il disco uscito sotto etichetta Black Fading Records prende il nome Da qui a domani, un lavoro troppo intenso per lasciare secca la gola, un racconto in versi meritevole di ripetuti e sofisticati ascolti. Monica Matticoli regala belle parole a Miro Sassolini al quale non resta che cantarle con la propria voce indelebile, una delle migliori voci italiane di sempre, e non solo new wave. Di sempre. Negli ultimi tempi fatta eccezione per qualche isolato caso si era persa la concezione di musica di spessore, tutto stava girando attorno alla semplicità e al beffardo stile compositivo dei moderni cantautori italiani ai quali la vena artistica sembra mancare del tutto, nei loro testi appare una sconcertante struttura poetica e le loro canzoni sembrano appartenere ad una generazione senza futuro, un pianto senza fine. Gli S.M.S. mantengono sempre una linea musicale minimale, tanta elettronica inserita da Federico Bologna, la precisione della semplicità d’esecuzione risulta essere arma vincente per la riuscita del disco. Miro Sassolini torna a grandi interpretazioni, tutte le attenzioni sono per lui, Giovanni Lindo Ferretti in stato di grazia ma senza il dannato fascino della new wave nelle corde vocali.
Nel pezzo di apertura Sul Limite Monica Matticoli ci regala un caldo e sofisticato reading d’introduzione al disco e subito si ha la percezione di quello che realmente sarà Da qui a domani. Poi i colpi di scena sono tantissimi, l’ascolto di una traccia comporta la grande curiosità ad ascoltarne la seguente lasciandosi intrappolare in un circuito vizioso. Tanta elettro music in pezzi come In Quiete, molta atmosfera e la voce viaggia su intonazioni alla Franco Battiato. Ma ascoltando bene quel Miro Sassolini ricorda tantissimo quello di Tre Volte Lacrime, non si discute.
Ce spazio anche per la dolcezza in Disvelo e Rimane addosso la veste lacerata del risveglio, molto emozionali e trafiggi cuore, i testi giocano un ruolo importantissimo come del resto per tutto il disco. Esageratamente bella la ballata trip-hop A Nudo, modernizzazione del sound dei CSI in Petite Mort.
Da qui a domani è un disco attuale con evidenti influenze del passato e del personale bagaglio artistico dei componenti della band, una delizia dei sensi per chi vuole lasciarsi trasportare da queste atmosfere, la voce profonda di Miro Sassolini dona la vita ai bellissimi testi di Monica Matticoli, una combinazione vincente, un risultato quasi garantito.
Ho sempre amato Miro Sassolini, sono anni e anni che apprezzo le sue interpretazioni, ero certo che il suo ritorno discografico non poteva affatto deludere. Da qui a domani diventa immediatamente una delle migliori uscite discografiche del 2012, Miro Sassolini è l’artista che non delude mai, Miro Sassolini ha cambiato il modo di cantare in maniera significativa.
Space Paranoids – Under The King Of Stone
Nati nel cuneese nel 2006, l’attuale compagine degli Space Paranoids prende forma solo lo scorso anno, dall’incontro tra Simone Rossi (voce e percussioni), Cristiano Rossi (basso), Luca Bruno (batteria) e Andrea giostra (chitarra e voce). Da quel momento in poi, lo spirito dei quattro li porterà verso la ricerca di un possibile futuro per certe sonorità in fondo forse anche troppo datate per le orecchie di noi divoratori di dischi. Partendo dall’universo Stoner che fu terra di grandi quali Kyuss, Queens of the Stone Age e Clutch e dal mondo psichedelico e spaziale di Monster Magnet, Colour Haze ed Earthless il loro obiettivo sembra essere quello di trovare la strada per unire il passato con i luoghi del loro presente fatto di scabri territori di montagna, pinnacoli imbiancati, macchie inviolabili, specchi d’acqua tersi e culture morenti, con l’unico scopo di cercare la catarsi attraverso la decantazione spirituale. Una sorta di viaggio allucinogeno nei deserti della California trasportato nei territori del nord dell’Italia. Il tutto registrato in presa diretta per dare maggiore convinzione alla durezza del suono.
I sette brani che compongono Under The King Of Stone sono un tripudio alle contaminazioni, ai rimandi, alle citazioni (spudorata quella in “Called Goblins Haze”. Avete indovinato?) eppure il loro non è per niente un lavoro spiacevole. Trasuda la consapevolezza di un background culturale musicale di un certo spessore e l’esecuzione dei quattro è impeccabile (senza dimenticare la partecipazione di Tommaso Fia e la sua Hammond nei brani “Under The King Of Stone” e “Blind Cyrus”) oltre che energica e potente, come si conviene per il genere, pur senza l’apporto della seconda chitarra (se non in casi rari). I quattro riescono a produrre esplosioni sonore imponenti che non sfociano mai in distorsioni eccessive e l’ampio spazio lasciato alla strumentazione di contorno, basso e batteria su tutti, non fa altro che intensificarne la furia. Veramente interessante il lavoro alle quattro corde di Cristiano che riesce a reggere le ritmiche anche nei momenti di pausa necessari alla fluidità della narrazione sonora.
Non si può non applaudire inoltre la voce di Simone Rossi che per quanto manipolata, detto tra virgolette, riesce pienamente a rendere l’idea di quello che è l’obiettivo della musica degli Space Paranoids e soprattutto riesce a evocare paesaggi torridi e gelidi nello stesso tempo e a saltare dalle diverse variazioni sul tema con estrema convinzione senza mai diventare prevaricatrice nei confronti del resto.
Tra i sette passaggi del viaggio, parecchio avvincente è “Black Salamander”, in cui la chitarra di Andrea Giostra si presenta acidissima e pesante nello stesso tempo, quasi sfiorando giri funky.
Il mio brano preferito (di questi primi ascolti) è invece “Blind Cyrus”, il meno Hard e più Blues del disco, soprattutto per il suo ritmo soffocante e ossessivo in contrapposizione con la voce carnale, calda, spirituale e profonda di Simone. Interessanti anche i passaggi di chitarra e Hammond, che danno al brano un senso di esplorazione psichica molto sixties.
Chiarito che non ritengo un problema, la scarsa originalità quando il lavoro è ben fatto, ci sono alcuni punti però che non convincono. Per prima cosa, credo che sarebbe stato opportuno dare un’impronta ancora più acida e lisergica al sound dell’album. I passaggi psichedelici di vecchio stampo sono molto pochi e non riescono a dare quel necessario senso di completezza. Molto più marcata, è la natura Hard Rock che, in combutta con le ritmiche e il cantato Stoner, finisce per tagliare fuori quegli aspetti psico-space, oltretutto richiamati evidentemente già dal nome stesso della formazione, che avrebbero certamente dato maggiore corpo a Under The King Of Stone. Penso ad esempio alla title track, che per quanto eseguita con una certa intensità, finisce per durare fin troppo (oltre sei minuti annoiano senza opportuni cambi di ritmo) in relazione all’idea di base del pezzo.
Molto più interessante invece, sotto quest’aspetto, “Electric Rotor Crossroad”, che col suo intro strumentale e il muro di chitarre che segue, finisce per ricordare anche un tipo di Post Rock stile Mogwai, anche se presto reindirizzato verso i lidi bollenti dello Stoner.
Un altro problema che ho trovato troppo seccante e vitale per essere ignorato è quello della registrazione. Preciso che registrazione e mixaggio sono opera di Massimiliano “Mano” Moccia al Blue Records di Mondovì e la masterizzazione di Niklas “Mr. Dango” Kallgren al Bombshelter Studio di Orebro. La cosa è evidenziata soprattutto dal brano “Deadmouth Monk” che oltretutto presenta un ritmo di chitarra tanto semplice quanto straordinario. Rispetto ai primi brani, il suono sembra farsi ancora più fumoso e i toni della registrazione sembrano perdere colore, tanto che, se ascoltati attentamente, alcuni pezzi non sembrano poter far parte dello stesso album. L’effetto non è, evidentemente, voluto.
Ultimo necessario riferimento al brano che chiude l’album, “Ordesa Sky Hunters”, il momento più soffice, intimo, rilassante, narcotico, anche se l’impeto torna prepotente già dalla fine del secondo minuto.
Under The King Of Stones è l’album perfetto per chi ha amato quei gruppi cui ho fatto riferimento nella prima parte, perfetto per chi non guarda di buon occhio chi esagera ed esaspera le innovazioni, per chi ama la musica ben fatta, possente, impetuosa e vigorosa, per chi ama il South statunitense, i suoi deserti e la sua magia.
Gli Space Paranoids, decidono di puntare sulle loro origini per arrivare a voi. Origini territoriali, montagne, freddo e alberi e origini musicali, soprattutto anni novanta. E poi, pura e semplice espressione artistica. Sono questi gli ingredienti di Under The King Of Stones. Origini ed espressione artistica. Solo da qui è possibile raggiungere se stessi.
Soul Revolution – People
La musica quasi sempre racconta storie, di vita, di amore, di morte. Quasi sempre racconta di qualcosa o qualcuno, del desiderio o della sofferenza. Si staccano dal brutto concetto di cover band i Soul Revolution e registrano un disco d’inediti variegati chiamato People. I Soul Revolution sono un duo acustico formato dalla cantante italo/inglese Deborah Baratelli che non potendo dare risalto alla propria appartenenza anglosassone si modifica il nome in Dee Bee (che forse farà più indie) e dal chitarrista Fabrizio Scafetti. Bene, prima parlavamo del passato da cover band di questi ragazzi dal curriculum interessante e stizzoso, loro hanno girato la capitale tra teatri e locali per proporre la propria interpretazione di cover internazionali cantate in ben cinque lingue! (italiano-inglese-francese-spagnolo-portoghese). Sicuramente un bel progetto poco comune, direi interessante ma non riesco a trovare un nesso logico con la voglia forzata di registrare un disco originale, è vero che l’arte si misura in originalità ma non bisogna mai varcare il confine della decenza.
Prendiamo il loro disco People e cerchiamo di capire cosa c’è dentro con estrema calma e franchezza. Il disco racconta di storie normali di tutti i giorni, come dicono loro un disco scritto tra la gente, cantato in maniera ineccepibile dalla cantante Dee Bee (ormai ti chiamerò in questo modo) e suonato (soltanto tecnicamente) maledettamente bene dal chitarrista Scafetti, le innovazioni musicali purtroppo non sono minimamente sfiorate lasciando spazio ad un caos devastante. Mancano completamente legami tra tutte le canzoni proposte, una cozzaglia di generi inverosimilmente spalmati nel disco, c’è bisogno di riprendere fiato per affrontare nuovamente l’ascolto dell’album. Swing, folk, tango, rock, tarantelle e tarantolate, capricci e depressione, voci angeliche turbate, insomma, l’inferno di Dante nel cerchio degli adulatori (questa volta musicali). Con pazienza quasi record porto a termine l’ascolto di qualcosa che poteva essere molto ma molto meglio, bisognava lasciarsi andare al sentimento personale dei musicisti, si è giocato ad una sorta di “butta tutto nel calderone” senza buoni risultati, si è pensato troppo alla tecnica e poco all’armonia dei riff sempre troppo ingessati.
People racchiude l’essenza della strada ma non riesce a tirarne fuori le verità, un modo troppo chiuso e condizionato ruota attorno ai Soul Revolution, Dee Bee (continuo ad evocare la figaggine British) e Fabrizio Scafetti avrebbero bisogno di suonare musica in maniera meno sintetica dimenticando per una volta programmi televisivi e smanie allunga curriculum. La musica è prima di tutto verità, il resto purtroppo è solo merda.