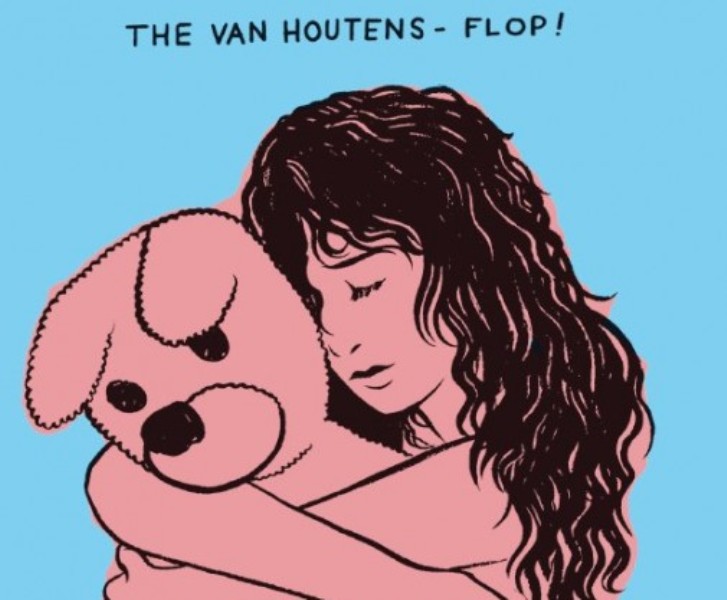Avviso importante!!! Questa recensione non parla di musica, Pino Scotto non parla di musica, nessuno parla di musica perché della musica non frega un cazzo a nessuno!
Pino Scotto è un enorme generatore di luoghi comuni, questa è la prova. Provate a tirare fuori il suo nome e tre saranno le attente valutazioni che verranno fuori. Non una di più. “È un pagliaccio buono a nulla”, oppure “è un mostro televisivo” o ancora “in passato è stato un grande rocker”.
Quale sia la realtà dei fatti lo sa, forse, solo lui stesso. Io posso unicamente dirvi come la penso. Non lo trovo un clown bravo in nonnulla. In fondo, per suonare, strimpella meglio di tanti sbarbatelli che mi è capitato di sentire, di quelli che si prendono troppo sul serio, non sanno accettare le critiche e sono convinti che la loro sia la migliore robaccia partorita dal culo dell’Italia negli ultimi ottomila anni. Forse è piuttosto un burlone che è stato molto bravo a vendere in tivù una macchietta che con la musica ha meno a che fare di quello che vuol farci credere. Pino Scotto se la prende con tutto un universo mediatico che in realtà è il suo cosmo (almeno in piccola parte, visto che quando ha provato a fare passaggi più complessi, come da Chiambretti, la sua figura di “big crazy” è risultata non solo ridimensionata ma addirittura compassionevole. Totalmente a disagio, senza capacità di esprimere concetti pregevoli e sagaci e senza l’attitudine ad essere spassoso come invece accade a casa sua). Da un punto di vista sociologico (sottolineo la parola sociologico) non vedo molta discrepanza tra lui, Sgarbi, Er Mutanda, Richard Benson, Tiziano Crudeli, Pappalardo, Paola e Chiara e via dicendo. Tutti non fanno altro che dare alla gente quello che la folla sembra volere. Il problema della tv è che quando parla alla moltitudine di zombie non parla a individui, che magari la Tv la vedrebbero anche, se come critici (d’arte o musica), esperti del cazzocheglipare o musicisti, ci fossero propriamente le migliori menti di un paese che non voglio credere cosi stupido. Ma la tv, che ormai si è arrogata il diritto supremo di demolire la nostra bella patria dall’interno delle sue cervella, parla alla moltitudine come mero dato auditel e sa bene che una rissa tra Sgarbi, Er Mutanda, Richard Benson, Tiziano Crudeli, Pappalardo, Paola e Chiara e magari anche Pino Scotto, raggiungerebbe un picco di pubblico che mai si sarebbe potuto avere, non so, con Gottardo Ortelli che ci parla di Concetto Pozzati, con Carmelo Bene, con Lester Bangs, con Gli Area, Con Carlo Emilio Gadda, con una qualunque delle menti più brillanti che abbiano calpestato la nostra terra.
Plausibilmente Pino Scotto sa quanto la moltitudine sia stupida e sa quanto poco lui possa dare ancora alla musica, sia in ambito compositivo che in ambito critico. È per questo che decide di non fare assolutamente il minimo sforzo per dire o almeno pensare qualcosa di perspicace. Si limita a offendere tutti, si limita a vomitare luoghi comuni, si limita ad apparire (male oltretutto) invece che essere.
Il suo disco, Codici Kappao più il Live…Rock For Belize, non fa nient’altro che mettere in musica il personaggio che, costruito o meno, non è niente di più di ogni altra merdata vi caghi quel cubo del cazzo chiamato Tv.
Ora ti starai mangiando le mani perché so che vuoi dirmi. “Ma Pino ha fatto la storia del Rock italiano”.
Ma cerca di essere serio. Ha cantato con i Vanadium e poi ha intrapreso una carriera solista i cui apici sono al livello di un Vasco Rossi da ”come porti bene quei Jeans” (non ricordo il titolo di quella stronzata). Questa è la nostra storia? E Pfm, CCCP, Banco Del Mutuo Soccorso, Battiato, Picchio Dal Pozzo, Area, Csi, Massimo Volume, Faust’o, erano solo dei poveri coglioni, giusto?
Adesso prova a chiedermi che cazzo di recensione è questa, visto che non parla di musica. Ti rispondo velocemente. Primo, ti avevo avvisato. Secondo, il tuo caro Pino parla veramente di musica nei suoi inutili monologhi? Ho semplicemente dato a lui quello che lui dà agli altri. Il nulla. Per una volta faccio io lo stronzo. Scrivo il suo nome e la prima cosa che vedo è il link “Pino Scotto Sbrocca di brutto!! da nn perdere!”. Se scrivo Demetrio Stratos mi compare “cantare la voce” (vi consiglio di dargli uno sguardo). Capite dove è la differenza?
Per la cronaca, non mi si dica che non ho ascoltato gli album. L’ho fatto quattro volte, e, anche se il live riporta sulla retta via il niente del lavoro in studio, siamo ad un livello di banalità sconcertante. Classico Hard Rock con una spruzzata di southern comfort e qualche collaborazione inutile (con Bennato e i Modena City Ramblers) che quantomeno non è fastidiosa come quella con J-Ax.
Se mai Pino Scotto dovesse leggere queste mie parole, so già cosa direbbe. “Chi cazzo è questo”,” Sei una merda”, “Ti devi vergognare, coglione”, “vai a fare in culo, stronzo” e altre eleganze simili. E la cosa confermerebbe solo tutto quello che ho detto. Lui deve essere cosi perché voi lo volete cosi.
Io però me lo voglio immaginare sorridente, mentre a labbra socchiuse biascica un “cazzo, mi ha sgamato” e intanto ascolta Moving Pictures dei Rush e si gratta le palle. E forse allora potrei anche essere felice di aver sbagliato, almeno un po’, perché di cervello e coglioni ne ha più di quello che vuole farci credere.