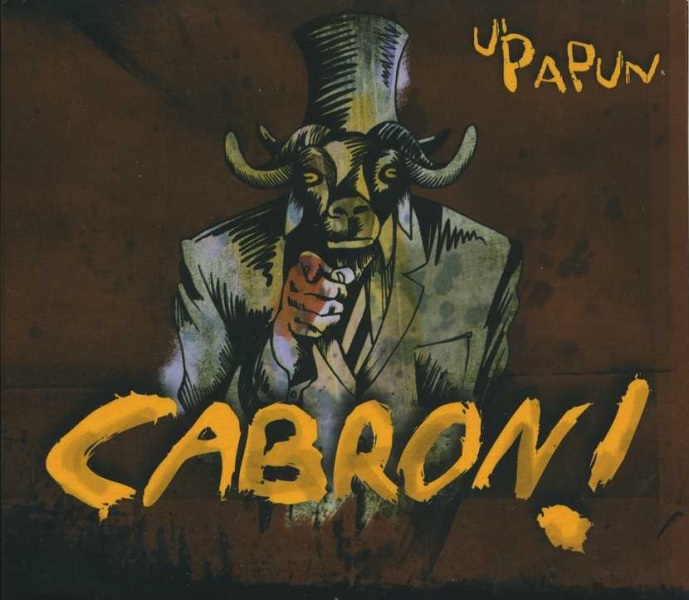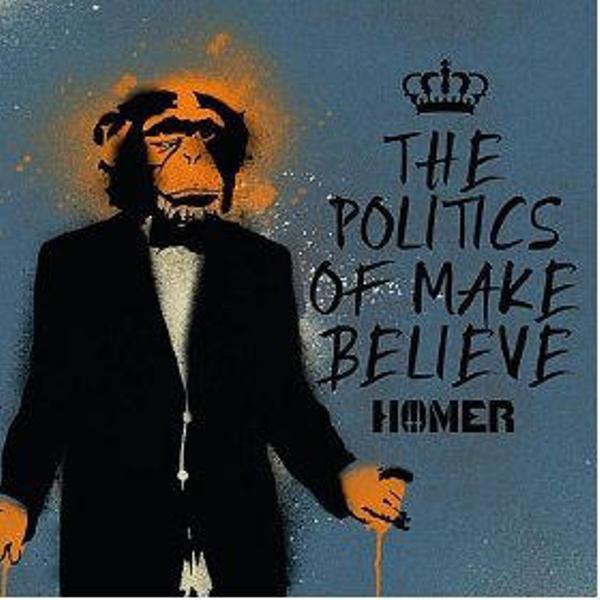Questo supporto non è un demo
Questo è il mio disco
È uno sport estremo
Questo è un album pieno di ricordi
Come quello delle foto
Questo disco è suonato da ignoranti ma pensato da poeti
Questo disco le lacrime le spacca non le strappa
Questo disco è diventato un’ossessione
Un motivo di depressione
Uno slancio vitale fatto con sana ambizione
Questo disco vale più di una tesi
Questo disco ha più di 60 mesi
Questo disco ha coinvolto più persone
Questo disco è stato una metamorfosi della mia passione
Questo disco parla di riabilitazione
Parla di un rifiuto che mi ha fatto perdere la testa
Parla di glauco e delle sue gesta
Questo disco non racconta storie ma imprime emozioni
Manca di razionalità
Disegna stati d’umore
Questo disco è la mia vita distillata in pillole
Questo disco è stato dimenticato
Ha accumulato polvere
Questo disco si chiama tenacia perseveranza
Questo disco si chiama faccia tosta di meritare una speranza.
Vetrozero
Tutto troppo facile. Tutto troppo lineare. Che aggiungere alle loro parole? Qualcosa si può. I Vetrozero scelgono la strada più pulita per il successo. Non sempre la preferibile. Formazione classica voce/chitarre/paranoie Glauco Gabrielli, basso Alessio Zeni, Batteria Daniele Bonvecchio (ai quali vanno aggiunti il pianoforte di Jacopo Mazzonelli, il synth, il flicorno di Christian Stanchina e l’extra della voce di Emanuele Lapiana. Scelgono il bianco puro. Scelgono un sound senza esuberanze, senza rumore, senza sperimentazioni, con un cantato in lingua italiana ben esplicitata. Tutto sembra oltremisura perfetto. Poi apri il supporto candido e ti vedi una foto di una famiglia di manichini senza testa in posa da tipica immagine da appendere al muro di casa, con donne e bambini con vestiti biancastri e il primogenito in uniforme. Quell’aria di eccellenza sembra schiacciarsi. Non tutto è come sembra, se si scende nel profondo delle cose, se si scarta la plastica che avvolge persone e situazioni potreste trovare qualcosa di più (bello o brutto). Poi però c’è la musica oltre la poesia. Ma poi ne parliamo. I Vetrozero scelgono un titolo “Temo Solo La Malattia” che sembra una presa di posizione, ben precisa. Ho bisogno di voi, ma in fondo non mi frega un cazzo di voi. Una razionale superbia che sembra quasi un modo per convincersi che qualunque critica non abbia la benché minima importanza. Ma anche una profonda dichiarazione di forza contro le ostilità della vita. Un modo di prendere la realtà senza ansie e preoccupazioni, come adepti di una pseudo personale religione ascetica. Ma poi c’è la musica. Ci vogliono sei anni prima che la band trentina si decida a renderci partecipi delle loro trepidazioni. Questo disco non è un demo ma l’album d’esordio di una band che vede Glauco Gabrielli prendersi gran parte delle responsabilità. È un disco estremo perché punta su una musica talmente semplice, ricamando a voce e parole il ruolo centrale, che il rischio diventa quello di essere ignorati. Se si ascoltano attentamente le definizioni, ci si rende conto di quanto sia confidenziale quest’album, tutto incentrato su ricordi, emozioni, sofferenza, ossessioni, lacrime, poesie, speranze, ambizioni, passioni mutevoli. Troppo riservato probabilmente. Il problema è che la musica non tiene abbastanza il passo. Il fastidio è che i testi non sono abbastanza empatici. Non si riesce a immedesimarsi nei sentimenti di chi canta, non si riesce a emozionarsi con una musica tanto banale. Per capirci parliamo di un Pop-Rock classico, con la voce in primo piano e la batteria che segue a ruota, che manca quasi completamente di accelerazioni tanto che la chitarra finisce per fare da comparsa. S’inizia con “Grisou”, brano figlio del Pop anni novanta italiano. Un platonico brano anni novanta, direi, in stile Raf per intenderci, che segue uno schema troppo preciso per suonare moderno o emozionante. Potremmo rifugiarsi nel testo ma la rogna è che per prima cosa, stiamo parlando di musica e non di letteratura. Seconda cosa…poi ve la dico. Il secondo brano, Biarso, inizia con un ritmo molto più cadenzato, fresco e solare. L’aggiunta del pianoforte serve quantomeno a dare maggiore dinamismo alla musica ed anche il cantato e la melodia risultano più accattivanti.
Il Mostro, scelto come singolo dai Vetrozero, ci dona una più intensa speranza, con un’intro che suona come qualcosa che ti fa sperare che il brano continui cosi fino alla fine. Alla strumentazione classica si aggiungono il synth e soprattutto la potenza dei ragazzi del profondo nord. Alla fine un bel pezzo (anche se ricalca eccessivamente, in alcuni punti (e se devo dirvi quali, chiedete pure) lo stile Subsonica) sul quale forse si poteva anche lavorare con più cura. In Treno Freno si torna su binari più classici. La voce di Glauco passeggia sotto braccio alla chitarra che quasi sembra di ascoltare Riccardo Sinigallia (e questo è un complimento) e il sound diventa sempre più pieno, quasi come Verdena particolarmente sentimentali e intimi, nel cammino verso l’orizzonte. Tralasciando Contagocce, passiamo direttamente a Io + Solo – Vivo. Si parte con un accenno di Folk Rock e poi tutto diventa una specie di citazione volontaria o meno ai Litfiba, sia nell’aspetto musicale, negli assoli di chitarra, che nell’impostazione vocale e nelle parole di pelle sussurrate da Glauco. Soffiando Contro Vento, pezzo centrale di “Temo Solo La Malattia, rappresenta il cuore dell’opera, sia per la sua posizione nella tracklist che per le pulsazioni nervose della linea di basso e sia per il tema particolarmente passionale. Ultra Intro, parte bene come in un accenno Trip-Hop, ma poi si risolve in una melodia molto più rassicurante. Il risultato è comunque interessante perché la musicalità per quanto semplice è molto orecchiabile soprattutto in combutta con il ripetersi ossessivo e delizioso del basso e l’aggiunta eterea del flicorno. La seconda parte del disco diventa molto più spirituale della prima. Emodinamica dilata le atmosfere cosi come Una Pistola Non Dice:- Salve! la carica di elettricità. Solubile (cantata in collaborazione con N.A.N.O., dei C.O.D.) è palesemente una sorta di elegia dell’aspetto lirico. La musica si riduce all’ essenziale ed echeggia dietro la gigantesca presenza vocale. Il disco si chiude con Ninna Nanna. E non è una bugia. Il pezzo è davvero una ninna nanna, parla di sogni e suona di sogni, leggere, le parole di Glauco si sdraiano su note bianche e fluttuanti e vaporose di pianoforte. Che dire. Mi è piaciuto? Non so. La formula proposta è abbastanza lontana dai miei gusti, rispecchia molto stereotipi eccessivamente ripetuti nel mondo della musica italiana. La musica stessa suona come una suppellettile giacché la voce e le parole si prendono tutto il palcoscenico. Dovrebbe esserci maggiore attenzione agli aspetti strumentali o comunque, se vorranno continuare su questa strada, quantomeno migliorare la ricerca melodica. Sono davvero pochi i passaggi degni di nota e non ci sono ritornelli o giri di basso, o melodie che ti s’inchiodano a fondo nel cervello. Quello che traspare è che, da parte dei Vetrozero, c’è tanta voglia di esprimersi, senza paura di sentirsi nudi a mostrare il loro fragile e al contempo prezioso equilibrio sentimentale e interiore. Questo significa che la loro musica trasuda anima e non è poco. Diffido più dei venditori di note che dei sognatori. Il problema è che per essere apprezzati non basta prendere il cuore e gettarlo in pasto ai lupi. Serve altro. Credo Che Glauco, Alessio e Daniele possano fare di più e forse lo sanno. Sanno che arrivati alla curva, a tutta velocità, per essere davvero bravi, essere diversi da tutti, è necessario andare avanti e lanciarsi dal dirupo, magari spalancare le braccia e provare a volare. Non serve svoltare come tutti. Forse ci hanno pensato troppo e questa curva è passata. Ma siamo in montagna. Di curve ce ne saranno tante.