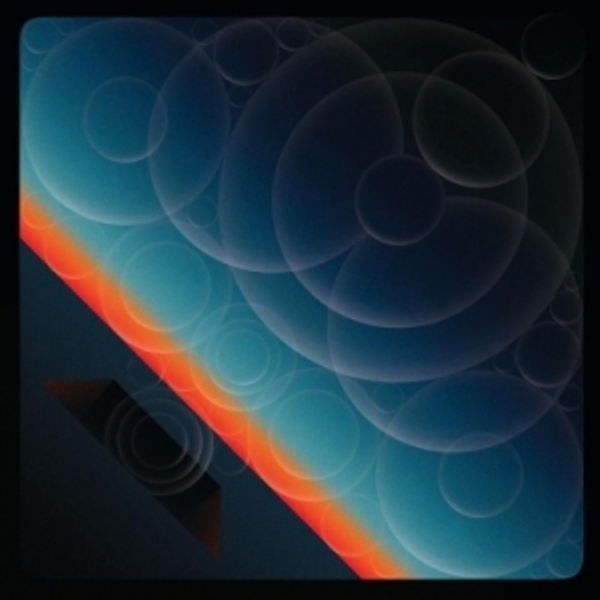La prima cosa che picchia nella testa, quando ci si ritrova davanti ad un gruppo come gli X-Mary è sicuramente un certo tipo di attitudine propria dei folli. Loro sono come quell’amico squilibrato che tutti abbiamo, che non si rade la barba da mesi, che si lava poco, che si sfonda di birra e poi si mette a far casino; che prende per il culo tutti ma devi sforzarti per capire se sta prendendo per il culo proprio te; quello sagace che sembra un ebete; quello che fa l’idiota con intelligenza; quello che non riesce a trovare una ragazza perché forse non esiste una che riuscirebbe a stargli dietro; quello che è sempre ilare e ti mette incessantemente di buon amore; quello che se c’è da prendere a calci nel culo uno stronzo, non si fa complicazioni. Tutto questo sono gli X-Mary. Sono anche una band di San Colombano al Lambro (Lombardia mica la California) che crea caos e musica da quasi vent’anni e che nel frattempo ha pubblicato diversi lavori tra cui “Day Hospital”, “A Tavola con il Principe”, “X-Mary al Circo” e “Tutto Bano” prima di “Green Tuba” appunto, coprodotto da Another Shame, Dischi di Plastica, Escape from Today, Le Arti Malandrine, Lemming Records, Noiseville, Smartz Records, Wallace Records. L’ingegnere del suono è Fabio Magistrali, che a detta della band ha rappresentato un valore aggiunto ben oltre le sue mansioni (“ci ha dato da mangiare, ha detto la sua e dato un sacco di idee (ultima ma non ultima quella dell’albero senza tronco in copertina” (foto di Davide Maione)). Per quanto riguarda la musica, gli X-Mary sono ancora più inenarrabili. Nel rispetto nella loro indole beffarda ma mai allontanandosi dalla realtà, indicano come loro generi di riferimento Rock, Pop, Punk, Bossa Nova, Pianobar, Latina e tra le principali influenze Luca Carboni, Henry Rollins, Ruben Camillas e Zagor Camillas.
Siamo vicini alla verità, più di quanto possiate pensare. Gli X-Mary propongono una miscela che ricorda lo stesso famelico spirito degli Ween, band statunitense formatasi a metà anni ottanta, caratterizzata proprio dalla capacità di fagocitare una miriade di generi diversi risputandoli poi con violenza in un Art Pop dissimile dagli elementi primari. Cosi come per gli Ween il risultato è un sound onirico e mordace. Una sorta di geniale e bonaria presa per il deretano di generi musicali diversi che nel caso degli X-Mary, sono rappresentati dalla tradizione della musica leggera italiana, la musica brasiliana, il Punk. Nello stesso tempo, nella capacità di ricerca di suoni e nelle sperimentazioni folli, la band lombarda ricorda (scusate se esagero) The Residents, anch’essi capaci di nascondere sotto una luce fatta di sarcasmo e divertissement un’analisi della musica, moderna e non, che puntualmente sfocia in una distruzione dei miti, in un anti-fanatismo di massa, ricco di estetica e pieno di sostanza, senza alcun didascalico citazionismo. Volendo invece fare un paragone tutto italiano, è sufficiente aggiungere alla capacità di ricerca di Freeman e Melchiondo e alle sperimentazioni dei bulbi oculari più famosi del mondo il punk demenziale degli Skiantos. Mi assumo la responsabilità piena di quello che dico e confermo che in molti punti la somiglianza è evidente sia nella composizione sia nella voce, cosi come nei testi. La discrepanza vera rispetto agli emiliani è che è maggiore la portata musicale, più ampia la lista dei generi toccati e forse gli X-Mary presentano la loro irriverenza in maniera meno aggressiva e più ricercata. Inoltre, l’aspetto demenziale del rock è meno evidenziato. Quindi mescolate Ween, The Residents e Skiantos alle prese col Pop, la musica brasiliana, l’HardCore e forse avrete capito di che parliamo. In realtà è impossibile capirlo (e descriverlo) senza ascoltare. “In Prima Fila”, brano che apre Green Tuba, vi darà un’idea migliore di quel paragone con la band di Freak Antoni fatto in precedenza. Stesso dicasi per “La Piazza Non C’è Più” anche se il testo e la musica si addolciscono fino a rendere plausibile la vicinanza con il Pop di Luca Carboni. La leggerezza sarcastica degli X-Mary continua con “Solo Mattia Mi Dà” e sfocia presto nel delirio. I quarantadue secondi di “Pasticciotti” sono la porta che apre sulla pazzia. “Gigia, il Cane di Cristiano, si è Persa nel Bosco del Castello”. Il nome non dice niente. E proprio per questo sembra dire tutto. I primi richiami alla musica sud americana si hanno con “La Rivista” che sembra sempre tuttavia indissolubilmente legata alla nostra penisola cosi come in “Tiziano Iron” si fanno sentire più prepotentemente le (s) porcherie noise, punk hardcore della band.
Con “Badula” siamo ancora oltre. Un sound tex-mex che sembra tirato fuori dall’intro di un duello Western fatto di tromba, pistole e Tequila. “Viados de Porao” prima de “La Giornata del Nuovo Pizzaiolo” rappresentano un’accoppiata da delirio puro. Metal, scream scaraventato nelle orecchie prima di un pezzettino Pop reso impazzito da un testo talmente concreto da sfiorare il surreale. Uno dei miei brani preferiti è la traccia tredici, “Racconti dell’Africa Nera” uno dei passaggi meno sperimentali del disco, eppure carico d’idee. Da segnalare anche “Io Amo Te” nella quale abbiamo scoperto non esserci seconde voci. Non l’avreste detto, vero? Il resto prosegue tutto sulla stessa reiterazione alternata fino alla traccia ventuno. Scatti veloci da un continente all’altro, urla, spettacolari passaggi pseudo Pop (“Alle 18 le Capre Bevono”), tutto frullato in un vorticoso ensemble di schegge che vanno dai ventinove secondi ai tre minuti e diciannove. Insomma, gli X-Mary sono tanta roba e spero abbiate la curiosità, non solo di ascoltare quest’ultimo lavoro, ma anche di riprendere i vecchi e soprattutto di andare a vederli dal vivo, magari insieme ai Camillas (X-Marillas), in uno spettacolo indimenticabile per gli amanti del casino puro, delle illogicità musicate e dei punkabbestia. Avete presente quelle band che non vi entusiasmano su disco eppure live vi fanno uscire pazzi? Potrebbe essere questo il caso. Dalle mie parole non avete capito molto, suppongo. Non è solo colpa mia, credetemi e comunque, meglio cosi. Se li conoscete già, vi basterà sapere che c’è molto meno Hardcore del passato, che sono stati aggiunti i fiati e che dentro ci sono potenziali pezzi da radio le cui possibilità sono mandate a puttane dagli stessi X-Mary quando decidono di non superare qualche decina di secondi (è il loro stile (purtroppo, in questo caso, giacché alcune sembravano poter veramente diventare grandi pezzi) e se non avessero avuto queste caratteristiche, staremmo ascoltando altro). Se non li conoscete, cercate di non perdervi questa fintantologia di storie irrazionali in bilico nella storia dell’ arte dei suoni. Vi lascio con le stesse parole della band. Vi potrebbero aiutare a capire. “Se cerchi un singolo, ascolta “Mi Sento Solo”. Se cerchi una pseudo cover dei Camillas, ascolta “Picante”. Se cerchi grane, hai sbagliato gruppo”.