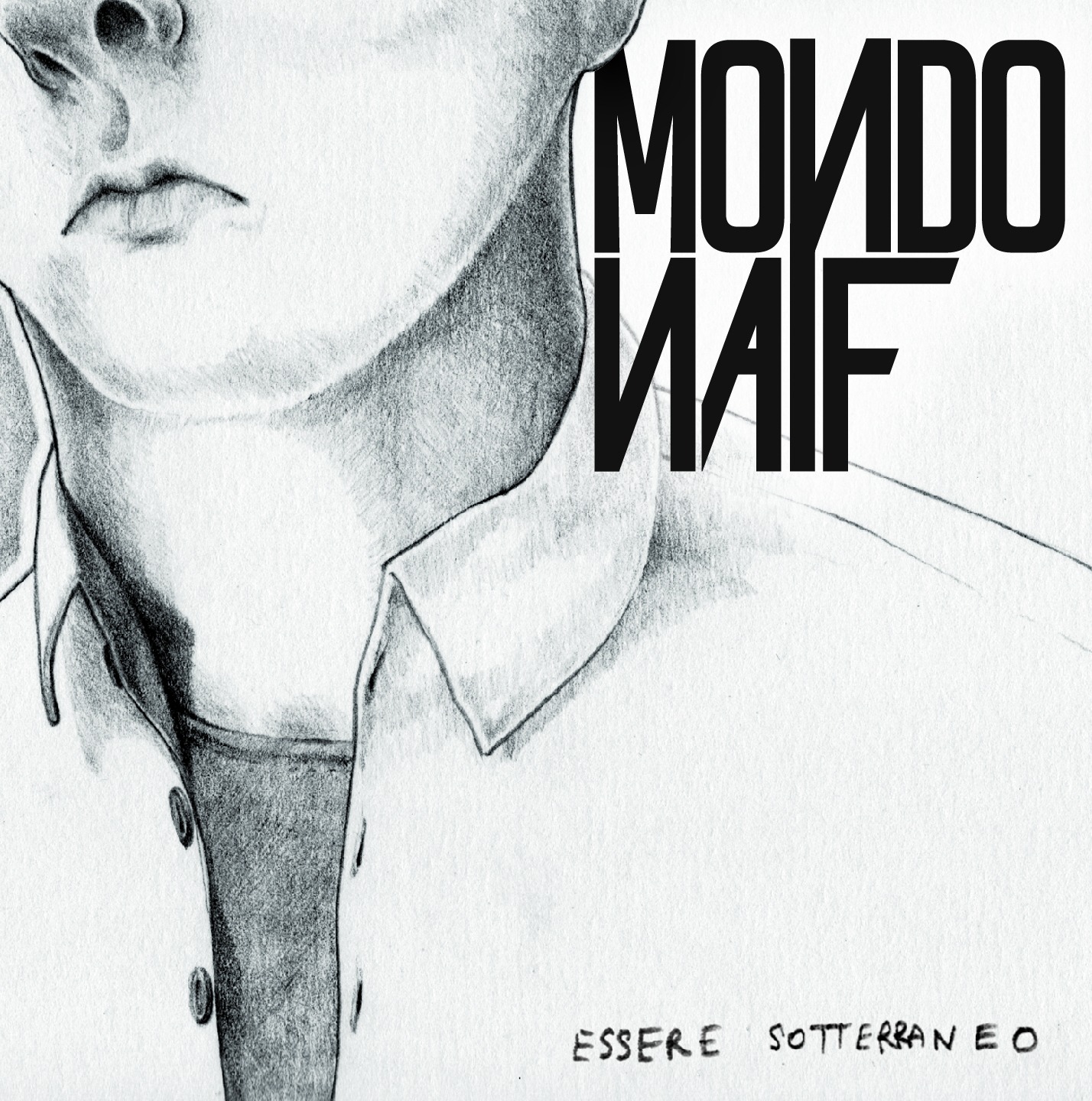Partiamo da lontano circa metà anni ottanta. In un buio scantinato freddo e puzzolente, tra rifiuti, siringhe usate, bottiglie rotte e sorci neri e grossi che si divorano gli uni con gli altri, sopra un materasso intriso di piscio giallo e sperma rinsecchito, l’Hardcore, strafatto come al solito, si stava trombando violentemente e senza precauzione alcuna quella fighetta dell’Heavy Metal, non sappiamo quanto consenziente. Poco tempo dopo ecco il parto tanto (in) atteso. Come un alieno verde, con la lingua biforcuta in bella mostra, dalla vagina della fighetta in tutta la sua furia estrema, in tutta la sua follia, senza lacrime, sulla terra fa la sua comparsa una nuova specie. Grindcore è il suo nome e come un vampiro presto inizia a nutrirsi del sangue degli ultimi, inizia a diffondere il suo verbo urlando e a spargere il suo seme dal Regno Unito al mondo intero come una pioggia di psicopatica violenza acida. Napalm Death e Carcass sono i primi apostoli poi convertiti al Death Metal. Proprio Mick Harris (drummer dei Napalm Death) battezzò il nuovo genere parlando di grind, tritacarne, per definirne i tratti caratteristici. Pezzi brevi come esplosioni, liriche sociali, rumore nero e parole a tratti incomprensibili. Nicola Manzan (c’è lui dietro la one-man-band Bologna Violenta) è molto giovane all’epoca ma segue la crescita e lo sviluppo del genere in maniera apparentemente maniaca. La prole dell’originale Grind si è spostata fisicamente, soprattutto in terra Americana (U.S.A.) e ha cambiato alcuni dei suoi tratti somatici. Spesso si è fatta più precisa, ad alto livello tecnico, con riff discordanti tra loro, struttura spesso molto complessa e dilatazione dei tempi di esecuzione, sfociando nel cosiddetto Math-Core (The Dillinger Escape Plan una delle band più rappresentative del genere). In altri casi si è allontanata verso le terre del Metal, sia Death sia Brutal, mantenendo intatte, in questo caso, alcune peculiarità quali la velocità nel riffing o il martellamento della batteria oltre i 200 Bpm, riducendo però la voce a qualcosa d’incomprensibile e quindi mettendo il secondo piano l’aspetto sociale delle liriche.
Nicola Manzan (trevigiano classe 1976, diplomato in violino e polistrumentista, già collaboratore con Teatro Degli Orrori, Non Voglio Che Clara, Baustelle e tanti altri) oggi ha quasi quarant’anni e uno spiccato senso di malinconia propositiva, di voglia di passato, un forte legame con le radici ed anche tanta attenzione agli aspetti evolutivi sia del genere sia della società in cui ha vissuto. La nostra società occidentale, italiana fino al midollo. Nel bene e nel male. La nostra musica di chitarre e pelle che bacia l’elettronica. Pseudo nichilismo teatrale e teatralizzato in una sorta di colonna sonora di un film fantasma (anche se stavolta sono assenti i riferimenti diretti al mondo cinematografico). Esiste un legame tra la “nostalgia” con la quale riprende il Grindcore originario plasmandolo e mescolandolo con l’elettronica e con schegge impazzite avanguardistiche che possono essere voci distorte, trasmissioni radio, inserti di musica classica, jazzismi, cover (splendida) dei C.C.C.P. (Valium Tavor Serenase cantata da Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids), electro-music e tanto altro, con quelli che sono i riferimenti testuali sociali e letterali delle canzoni (canzoni è il termine meno adatto per le esecuzioni di Bologna Violenta) che tanto si rifanno agli anni ottanta, proprio gli anni in cui il genere è nato.
Bologna Violenta è palesemente ben oltre il Grindcore. Utopie e Piccole Soddisfazioni, secondo album dopo l’ esordio datato 2010 “Il Nuovissimo Mondo”, è un insieme di tante cose. E soprattutto è una degna evoluzione, logica prosecuzione, eccelso sviluppo di quanto fatto nell’ album precedente, con notevoli miglioramenti strutturali e compositivi, maggiore lucidità, visione più ampia e meno incentrata sulla sola tagliente chitarra elettrica. Un enorme passo avanti. Il Grind è la materia prima penetrata da citazioni, digressioni splatter, intellettualismi, parole del Presidente della Repubblica Saragat del 1967, canti polacchi, il bambino Dario e la signora Maria, Arturo Taganov e altre follie. Utopie e Piccole Soddisfazioni è accozzaglia, babele, cagnara, confusione, disordine, guazzabuglio, macello, pandemonio, sconquasso, trambusto, il risultato defecato dalla società italiana in digestione dagli anni settanta fino a oggi, che un Demiurgo chiamato Bologna Violenta ha lavorato come creta per creare qualcosa che disturbasse il perbenismo in maniera mirata e apprezzabile da chi riesce a saltare la schematicità della classica forma musicale tipo canzone e una volta creato qualcosa di bello ci ha pisciato sopra per rendere l’opera ancora più viva nella sua ripugnanza. Come abbiamo detto, dall’analisi del disco e delle sue singole parti, emerge una varietà notevole di elementi. Dalle parole del PdR di “Incipit” e la violenza della chitarra, si passa alla purezza (nel qual caso non prendete la parola alla lettera) di “Vorrei sposare un Vecchio” e il suo coro di bambini, fino a sperimentazioni elettroniche Harsh stile Kazumoto Endo, pseudo improvvisazioni noise degne dei Dead C o dei Flipper e follie pregne d’impulsi sessuali avantgarde memento dei geni della provocazione Butthole Surfers. Ci sono collaborazioni importanti (oltre alle citate ricordiamo quella con J.Randall degli Agoraphobic Nosebleed, con Nunzia Tamburrano, compagna e collaboratrice che recita in Remerda e con Francesco Valente, batterista de Il Teatro Degli Orrori, che urla in Mi fai schifo) e inserimenti di violino, ci sono parole di rabbia, ci sono cover, c’è una ricerca metodica e spasmodica, c’è rassegnazione e speranza, ci sono ballate dall’aspetto folk che raccontano una novella finto De Andrè (Remerda) come a prenderci per il culo, ci sono intermezzi che sarebbero perfetti con le foto delle piazze italiane sullo sfondo, c’è la decadenza culturale e politica, c’è la decadenza dell’arte musicale, ci sono cori monastici squartati dalle urla della chitarra, c’è tutta Bologna Violenta, fino alla fine, ovvia come la morte, triste come la vita. C’è cosi tanto che descriverlo, è impossibile. Utopie E Piccole Soddisfazioni è parte dell’unico strumento a nostra disposizione per distruggere dalle fondamenta il Panopticon nel quale la mente della collettività è stata rinchiusa in completo potere psichico dal guardiano della società moderna. Tutto è smitizzato,tutto è ridicolazzato. Ora sta a voi.