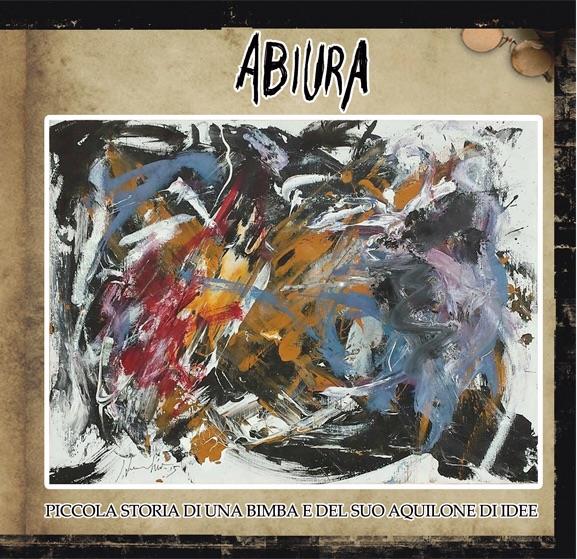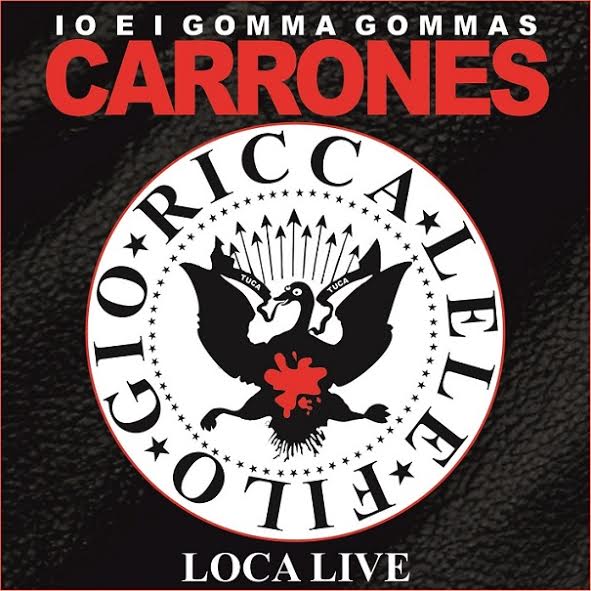La vera dichiarazione d’intenti di questo nuovo album della band ateniese Motherfucker è racchiusa nell’immagine di copertina, in cui, disteso sopra un freddo parquet, giace un braccio inerme, ricoperto di sangue, coriandoli e brillantini superstiti di una festa e un tatuaggio che recita don’t quit, non smettere. Se il messaggio concettuale nascosto in questa visione può essere interpretato sotto diversi punti di vista e lasciamo a voi scegliere la strada dell’ironia e sarcasmo dello show must go on o quella di una rabbiosa lotta alla rassegnazione, da un punto di vista stilistico tutto è più chiaro. In Confetti, come nella sua cover, si miscelano colori e note che potremmo definire speranzose ma anche il suo contrario. Dunque, una certa violenza sonora è squarciata da una continua ricerca melodica, la voce meccanica e fredda danza con ritmiche che martellano cercando di non fracassare nulla. Il sound nel suo insieme è insipido, con una registrazione non sappiamo quanto volutamente grezza. Rinuncia a ogni sorta di sperimentazione, mette da parte il possibile lato Psych Rock facendo scivolare la sezione ritmica dietro la voce e punta dritto alla creazione di brani che possano suonare tanto crudi quanto digeribili. Con lo sguardo rivolto agli anni 90 del nord est statunitense, i Motherfucker provano a tracciare lo stesso solco di band come Cloud Nothings o Japandroids capaci di miscelare, con ottimi risultati, Noise e Pop ma qui, non solo è diverso il punto di partenza che è piuttosto da fissare nel Post Hardcore classico albiniano, ma anche il risultato è ben lontano da ciò che ci si sarebbe aspettati. Il grosso limite di Confetti non è nell’evidenza di queste intenzioni, ma piuttosto nel non essere riusciti a chiudere un cerchio che potenzialmente poteva avere un senso. Portare un genere tanto brusco e violento come quello degli Shellac a un pubblico magari meno propeso a certe ruvidezze, sarebbe stata una buona scelta ma quelli che dovevano essere i punti chiave, quindi ganci, melodie, vocalità, ritornelli e riff alla fine suonano come tentativi malriusciti di ottenere qualcosa di esclusivo. Quando Erika Rickson (drums), Erica Strout (guitar) e Mandy Branch (bass) pestano i piedi sull’acceleratore o creano strutture strumentali deformi il sound acquista corpo e credibilità ma è proprio nel momento in cui entrano in scena quelli che dovevano essere i momenti di svolta che lo scheletro crolla su se stesso. Prendiamo ad esempio la seconda parte di “I Want the F”. La reiterazione chitarristica stordita da una batteria morente alternata alle sfuriate più old style s’interrompono proprio quando ci aspetteremmo una scarica di violenza e a quel punto, se la scelta delle ragazze greche è quella di non forzare la mano sul lato brutale ma piuttosto di alleggerire il suono, non è certo sufficiente ridurre i tempi, abbassare i volumi e frenare. Quello che poteva essere un cazzotto in pieno volto sferrato dalla donna più bella che abbiate mai visto, si risolve in una tirata di capelli e qualche gridolino. Un album violento per gente non violenta.
Recensioni
Abiura – Piccola Storia di una Bimba e del suo Aquilone di Idee
Rock allo stato puro: ecco come si potrebbe definire in poche parole Piccola Storia di una Bimba e del suo Aquilone di Idee degli Abiura. Un titolo apparentemente lungo e complesso che lascia presagire sonorità Progressive Rock ma che, in realtà, piuttosto che Premiata Forneria Marconi (come Franz Di Cioccio il gruppo è originario di Pratola Peligna) e Banco del Mutuo Soccorso, prende come punto di riferimento i Timoria della prima ora (quelli con Francesco Renga in formazione, per capirsi) e i Litfiba post El Diablo. Dalla cosiddetta “Quadrilogia del Potere” della band fiorentina gli Abiura hanno infatti attinto parecchio, imitandone i suoni e gli stili. Basta ascoltare la chitarra in “Il Nonno della Bimba (il Vecchio)” per far tornare alla memoria il tapping di Ghigo Renzulli ma tuttavia c’è anche tanto altro in questo disco. “Sorella” è un brano dalla classica impronta Blues alla Stevie Ray Vaughan / John Mayall, mentre la conclusiva “Festa” è molto più Heavy rispetto a quanto sentito in tutto il resto del cd. Se dovessi dare un consiglio ai quattro ragazzi abruzzesi, direi loro di provare ad ascoltare anche i Diaframma, che del Rock italiano sono un pezzo importante e non da trascurare in modo da ampliare la molteplicità dei suoni proposti. Qualche riff di stile fiumanesco in fondo ci starebbe davvero bene all’interno delle loro canzoni, anche per dare una fluidità melodica maggiore facendo attenzione a non sfociare in un’impronta Punk che denaturalizzerebbe lo spirito del progetto. Avrei anche cercato un mixaggio leggermente diverso perché gli strumenti non sono bilanciati come dovrebbero ma tuttavia, a parte questo piccolo particolare tecnico che probabilmente sarà anche voluto per dare un sound “grezzo” e allo stato brado, come nel più classico Rock n’ Roll, il disco non soffre mai di “alti e bassi”. Piccola Storia di una Bimba e del suo Aquilone di Idee degli Abiura è infatti un lavoro che suona quasi perfetto anche negli arrangiamenti e, in aggiunta, degni di nota sono anche l’artwork generale con un insieme di disegni realizzati da una bambina e dalla stessa voce della band, opere d’arte del maestro Silvio Formichetti e foto volutamente retrò che richiamano alla memoria quelle di The Doors, The Allmann Brothers Band e The Notting Hillbillies. Perché in fondo le radici del Rock sono quelle, ed i buoni alberi nascono tutti da lì. O dall’Abruzzo forte e gentile!
Terzo Piano – Super Super
Sonorità brillanti, piglio deciso e personalità sono la forza di questo Super Super dei Terzo Piano, band di Cava de’ Tirreni che giocherella incauta sul bordo tra la minchiata nonsense (il meta-testo di “H”, parte 1 e parte 2) e il capolavoro vorticante e cosmico dove si vola a occhi chiusi, liberi, senza farsi troppe domande (“Attratti Super”, che ha anche un video bellissimo). È bello sentire, nel marasma di band che tentano di piacere a tutti i costi, qualche raro esempio di sguardo che pare limpido, che sembra guardare dove vuole, sbattendosene di sembrare più o meno “hip”, più o meno fuori di testa. Ma mi trattengo ancora, perché nelle voci e nelle melodie così Pop eppure storte, nelle ritmiche minimali eppure trascinanti, nelle canzoni così vere che sembrano finte (o così finte che sembrano vere) c’è ancora una penombra di dubbio che non mi tolgo. Ci sono o ci fanno? Follia o calcolo? C’è chi direbbe che non importa, che l’opera è l’opera e da sé parla, e non ci sono contesti o contorni che tengano quando la si assume, quando ce la si inietta nel timpano. Sarà; io un po’ ci penso, ma nel frattempo mi riascolto Super Super e ci navigo un po’ dentro, poi vedremo. Nel peggiore dei casi sarà un guilty pleasure ad alto contenuto calorico. Nel migliore, una frangia del Pop di domani.
Sakee Sed – Hardcore da Saloon
Scherzando, dalle mie parti diciamo che in Brianza deve essere caduto un meteorite che piega lo spaziotempo o non si spiegherebbe la follia dei musicanti della zona. Credo una cosa simile succeda nel bergamasco, dove o vendono della droga molto buona o l’acquedotto filtra attraverso i resti di qualche bestia mitologica soprannaturale interrata nei paraggi che infetta la gente di lì e la rende mutante nella testa e nella musica. La prima spiegazione è più probabile, la seconda è più affascinante. Ci penso perché mi va in cuffia l’ultimo dei Sakee Sed, che avevo già incrociato ai tempi di A Piedi Nubi e che anche in questo Hardcore Da Saloon continuano nel loro meticciato di generi e spunti, creando un Far West che è talmente Far che forse non è più nemmeno West, dove il pianoforte sta in mezzo a tutto, facendosi roteare intorno ritmiche forsennate e distorsioni, voci seminascoste e gusto per teatralità e sorpresa. Non voglio fare paragoni troppo stringenti con altre band, e quindi non li farò. Ma posso permettermi di dire che anche a loro accade ciò che nella zona (geografica) succede spesso, ossia: una lodevole libertà compositiva e immaginifica che però lascia indietro la costruzione di un mondo lirico, di un racconto, per avere invece in cambio una panoramica a tinte forti e impressioniste che diverte e meraviglia, senza dubbio, ma non rimane impressa con la dovuta forza nella mente e, soprattutto, nel cuore. (Il riferimento geografico potrebbe essere anche frutto di un mio personale bias, ma il discorso non cambia). Brani come “Markala”, “Beck and Musical” (che ritornello!) o “La Fuga di Barnaba” creano sì colore e tensione, ma poi qualcosa si perde. Miscelano Rock, Folk, batterie pestatissime, frenesia e pianoforti inaspettati, fughe strumentali brevi ma pungenti, frasi melodiche sghembe, scalene, che allenano le orecchie, che soddisfano il palato, che tendono i muscoli facciali in un ghigno divertito e si fermano lì, sull’orlo del padiglione auricolare, senza penetrare nell’osso, nel sangue. L’energia e la gioia (in senso lato) che sprizzano da queste tredici tracce bastano a fare di Hardcore Da Saloon un buon disco? Sì. Per essere ottimo, però, ci vorrebbe forse anche qualcos’altro che i Sakee Sed, probabilmente, non sono nemmeno disposti a dare. Non importa: se facessero altro non sarebbero loro (e magari sarebbero peggio). C’è bisogno di band che fanno il cazzo che vogliono senza ruffianate. Io non mi convinco al 100% ma a loro, giustamente, che gli frega?
Danzig – Skeletons
Glenn Danzig è un artista con un marchio di fabbrica ben delineato fatto di un personale Rock ruffiano, roccioso e a volte strampalato, e una voce inconfondibile sin dai tempi dei Misfits. Come tanti però, anche lui pare ultimamente aver trovato una nuova propria dimensione che non sembra voler più scrollarsi di dosso. Skeletons è il suo ultimo album e rappresenta la totale conferma di questa ritrovata nuova stabilità. Di certo ci sarà chi ne apprezzerà la nuova veste e chi storcerà il naso come qualcuno si accontenterà del suo solito sound e chi pretenderà qualcosa di più. Insomma è come la questione di Iron Maiden o dei Motorhead: restare cosi perché ormai gli anni lo permettono o tornare a stupire ancora una volta? Innegabilmente la prima ipotesi va un po a screditare gli artisti perché è sinonimo di fermezza, di mancanza di idee e nel peggiore dei casi, sintomo di artisti finiti; nella seconda, invece, c’è il piacere e la curiosità di vedere se c’è ancora un’inventiva o magari un’ “anima”. Le leggi di mercato, i target e i contratti fanno la loro parte ma fino a che punto? Skeletons è un disco che ha davvero poco da dire in quest’ottica, è il classico lavoro di buona fattura di Danzig ma non aspettatevi assolutamente nulla di nuovo. Osservando in maniera pignola il disco, notiamo addirittura che certe melodie, che tanto avevano reso celebre l’ artista, sono diminuite e quasi tutte le tracce hanno una struttura simile. Il sound è sempre pulito, il lavoro in studio come al solito è ben fatto; non ci sono sbavature che compromettano l’ album. Il punto cruciale resta quello citato all’ inizio; di seguito non aspettatevi un platter diverso dagli altri. I fan più accaniti lo apprezzeranno ma gli intenditori del genere volteranno pagina e si dedicheranno sicuramente ad altro.
Dumbsaint – Panorama, in Then Pieces
Abbiamo davvero bisogno di un ulteriore album Post Rock e di una nuova band australiana che si metta sulla scia dei Dirty Three andando ad spalleggiare formazioni più note come Sleepmakeswaves o Tangled Thoughts of Leaving? Probabilmente non c’è alcuna necessità vitale ma, per i cultori del genere strumentale d’indole “cinematografica”, c’è sempre la voglia di lasciarsi sopraffare da quelle suggestioni soniche che solo questo stile, torbido più nella definizione che nel concreto ascolto, riesce a evocare e la provenienza geografica non può che fare da garante di una certa dote espositiva che quasi mai è mancata proprio a chi quel peculiare stile l’ha portato oltre i confini della nazione più selvaggia che esista. Chiariamo che i Dumbsaint non sono proprio una compagine all’esordio, andando ad affondare le radici nel 2009 e avendo concepito il primo Lp tre anni fa. Something That You Feel Will Find its Own Form fu l’ipotetico trampolino di lancio che permise a James Thomas e soci di iniziare un cammino artistico che li ha portati a questo Panorama, in Then Pieces passando per i palchi d’Australia in compagnia di This Will Destroy You, Russian Circles, Boris ed Earth. Quel trampolino avrebbe potuto far volare i Dumbsaint se solo avessero avuto ali abbastanza possenti da reggere il peso di un linguaggio che non fa dell’originalità e dell’orecchiabilità melodica propria caratteristica singolare. Panorama, in Then Pieces è un progressivo susseguirsi per quasi un’ora di ritmiche potenti, controtempi non eccessivi e chitarre ad alternare fasi più lievi e oniriche ad altre più violente e quasi Noise. Un disco assolutamente di valore sotto l’aspetto estetico e tecnico ma che ha quel sapore manieristico e ridondante che stanca già al primo ascolto. Un’opera che cerca di mostrare un lato oscuro che l’ascolto non riesce a evocare e che, probabilmente, potrebbe trovare la sua forza nelle immagini, giacché realmente quest’album ha una componente cinematografica che ora non mi è richiesto di analizzare. Quello che ho adesso è un ottimo artwork che racchiude solo gradevole mediocrità.
Io e i Gomma Gommas – Carrones
La storica band marchigiana, ispirata per nome e concezione ai Me First and the Gimme Gimmes, si rifà viva con questo nuovo lavoro descrivibile come un doppio omaggio a due icone che nulla hanno da spartire tra loro, ma che con la giusta dose di fun possono incontrarsi e camminare con spensieratezza a braccetto. Ecco come nasce Carrones – Loca Live. Stiamo parlando, ovviamente, dei Ramones (fortissimo il riferimento già dalla cover dell’album) e di Raffaella Carrà. Infatti le sette tracce sono tutte delle rivisitazioni dei successi della Raffaellona nazionale. Si parte con “Ma che Sera” e si termina con un’improbabilissima versione Punk di “Tuca Tuca”. Impossibile far emergere una canzone sopra le altre: sono tutte dei grovigli di ritmi Rock’n’Roll e melodie Surf. Carrones è questo: snaturare positivamente brani classici con lo stile di Derozer e Lagwagon, avere una durata limitata e una dose di divertimento prolungata. Non è consigliabile ai bigotti della musica italiana, per evitare effetti collaterali. One, two, three, four…
John Grant – Grey Tickles, Black Pressure
Vive di paradossi affascinanti, questo terzo album dell’ex frontman de The Czars, di scarti minimi e diversioni apparentemente casuali. Un impianto minimale, di suoni elettronici qui frizzanti e là cupi, in cui John Grant sciorina flussi di coscienza tra vita quotidiana e paranoie notturne, zampate sensuali e paure profonde della malattia (è affetto da HIV) e della perdita. Pecca di Grey Tickles, Black Pressure è la sua linearità: sonora, quando questi brillii di beat secchi, questi fondali di synth, questa voce bassa e suadente iniziano a confondersi tra un pezzo e l’altro; e lirica, quando le rime baciate diventano un gioco ritmico più che una necessità poetica, quando il quotidiano si infiltra con troppa immantinenza per permetterci di uscire dall’hic et nunc di quella vita, di quel vissuto. La sfida vinta, invece, è sulla piacevolezza immediata, sul sapere essere profondamente Pop portando il minimalismo elettronico nell’area del Funk, del groove, del suonare cool intrinsecamente, senza sbavature, con un gusto melodico lanciatissimo che ricorda le grandi star inglesi, la scuola del titanismo popular anglosassone (potrebbe essere un Robbie Williams di un Rudebox meno paraculo, per intenderci), capace di suonare freak e insieme radiofonico, travolgente. Non so se questo disco passerà alla storia, ma di certo è un disco sincero fino alla nudità, dove John Grant si spoglia e, con un’ironia che fa trasparire una sensibilità malcelata, ci canta davvero il suo intricato vivere, le sue vibranti viscere.
Radar Men from the Moon – Subversive I
A differenza dei compagni di etichetta Underground Youth, gli olandesi Radar Men from the Moon hanno compiuto un viaggio diametralmente opposto, almeno fino all’uscita datata 2015 di entrambi. Se quelli di Manchester avevano esordito con poche promesse per il futuro salvo poi evolvere e crescere fino a buoni livelli, la band di Glenn Peeters aveva debuttato due anni dopo con tante ottime prospettive che, col passare degli anni, si sono rivelate illusorie. Un percorso antitetico, dunque, che però ha portato le due band a un risultato (l’ultima release per intenderci) molto simile, in quanto a giudizio critico. Non si faccia l’errore di immaginare le due formazioni parificabili in quanto a stile, non è questo che le accomuna. Messa da parte l’etichetta e la quasi contemporaneità dell’ultimo album, la vicinanza tra Radar Men from the Moon e Underground Youth può ritrovarsi solo in una non troppo marcata predisposizione a suoni di stampo Psych Rock. Tornando ai nostri olandesi, parliamo, infatti, di quattro brani per circa trentacinque minuti di musica, completamente strumentali. L’avvio di “Deconstruction” è una bomba per quando diretto e potente. Col passare dei minuti però, quella stessa veemenza si riduce in una banalità sonica e una monotonia ritmica, che talvolta sembra voler prendere pieghe Math Rock ma che alla fine è solo volgarità creativa. La situazione non migliora con i brani seguenti, anche se il lungo intro Minimal Noise di “Neon” inserisce qualche elemento di varietà apprezzabilissimo, ponendo le basi del brano più intrigante di tutto questo Subversive I. “Hacienda” chiude il disco provando a fornire nuovi ingredienti ma anche in questo caso è la noia a farla da padrone oltre che un’insipidezza retorica quasi avvilente. L’unica cosa che salva il disco la troviamo nella traccia numero tre e in qualche fugace tentativo di uscire dallo schema precostituito dai Radar Men from the Moon come nella parte finale della closing track; per il resto, se proprio volete cimentarvi con lo Space Rock, andate a ripescare qualche vecchio disco di Spacemen 3, Gong o Hawkwind o se cercate qualcosa di più attuale, magari proprio di questo 2015, provate con i veterani britannici Ozric Tentacles o, se desiderate una band freschissima, coi cileni Föllakzoid perché l’ultimo dei Radar Men from the Moon sarà duro da digerire.
Valkyrie – Shadows
Un rock inspirato quello dei Valkyrie, un Rock dalle tante sfumature e dai diversi riferimenti. La band sa bene come amalgamare Doom ed Hard Rock. Shadows è il loro terzo disco, quello che si è fatto apprezzare più di tutti. La band dei fratelli Adams si rifà ancora una volta a pilastri come i Deep Purple, Thin Lizzy e Mr. Big, questo per quanto riguarda il versante Hard Rock, mentre, sulla scia Doom, padroneggia un sound tanto caro ai Kyuss ed agli Spirit Caravan. Questa terza fatica della band americana mette a fuoco, e questa volta veramente, le potenzialità dei ragazzi. E’ interessante lasciarsi andare ai loro giri di chitarra ed è magnifico lasciarsi trasportare dai loro assoli. Riescono ad alternare, in un pezzo, momenti tecnici e chiassosi dediti al più pungente Hard Rock a momenti oscuri e baritonali del Doom. La melodia è una costante del disco, si fa notare ed apprezzare; la banalità invece è inesistente. Nulla è dato per scontato in questo disco, ogni cosa è al suo posto in maniera artistica. Partendo dall’opener, troviamo una traccia maggiormente strumentale che presenta l’album alla grande; i musicisti partono con una canzone che è un vero e proprio macigno: riff, assoli ed una batteria strepitosa. In “Golden Age” si comincia a sentire la vena Doom; l’andazzo baritonale è molto evidente. La terza traccia, “Temple”, è quella che, con molta probabilità, amalgama al meglio i due stili; per il sottoscritto è la canzone più rappresentativa: chitarre possenti e taglienti allo stesso tempo, accompagnate da un pulsante basso che insieme alla batteria crea una base unica. “Shadow Reality” è quasi una ballata con ottimi giri di chitarra ed un cantato coinvolgente. “Wintry Plains” invece è la traccia che più di tutte ha delle venature psichedeliche; il gioco delle chitarre conduce a quelle sonorità. “Echoes” invece, la penultima canzone del platter, è tra quelle più belle e a far da padrone sono le chitarre coinvolgenti più che mai. La conclusiva “Carry On” chiude in bellezza attraverso affascinanti melodie create dalle onnipresenti chitarre. Insomma, Shadows è un album di ottima fattura; piacerà a persone di vario genere.
Winter Dust – Thresholds
Quattro canzoni, quattro potentissime scosse telluriche che si insinuano sotto pelle e bruciano fino a far ribollire il sangue nelle vene. Ecco una piccola sintesi di cos’è Thresholds, nuovo EP dei padovani Winter Dust. Non avranno la delicatezza ammaliante dei Mogwai, ma in loro resta intatto lo spirito evocativo del Post Hardcore di Cave In o Pelican. “There” è il battesimo che non ti aspetti con questa realtà musicale: paesaggi martoriati che rifioriscono per poi appassire nuovamente, il cui concime sono le liriche urlate da Marco, che non mostra neppure un briciolo di autocontrollo. “Acceptance” ci fa capire che non c’è fine alla disperazione, mentre la terra si sgretola sotto i nostri piedi e l’Apocalisse festeggia intorno a noi. Il pianoforte corre a darci soccorso ed è come uno spiraglio di luce che fende le tenebre. Ecco che “Let the Morning In” ricostruisce il mosaico di un mondo devastato, corrotto dalla piaga della deriva. E’ un salmo viscerale, emozionale, fondato su una melodia solenne, è una sorta di “Inno alla Gioia” di Beethoven in chiave Post Rock. L’epilogo avviene con “Elsewhere” ed è un’ennesima carica di emozioni contrastanti: la calma, la pace fugace, le insidie della discordia, la purezza di un disco che non conosce limiti e manda in frantumi diversi clichés legati alla nostra Patria. Quattro canzoni, una moltitudine di brividi.
Verbaspinae – Tre
Spigoloso è il primo aggettivo che mi viene in mente ascoltando questo album del trio milanese Verbaspinae. Un disco ben suonato, ben prodotto, ben interpretato ma che sicuramente non ha nessuna parete morbida o malleabile. Di Pop qui c’è poco e niente, ma piuttosto una stanza buia e ricca di insidie. “Il Pezzo” è proprio l’anti-Pop per eccellenza, metodica fuga dalla melodia. Una forza che stride nelle nostre orecchie. Pochi versi e non in tutti i brani, tanta Elettronica, a volte distesa e leggera come un corpo sinuoso che fluttua nell’aria, a volte rigida come il marmo. Così parte “Vyger”, nemmeno una parola e suoni che si incastrano tra New Wave e il Blues di un’armonica. Un romanticismo latente e il vecchio nostalgico che si incontra col ragazzetto superbo smanettone col computer. Un viaggio stellare fatto con uno shuttle degli anni 70. “Ieridomani” è accompagnato da un riff martellante, da sentenze ermetiche, da una bella chitarra distorta e da synth impazziti che danno un po’ di verve al pezzo. Il tutto si incastra in una grande opera di produzione ed esecuzione. Cura certosina nella ricerca di suoni e mix. Questo pezzo è proprio quello che sarebbero i Massimo Volume se incontrassero i Daft Punk. “Novantuno” continua sullo stesso filone, le tastierone governano un groove elettronico, quasi robotico e macchinoso. Come un ingranaggio che si inceppa, come il Charlie Chaplin dei Tempi Moderni portato nel 2015. Sì, si può dire tutto su questo gruppo ma non che suoni vecchio o già sentito. E nemmeno che non sbirci costantemente verso quella che è la stroria del Rock. Anzi azzarda fin troppo quando nella title track sfodera un suono tra Space Rock e Gospel in un’orchestrazione che sottolinea ancora una volta il lavoro immenso che sta dietro al nome Verbaspinae. Difficilissimo da digerire. Un pugno in pancia come la ballata “Parole”, dove finalmente escono versi semplici, vomitati di getto, intensi, che escono dalla bocca di Germano Allegrezza insieme a sangue sporco e una risata storta. Una canzone che pare uscita dagli archivi di un Manuel Agnelli nei suoi tempi migliori. Il Blues poi torna nel finale cupo di “Ergot” e si mischia alla onnipresente elettronica, qui marcia, contaminata di quello strato di polvere che rende il pezzo, privo di parole. Una vera e propria discesa negli inferi. Dalle stelle agli abissi più profondi, questo album è ricco di spunti, di influenze e di pensieri malati. Incubi che sono così reali e che si sentono davvero molto molto bene.