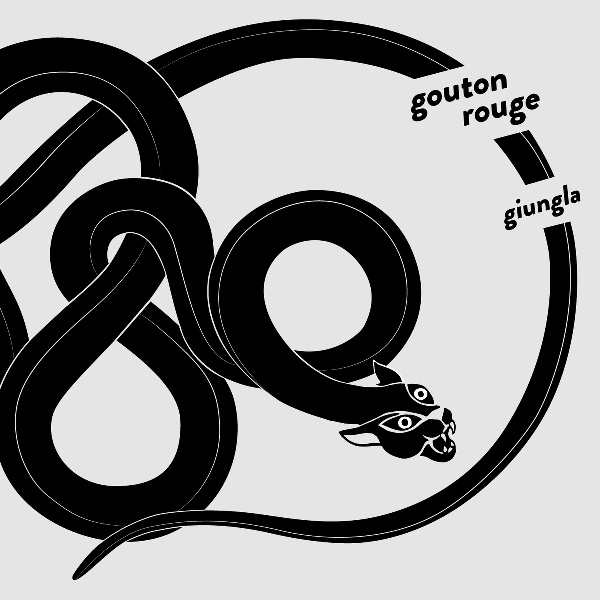Paroxysmal è l’ultimo lavoro del bolognese Fabrizio Matrone, in arte Matter. Già dalla cartella stampa si presenta bene: “un suono estremo ma adulto per chi non ha paura di ascolti difficili”. Ebbene, devo dire che l’ascolto, alla fine, mi è parso meno difficile di quanto quelle righe dessero a intendere. Parliamoci chiaro: non è un disco facile. Si tratta pur sempre di dodici tracce per più di tre quarti d’ora di Elettronica sporca, vibrante, dove la melodia praticamente non esiste, dove regnano il rumore e l’iterazione. Loop distruttivi e graffianti che suonano come il lavorìo incessante di una fabbrica cupa e rugginosa, meccanizzata ma senza circuiti elettronici, solo pistoni e benzina e altoforni e picchiare di metallo contro metallo. Però c’è una sorta di calma sottostante, la rilassatezza digrignante del rumore continuo, del processo senza fine, che si ripete come un mantra automatizzato, come una catena di montaggio che nel disumano della ciclicità nasconde la certezza del proseguire, la linearità di un percorso che va sempre avanti non muovendosi mai. Si rinnovano le esplosioni gravi, le unghie taglienti delle distorsioni, il quasi fastidioso lamento della macchina, ma intanto la testa si muove su e giù, e mi perdo nelle litanie poco liturgiche e molto industriali di un disco che potrebbe essere causa e soluzione di parecchi, godibili mal di testa. Per crani di latta e orecchie di ghisa, astenersi colletti bianchi.
Recensioni
Brother and Bones – Brother and Bones
Prendete quel sound sporco ma preciso americano tipico dell’epoca Post Grunge, calatelo su cinque ragazzi della Cornovaglia che puntano a diventare immortali come Braveheart con le loro canzoni e avrete i Brother and Bones. Giunti al loro album d’esordio omonimo nello scorso agosto, gli inglesi (già opening act di Bastille e Ben Howard) stanno intraprendendo un lungo tour che vede toccata anche la nostra penisola (Milano e Torino). Ma cosa portano sul palco i Brother and Bones? Prima di tutto storie, raccontate in maniera epica ma incredibilmente vicine alle vicende quotidiane di tutti. “Omaha” ne è l’esempio più luminoso: cavalli neri al galoppo, citazioni bibliche, muscoli e testosterone si mettono al servizio di una narrazione spettacolare e intima allo stesso tempo che ci narra dell’essenza stesso dell’essere umano. La formula classica doppia chitarra-voce, basso e batteria consente alla band di spaziare tra vari ambienti passando attraverso porte che recano nomi come Pop, Grunge, Folk, Indie. La batteria si incendia grazie al combustibile di “Kerosene” che apre le undici tracce e ci parla di un amore vissuto a mille all’ora; la timbrica di ispirazione Cornelliana ci trasporta immediatamente in un’altra dimensione. Proprio giocando con le sue variazioni, i B&B riescono a rimanere attuali e moderni pur serbando un sound ormai lievemente datato. Declinando voce, chitarre e timpani al 2015 escono vincitori sia in momenti particolarmente raccolti come “Save you Prayers” e “For All We Know”, sia in situazioni dove si schiaccia di più l’accelleratore (“Crawling”, “Everything to Lose”). Freschezza dunque, coperta però da un lieve velo di nostalgia per il passato che, se in questo Brother and Bones può essere segnalato come valore aggiunto, nel prossimo lavoro dovrà necessariamente essere assimilata e messa in bagaglio. Al primo full length non ci si aspetta una qualità così elevata ma, complici anche gli ottimi East West Studios di Los Angeles, tutto ci appare già come un prodotto completo e credibile. I ragazzi sono la perfetta band da locale, dove si suda e si beve birra fino a perdere i sensi. Adesso però i grandi palchi li stanno aspettando e loro sembrano essere ormai pronti.
Gouton Rouge – Giungla
I Gouton Rouge riescono a miscelare il loro buon talento ad una sincerità di fondo che viene, a tratti, edulcorata da una delicata paraculaggine (ad esempio chiamare un brano “Hasselhoff” è paraculaggine) che crea un contesto totalmente svincolato dal pressappochismo che genera la musica di tendenza in Italia. Sono fermamente convinto nella buona fede del quartetto. Il loro è un lavoro molto lineare e pulito: chitarre dal suono prevalentemente crunch, batterie e bassi semplici e tastiere ricercate e presenti quanto basta. Possono ricordare immediatamente i The Drums con qualche sfumatura qua e la figlia dei primi Cure. Le creature della giungla della band lombarda si palesano con un meccanismo lento e fluido, che lascia spazio a personaggi dai contorni abbastanza netti, sintomo di una buona capacità compositiva e di una maturità artistica non molto lontana dall’essere raggiunta. “Sulle mie Labbra” è sicuramente il brano di maggiore impatto del disco, sotto ogni punto di vista. La vera forza dell’ottava traccia risiede in un riuscitissimo bridge che spinge tutto il brano ad un livello effettivamente più alto rispetto al resto del comunque piacevole CD. In definita Giungla è uno di quei lavori che potreste ascoltare due giorni e dimenticare subito dopo oppure tenere nel cuore per sempre. Io sto nel mezzo. Non mi piace né dimenticare né affezionarmi troppo.
Liv Charcot – La Fuga
A un primo ascolto i Liv Charcot sembrano gli eredi de Le Vibrazioni con qualche elemento preso in prestito da Cesare Cremonini in versione Lunapop. In realtà già “Cosmonauti” mostra qualcosa in più rispetto ai citati “colleghi”, qualcosa di indefinibile ma gradevole che certo non appartiene alla cultura musicale italiana. La cosa viene messa in evidenza ancor più con la velocissima “Davanti alla Macchina Ancora nella Casa” con quella sezione ritmica che sembra appunto suggerire un tentativo di fuga. Del resto, a detta del gruppo composto da Lorenzo Cominelli (voce, basso), Tommaso Simoni (chitarra), Giulio Fagiolini (tastiere) e Nicolò Selmi (batteria), “la fuga è quella richiesta urgente che benché tentiamo di soffocare prima o poi si manifesta. I Liv Charcot sono espressione di questa richiesta”. Non manca però la classica ballad che con “Dove Andrai (Le Rondini non Tornano)” riporta alla memoria la grande hit dei Duran Duran, “Ordinary World”. Sia chiaro, il paragone con il gruppo inglese ci sta solo in questo caso, perché il resto del disco è tutta farina del sacco di questi quattro ragazzi toscani. Il Rock puro torna infatti con “Frammenti di Te” e “L’Obiettivo” che sembra essere uscita dalla penna di Matt Bellamy dei Muse coadiuvato da The Edge degli U2 (quelli più eighties). “Lettera dal Brasile” ha poco del paese dalla bandiera verde-oro ma appare un gradino sopra rispetto a quanto sentito finora e si candida immediatamente ad essere l’episodio migliore del disco se non fosse per quelle “Dicembre ’69” (dal sapore un po’ Funky degna dei migliori Bluvertigo) e per “Non mi Basterà” aperta da un drumming deciso che viene presto supportato da basso e chitarra e dalla voce decisa di Cominelli. Difficile quindi per “Sole a Mezzanotte” non fare brutta figura (non me ne voglia il gruppo ma il disco sarebbe stato meglio concluderlo qui spacciandolo per un ep). Troppo basilare negli arrangiamenti (che a volte sembrano persino un po’ forzati) e forse pure troppo elementare nei testi. Per fortuna a rimettere in carreggiata la band arriva “Vortice” una vera ventata di sperimentazione sonora con un sax alla Lounge Lizards che argomenta con un linguaggio Jazz con il resto degli strumenti. Conclude il lavoro “La Pineta” in perfetta calma e con qualche incursione vocale femminile che dà un tocco gradevole a quanto ascoltato finora. Un bel concept album tutto sommato, forse un po’ troppo lungo, ma abbastanza curato nei suoni e nei testi. Dimenticate quindi “Sole a Mezzanotte” e lasciatevi conquistare dal resto del disco, ne varrà davvero la pena!
Orange Revival – Futurecent
Eric, Christian, Andreas ovvero i nomi dietro ad una delle migliori band Psych Rock nate negli ultimi cinque anni, anzi, se continueranno con tale pregio, stile e carica, presto la migliore band del genere in circolazione. Non sto esagerando, perché se già l’esordio Black Smoke Rising era riuscito a persuadere tanto il pubblico (nei limiti di quello che può esserlo nella scena) quanto la critica, ovviamente il confermarsi non doveva essere cosa agevole. A distanza di quattro anni, ecco vedere la luce Futurecent, e se da un lato dovremo attendere per comprendere quanto gli affezionati ascoltatori sappiano apprezzarlo, quello che è certo è che anche questa volta il trio svedese ci ha preso alla grande. Sette brani che ripercorrono tutta la tradizione psichedelica, partendo sì dagli albori piantati nei sixties, ma sviluppandosi soprattutto dalla scuola susseguente, quella nata sul finire dei Settanta per opera di formazione quali The Teardrop Explodes e Soft Boys e che si sta sempre più imponendo grazie ad etichette come la Fuzz Records, festival come l’Austin Psych Fest e band quali Tame Impala, Gang Gang Dance e soprattutto, almeno per le similitudini stilistiche con i nostri oranges e Singapore Sling. I sette pezzi che si succedono nei circa trentotto minuti dell’album sono una cavalcata di ritmiche ripetitive, chitarre distorte quanto basta, fuzz e noise, e una voce tagliente e ben calibrata e modulata anche in fase di registrazione. Non c’è la potenza pura, introspettiva e violenta di certi Dead Skeletons in quest’album, né l’enigmaticità di un Henrik Baldvin Björnsson o la tecnica conturbante di Kevin Parker e soci, ma ciò che rende Futurecent tanto accattivante, quanto valido e spettacolare all’ascolto, è la capacità di mescolare le diverse parti, senza lasciare mai che sia una di queste varianti a emergere ma piuttosto facendo in modo che i brani acquistino un’essenza propria, che sappia accontentare i più cupi come i più attenti al lato melodico, i più nostalgici tanto quanto i più tesi verso l‘ostentazione del nuovo. Futurecent trova la forza proprio dove tanti altri hanno trovato il proprio declino. Alla ricerca simultanea di svariati mondi, c’è chi si perde nell’universo e chi scopre nuove forme di vita.
Recensioni | novembre 2015
Max Richter – Sleep (Modern Classical, Post Minimalist, 2015) 7,5/10
Capolavoro totale per il compositore britannico (lo trovate qui) che confeziona un’opera titanica la quale, anche per la durata che supera le otto ore, vuole essere realizzazione perfetta da assimilarsi durante il sonno. Disco dell’anno, se siete capaci di andare oltre le barriere del Rock e della forma canzone.
Ought – Sun Coming Down (Art Punk, 2015) 7/10
Secondo album eccelso per la band degna erede dei grandi Television. Tra le migliori e più originali formazioni Post Punk di ultima generazione, qui raggiungono il loro apice creativo.
Kathryn Williams – Hypoxia (Folk Pop, 2015) 7/10
Arrivata all’undicesimo album, la cantautrice britannica compone un concept ispirato al romanzo La Campana di Vetro della tormentata poetessa Sylvia Plath. Atmosfere soavi, minimaliste, ma di una notevole intensità. Da ascoltare in solitaria. Consiglio l’esilio su un’isola deserta.
Dhole – Oltre i Confini della Nostra Essenza (Post Hardcore, 2015) 6,5/10
Pregevole incastro di strutture sonore Post Rock e cantato Scream per questo quartetto lodigiano agli esordi, matasse di distorsioni da cui lasciarsi avvolgere mentre le liriche colpiscono violente. Un debutto meritevole di spazio nel consolidato panorama nostrano del genere.
Open Zoe – Pareti Nude (Pop Rock, Post Punk, 2015) 6,5/10
Carico di echi delle esperienze Alt Rock italiane anni 90 il primo disco di questa band veneta, armata di tradizionali basso-batteria-chitarra, a cui si aggiungono pochi tocchi di elettronica e un timbro vocale femminile che conferiscono un gusto catchy e contemporaneo al risultato finale.
Il Mare Verticale – Uno (Alternative Pop, 2015 ) 6,5/10
Non è semplice fare un bel demo. Bisogna essere esaustivi nel saper dar sfoggio di sé e delle proprie abilità compositive, senza strafare e risultare pesanti. E su questo Il Mare Verticale, con Uno, ha saputo davvero fare bene. Il disco apre con “Tokyo”, un brano Alternative Pop delicato, a cavallo tra Afterhours e sonorità Indie nordeuropee, che chiarificano subito timbri e accorgimenti che la faranno da padrone: arrangiamenti mai scontati per quanto perfettamente in stile, liriche (in italiano) trattate più come pretesto fonico che come significanti, atmosfera galleggiante e onirica, che sfocia naturalmente in “Non Luoghi”, con i suoi echi alla Radiohead. “Spuma” è forse la più italiana di tutto il lavoro della band romana, con richiami alla produzione di Benvegnù e Gazzè su tutti. Il disco chiude con “Elaborando”, che, quasi in maniera volutamente descrittiva, si connota in fretta come il brano più complesso tra i cinque, con i suoi ritmi marcati e il sound più cinematografico.
Prehistoric Pigs – Everything Is Good (Instrumental, Stoner, Psych Rock, 2015) 6,5/10
Distorsioni e spazi immensi, sabbiosi e oscuri. Un viaggio interminabile (otto brani per quasi un’ora di musica) tra i più desolati deserti descritti da un trio non sempre impeccabile e fantasioso, ma che cerca perennemente il suo suono, incastrando la chitarra di Jimi Hendrix nel caldo torrido dell’Arizona. Peccato manchi la voce, avrebbe potuto dare maggior senso e maggiori vibrazioni a questo serpente sporco, vorace e velenosissimo.
La Casa al Mare – This Astro (Dream Pop, Shoegaze, 2015) 6,5/10
Viene da Roma il terzetto che compone La Casa al Mare, con sonorità che non posso che richiamare subito una certa produzione Pop anni 80: voci indietro sullo sfondo, chiamate a far le veci di un vero e proprio strumento aggiunto, chitarre quasi prepotenti, seppure senza giri virtuosistici, effetti trasognani e riff ariosi e cantabili. This Astro apre con “I Dont’ Want To” che per i primissimi venti secondi sembra richiamare quasi gli Smashing Pumpkins e poi cede il passo allo Shoegaze in “Sunflower” e “M, particolarmente interessante per le aperture armoniche e il trattamento della dinamica. La mia preferita del disco risulta però essere “At All”, che suona come un brano degli Indiessimi Yuck. La costruzione dell’impianto sonoro cambia leggermente in “Tonight or Never”, in cui ogni elemento emerge con una brillantezza che sembrava mancare nelle tracce precedenti. L’EP chiude con “CD girl”, una traccia à la Raveonettes o My Bloody Valentine. Nulla di nuovo dunque, ma neppure qualcosa da cui rifuggire come la peste.
A Copy for Collapse – Waiting For (Electronic Synth Gaze, 2015) 6/10
Interessante duo barese che si muove agevolmente sulla via dei vari Telefon Tel Aviv, Mouse on Mars e The Postal Service. Qualche richiamo alla Dance Music poteva essere evitato. Sound anni 80 per chi non è fanatico degli anni 80.
Mimosa – La Terza Guerra
Attrice teatrale e cinematografica, ancor prima musicista, Mimosa Campironi esordisce con La Terza Guerra, un disco che racconta storie di donne ed amori, a volte violenti, a volte sbagliati. In undici brani viviamo una serie di capitoli in cui le carriere parallele della cantautrice si coniugano in continuazione come se ci trovassimo davanti a una risposta italiana alla statunitense Amanda Palmer: rimembranze del suo Dark Cabaret sono, difatti, presenti nella titletrack. E il che non disturba. Veniamo mandati indietro ai tempi del film muto e della comicità di fine Ottocento. “Arance” e “Fame D’Aria” ci ricordano con veemenza che ci troviamo nel 2015 e Mimosa regala magie con il suo pianoforte, molto più contemporaneo. E anche questo non è un male. “Gli Effetti” torna sui binari isterici dei Dresden Dolls: teatralità e giocosità a iosa. Dal sorriso alle lacrime in quanto la successiva “Fakhita” è dedicata alle donne trovate uccise in Africa, di cui spesso non si conosce neppure l’identità. Un episodio toccante che fa lievitare il voto di almeno mezzo punto. Delle seguenti composizioni segnalo “Voglio Avvelenarmi un Po’”, che gode di una ritmica che segue appieno la voce recitata dell’artista. Purtroppo sul finire regna una certa stanchezza dove il messaggio delle canzoni deturpa le canzoni stesse. Teatrale, sognante, triste, talvolta divertente: La Terza Guerra è tutto questo e molto più. Un album attuale concepito nel passato da una mente che ha un’esperienza enorme a dispetto dei suoi ventinove anni. Il confine tra arte e musica non è mai stato così labile.
Frisino – Tropico dei Romantici
Tropico dei Romantici non è un nuovo parallelo terrestre dedicato agli innamorati, ma è il titolo dell’album di debutto di Antonio Frisino, in arte solo Frisino. Pugliese di nascita, è un cantautore giovane ma al tempo stesso “d’epoca”, che propone un Pop immediato, orecchiabile con marcati richiami a melodie d’antan e uno stile che trae spunto dai grandi cantautori italiani degli anni 60 come Battisti ed Endrigo, ma anche da autori più moderni come Dalla, Conte e Venditti, senza escludere i contemporanei Di Martino e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Tropico dei Romantici è un album classico dove la forma canzone strofa-ritonello-strofa è padrona assoluta, anche se i vincitori indiscussi sono i ritornelli coinvolgenti e diretti, dei veri e propri tormentoni già dal secondo ascolto, come nei brani “ Lontanissimo” e “Che Cosa Vuoi da Me”. Frisino, da bravo cantautore, pone molta attenzione alle storie che racconta e come, anticipa il titolo, il territorio sul quale si muovono i dieci brani è l’amore, sentimento che impregna totalmente i testi, che si tratti di riflessioni amorose, storie reali o incontri immaginari. Il punto di vista si sposta di frequente, a volte è personale altre è quello di un semplice narratore, ma da qualsiasi prospettiva Frisino ci propone un ritratto spesso amaro a tratti nostalgico del sentimento per eccellenza. Si parla di tradimento in “Con o Senza di Te”, di rimpianti amorosi in “Domani è un Altro Giorno” o rotture disastrose in “Le Tue Parole”. Nonostante le pene d’amore narrate le melodie, altro punto fondamentale del disco, sono leggere, ritmate, ammiccanti, i suoni sono puliti, ariosi senza ombre e tormenti atavici. La delicatezza di Frisino e degli arrangiamenti dona ai brani intensità e veracità privandoli della parte più oscura e cupa. Tropico dei Romantici è un album per cuori teneri, per la maggior parte autobiografico, ma che racconta esperienze e sentimenti universalmente condivisibili che generano immediata empatia e coinvolgimento. I brani sono fatti per essere ricordati facilmente e richiamano alla mente le canzoni di Dalla e Battisti, che hanno cresciuto due, se non tre generazioni d’italiani. Un debutto promettente per un genere, quello cantautoriale italiano, sempre più ricco e vario.
The Underground Youth – Haunted
Tanta cassa dritta, voce cupa, monotona e suoni sommessi e ovattati. Non è un caso che The Underground Youth provenga dalle stesse terre della più grande band Post Punk mai esistita, i Joy Division. Il solco è quello ma con sfumature sintetiche e psichedeliche maggiori, un’attitudine rivolta più al Gothic che al Punk e un suono tendenzialmente Wave che se non fosse per l’indolenza delle ritmiche sarebbe perfetto per far ballare i vampiri quasi a guisa di violenta Ebm (“Drown in me”). Quelli che sembrano i punti di forza di Haunted finiscono inevitabilmente per diventarne gli stessi limiti. Laddove le chitarre osano con più insistenza, si evidenziano non solo le influenze della band di Manchester ma anche le similitudini con formazioni contemporanee ben più note e talentuose. Stessa cosa possiamo rilevare nella sezione ritmica e se da un lato ci si potrebbe aspettare un qualche conforto dalla voce, non resta che rassegnarsi anche alla sua banale piattezza e timbrica involontariamente sgradevole. Tutte queste considerazioni sembrano far protendere il giudizio verso una solenne bocciatura eppure c’è qualcosa di buono in questo settimo Lp della band formatasi solo nel 2009 (certo quello che non le manca è la prolificità). Quando le derive psichedeliche si fanno più marcate e Craig Dyer e soci prendono le strade più Experimental Noise Rock (la parte iniziale di “Self Inflicted” ad esempio o “The Girl Behind” che può ricordare certi Have a Nice Life o ancora “Slave”) mostrano tutto il loro potenziale talento e il rimpianto è di non aver assistito alla definitiva crescita stilistica di una formazione che probabilmente avrebbe potuto dare molto di più al genere pur avendo fornito prova di evoluzione considerevole rispetto agli esordi.
Jesus Dies Alone – Jesus Dies Alone
James Rossetti (alla voce) e Marco De Masi (a tutto il resto: chitarre, bassi, sintetizzatori, cori), dopo avventure varie sotto altrettanto vari moniker, si stabiliscono definitivamente nella nuova casa Jesus Dies Alone con l’esordio omonimo, porta d’ingresso di un palazzo sintetico e polveroso, oscurato da uno spleen onnipresente e accidioso. Voci strascicate, basse, in un mare di sintetizzatori e batterie finte che creano una penombra che rischia troppo spesso di risultare posticcia e poco a fuoco. Le canzoni ci sono, anche se non sorprendono né innovano nulla; le movenze sono mimetiche, tendono a farsi dimenticare, e i suoni non catturano, non conquistano. La voce pure c’è, o almeno ci prova, ma non riesce (nemmeno lei) a superare la china e a farsi trovare oltre un orizzonte che, dietro la bruma, s’indovina ancora lontano. Un disco che fa il suo senza risultare particolarmente geniale, che dimostra quel tanto di stoffa che può bastare per non risultare fastidioso, senza però quel valore aggiunto che gli farebbe superare con un salto la mera sufficienza.
Tymon Dogg – Made of Light
La luce artificiale in copertina potrebbe ingannare. Una luce fredda e squadrata che poco si intona con il violino del musicista britannico. Cinquant’anni di carriera e un portfolio da far raddrizzare tutti i peli in corpo. Collaborazioni con Paul McCartney, James Taylor, Jimi Page, The Moody Blues, Ian Hunter. Per non parlare della sua fraterna amicizia con Joe Strummer, che l’ha portato a militare anche nei Mescaleros (stupendo il suo violino in “Silver and Gold” dall’album “Streetcore”). La luce è dunque vivida, offuscata dalle nuvole della Gran Bretagna, bagnata come la rugiada e bianca come la pelle dell’ormai sessantacinquenne Tymon Dogg. Made of Light è un album estremamente maturo eppure così vicino alle radici della musica Folk d’oltremanica, con un piede nella prateria e uno verso la grande città. Un suono di altri tempi trapiantato nel 2015. La forza della sua voce e del violino vengono subito sprigionate dalla rabbiosa “Conscience Money”, violenta, virale, quasi a risvegliare Strummer e i fantasmi della ribellione. “A Pound of Grain” è proprio un inno al veganesimo. A detta di Tymon la canzone è stata proprio ispirata dai discorsi con l’ex Clash riguardo lo sfruttamento degli animali da parte dell’uomo. I suoni sono acustici ma risuona in ogni nota la prepotenza del Punk degli anni d’oro e quello spirito gypsy che strappa sempre un sorriso sulle labbra. La title track è intensa, liturgica, grido straziante a richiamare un Dio dimenticato. Qui Tymon si fa accompagnare da chitarre classiche, mentre il violino innalza la voce verso il cielo. Le sfaccettature di questo disco non finiscono qui; “Like I Used to Be” e “Perfect Match” sembrano rubate ai Beatles di Revolver, un bel sorriso in un giorno esageratamente estivo in un paesino d’Inghilterra. La melodia danza indisturbata anche nella meravigliosa ballata “As I Make my Way”, simbolo della spontaneità e della semplicità di questo onestissimo musicista. Un canto quasi ubriaco, e per questo vera quanto mai. La voce di Tymon Dogg è tremendamente inglese e tremendamente saggia, in una canzone è capace di descriverci la meraviglia della vita buttando dentro suo padre, suo figlio e tutto se stesso. Aggiungiamoci la forza di un violino Punk mai troppo invadente e di una luce tutt’altro che artificiale, capace di illuminare il nostro paesaggio creando colori abbaglianti e ombre che con questo suono fanno meno paura.
L’Introverso – Una Primavera
“Mi rialzo da me, mentre affondano i marciapiedi”. L’Introverso da Milano stanno per dare alle stampe il loro primo album, Una Primavera, lavoro che parla di sconfitte incassate e di immediate resurrezioni con un taglio Brit Pop, Indie Rock. Dall’opener “Tutto il Tempo”, gradevole presa di coscienza di stampo Coldplay (anche se a loro piacciono gli Oasis) si passa a “Manie di Grandezza”, pezzo con volontà catchy dal ritornello orecchiabile che risulta essere il brano centrale del lavoro ma che non riesce a pieno nell’intento del singolo spaccatutto, vittima di un eccessivo controllo e determinismo. D’improvviso però ci troviamo di fronte ad un calo, un freno a mano fisiologico poco motivabile che una band apparentemente “macchina da guerra dal vivo” non può di certo permettersi: “Il Finestrino” parla (anche) di sesso in macchina ma non percepiamo nulla di un momento così intimo; “Uguali” sceglie un arrangiamento irritante di stampo sanremese come anche “Prima o Poi”. Cosa succede, quindi? I quattro di Milano, e questa è una nota di gran merito, hanno ascoltato, studiato e fatto proprie molte formule tipiche del Brit Pop senza però, e questo è il problema, riuscire a plasmare un prodotto nuovo e fresco e rimanendo spesso aggrappati a un certo Pop melodico italiano da (bassa) classifica. Ma non tutto è perduto, un disco va ascoltato fino alla fine per dare un giudizio. Sai che c’è, potrebbe andare meglio e credimi avrei diritto al meglio. Sento di rinascere, da oggi voglio una primavera per me: questo estratto dalla traccia di chiusura “Primavera” racchiude l’essenza di ciò che L’Introverso vuole esprimere. Semplicità, molto contenuto e una poetica diretta e precisa che, insieme a “Estranea” (dentro c’è tanto Marlene Kuntz) va a risollevare le sorti di un lavoro indubbiamente sopra la sufficienza ma a tratti incomprensibilmente tedioso. L’introverso ha idee, know-how e voglia ma per arrivare dritti al cuore dell’ascoltatore (come afferma lo stesso Nico Zagaria, voce della band), magari proprio come un “Pugno allo Stomaco”, bisogna liberarsi dalla gabbia virtuale e cercare di osare sempre di più.