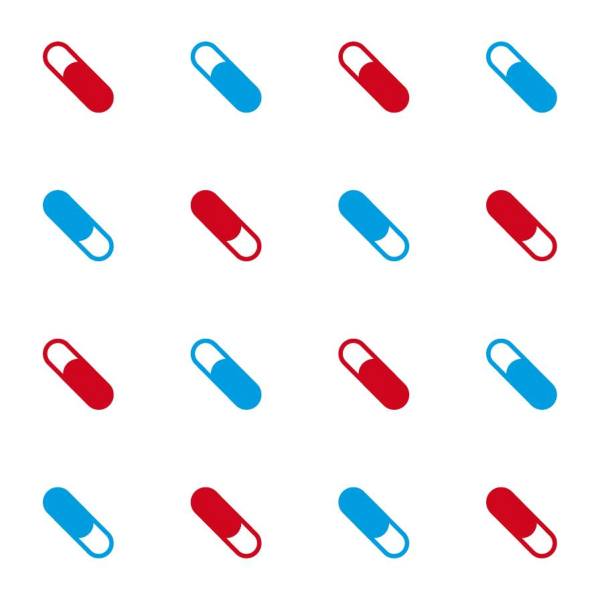Lo ammetto, sono partito con il piede sbagliato. Lo ammetto, mi aspettavo altro. Lo ammetto, sono senza parole. Lo ammetto: i Dropeners hanno letteralmente vinto!
I Dropeners nascono nel lontano 2008 e, dopo aver accumulato un incredibile quantitativo di esperienze (soprattutto estere), tirano fuori il lavoro di cui sto per dire: In the Middle. Il disco d’esordio si fa vivo nel 2009, sotto il titolo di Drops of Memories e fra questo ed il capitolo oggetto di discussione, s’intermezza un EP risalente a ben quattro anni fa: Silent Sound (EP). Si sono fatti parecchio attendere a quanto pare, ma il motivo lo scoviamo in breve ed è nascosto dietro ognuna delle dieci tracce che formano il loro secondo disco. Il sound, complice dell’inglese adottato in ogni parte del lavoro, lascia fraintendere l’interlocutore medio e fa sì che si attribuiscano i meriti dell’opera ad esperte menti anglosassoni. Ma qui siamo innanzi a tutta roba made in Italy: vengono da Ferrara, sono autoprodotti e non hanno nulla da invidiare al meglio delle band internazionali. You won’t get a second chance to make an extraordinary firts impression, diceva qualcuno e i Dropeners dimostrano di saperlo bene, curando l’aspetto di In the Middle in ogni minimo particolare. Il packaging è leggerissimo, minimale ma efficace (ammetto anche questo: ho un debole per il packaging). La copertina lascia intendere un egregio lavoro introspettivo, confermato ottimamente dal contenuto del disco, attraverso una musica penetrante, grazie ad un New Wave ben articolato ed a sonorità molto lente e buie. Lo confermano i Dropeners stessi in “Western Dream”, che fa da titoli di coda al film surreale che i registi ci propongono: in the middle of western dream, there’s a light that comes from the east, recitano per tutta la durata della traccia. Il theremin in questo capitolo gioca un ruolo essenziale, evidentemente. Penetrante. Ossessivo. Possessivo. Ipnotnico.
All’interno di questo straordinario lavoro troviamo spunti di verde invidia per il migliore Dave Gahan, quello che si cimentò nell’incredibile opera di “Saw Something”. È come se i Dropeners avessero preso spunto da questa singola traccia, depurandola dall’eccessiva vena elettronica per poi ampliarla, estenderla e costruirci su un intero album. Ma non è tutto. Lo spazio artistico toccato è incredibilmente vasto: si sfiorano le corde dei Coldplay in “Lead Your Light”, appesantendole con i migliori Radiohead di OK Computer. Nel secondo capitolo (“You Don’t Know”) è possibile persino scovare un nonsoché di Gothic, di scuro, che lascia sovvenire alla mente vecchi ricordi di HIM e The Rasmus, light version. Ma i Dropeners non amano paragoni e non vogliono di certo essere la copia di mille riassunti e, nonostante riportino in vita questa scia di fine anni Ottanta, sanno bene come rinnovarla. Sfruttando, infatti, la propria conoscenza musicale e strumentale, si trasformano in polistrumentisti, riscoprendo in un’ottica del tutto nuova il sound sopra citato. Così, la voce e chitarra Vasilis Tsavdardis si cimenta in eccezionali imprese al synth e la chitarra di Francesco Mari sperimenta trombe e theremin (che gioca il ruolo di psicanalista nell’analisi introspettiva condotta dal disco), accompagnando perfettamente il basso di Enrico Scavo e le batterie di Francesco Corso. L’armonia è inevitabile, essendo che lo strumentale poggia direttamente sulla melodica voce di Tsavdardis, lunga, bassa e sempre in perfetto tono, accompagnandola lungo la stesura di ogni capitolo. Insomma dieci tracce di puro intelletto ed organicità, con tanto di ghost track, come non se ne vedevano da un bel po’. Potremmo andare avanti per ore, il disco fa parlare di sé come fosse parte di noi stessi. Penetra letteralmente nel più profondo dell’inconscio e ci lubrifica l’animo. È un lavoro che vale l’attesa, tutta. Signori, siamo innanzi ad un ottimo allievo. Stimolarlo a far di meglio potrebbe essere controproducente. Conosce i suoi obiettivi, sa chi è e sa dove vuole arrivare: nell’io di ognuno di noi. Nel mio ci ha messo le radici e nel vostro?