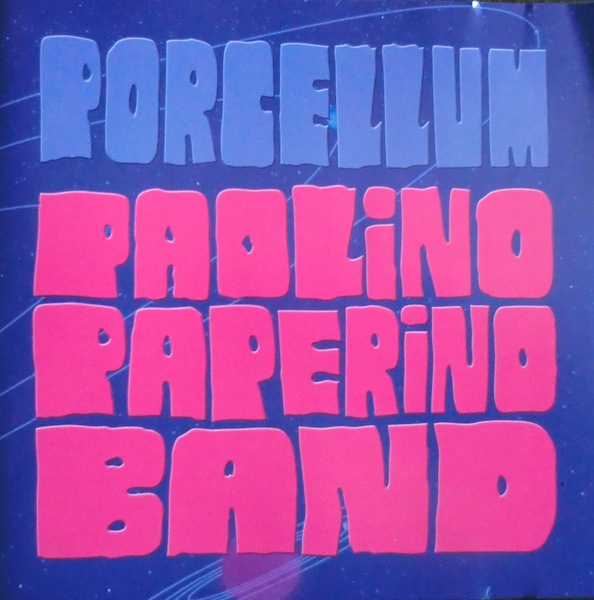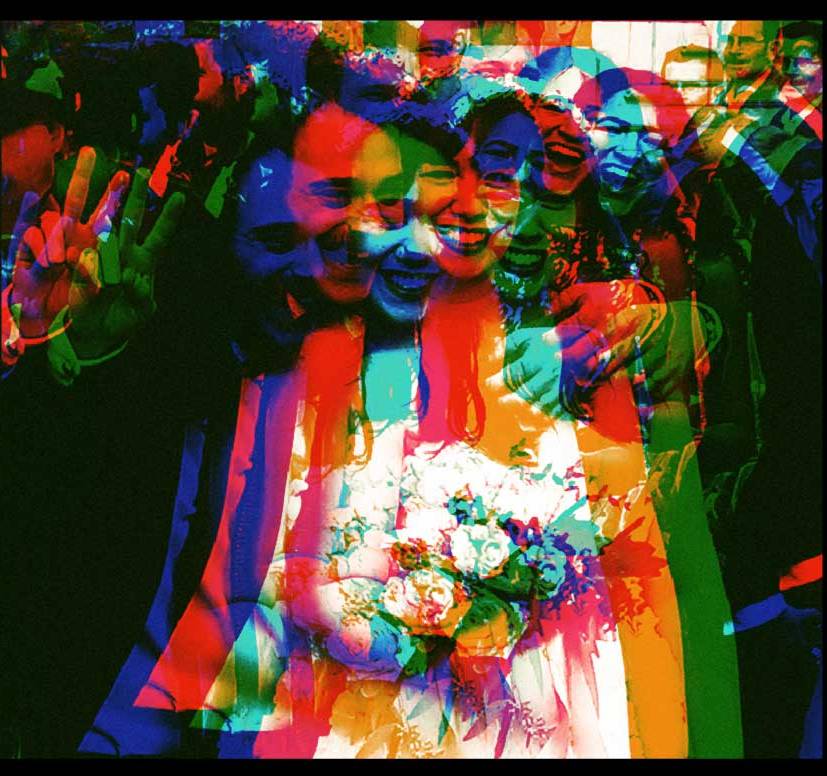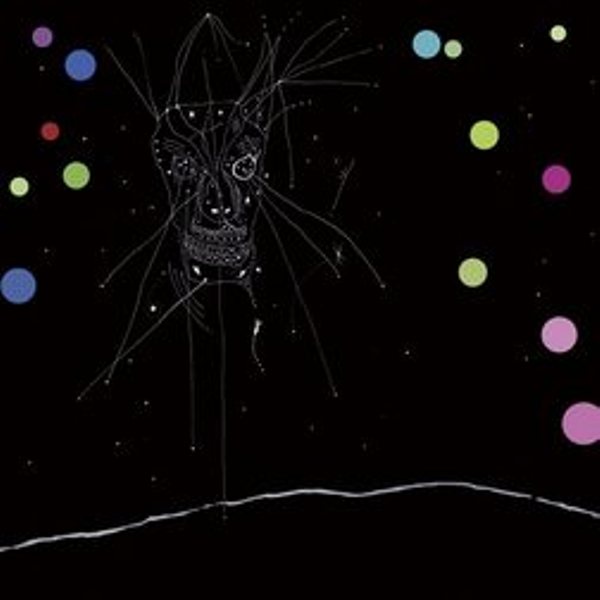In quel di Milano il settore artistico non conosce domeniche e propone di recente un nuovo interessante lavoro: Crash Test. Un disco scritto ed interpretato da Paolo “Bandit” Bandirali ed arrangiato da Luca “Bitti” Cirio, firmato Bandit. Il lavoro si sviluppa in una tracklist lunga nove click di Folk Rock, caratterizzato da testi impegnati (che a tratti rimanda al Rock n Roll di Bennato). Nella prima parte del disco, in particolare, si caratterizza per un alternarsi di musica ed intermezzi parlati (che richiama lo stile live degli Zen Circus), che fanno da introduzione alla traccia a seguire. Di certo una trovata molto originale (ed un’ottima opportunità per dar spazio ad un po’ di sano sarcasmo), che tuttavia spezza un po’ troppo l’armonia stessa del disco, portando l’ascoltatore allo skip degli intermezzi già a partire dal secondo ascolto del disco. Ciononostante, siamo innanzi ad un lavoro piuttosto maturo e che si fa ben ascoltare dall’inizio alla fine. L’album di debutto sembra avere seri intenti comunicativi. I temi, di elevato impatto con l’attualità, ruotano costantemente intorno al tema della vita, spaziando da intellettualismi del saper vivere, a romanticismi della necessità di amare (riprendendo al riguardo un amore a lunga conservazione già cantato dai Marta sui Tubi in “La Spesa” ben sei anni fa), a malinconiche, statiche prese di coscienza dell’io. Si esce fuori tema in traccia sette (“Quando C’Era Lui”), che, mio malgrado, suona un po’ come una nota stonata in un disco di così elevato contenuto morale. Non tanto per lo strumentale, il quale mantiene la sua vena accattivante, quanto per il testo, che la rende il vero neo del disco. Politica e musica sono due arti differenti: cantare la politica è un po’ come cantare un dipinto.
Il lavoro esordisce in prima battuta con “La Crisalide”, che senza dubbio merita qualche riga. Lo strumentale, impegnato in ritmiche Country e Folk che si fanno ben apprezzare, viene poetizzato attraverso un testo ricercato e di certo non banale. Il perno è il crivello del vivere la vita, del se è giusto o sbagliato viverla secondo lo standard collettivo. Ed all’interrogazione a scuola, nasce bene la risposta mi scusi prof ma io non ho tempo da perdere, meglio essere crisalide che ha tempo ventiquattr’ore per vivere al meglio. La scelta di aprire il disco con un pezzo così ben lavorato è (volutamente o meno) strategica e conduce inevitabilmente all’approfondimento dell’intero lavoro. La strategia si mantiene sofisticata, approdando alla terza traccia e realizzandosi stavolta attraverso uno stile cantato pressante che fa subito pensare al timbro martellante del Cristicchi (ancora una volta un forte riferimento). Il tema della vita accompagna una buona parte del disco, ritornando anche nella traccia numero cinque (che dà il titolo al disco). Stavolta si toccano le corde della malinconia, garantendo un inevitabile rifugio a chi l’ascolta. D’altra parte, la vena malinconica accomuna un po’ tutti ai giorni nostri. Ciò non toglie che siamo innanzi ad un buon lavoro, che merita molto più di un ascolto. Ottima sintesi del disco.
Il disco si chiude quindi con un mix fra il sound di Samuele Bersani e la versione Folk di Brunori Sas, addobbato ancora una volta con un testo che lascia ben poco spazio alla polemica. Il tema della vita che ha aperto il lavoro si ritrova così a ricamarne i titoli di coda con un richiamo lungo 4’02’’. Un gioco di parole lungo una canzone intera, lavorato al dettaglio fra assonanze e rime prepotenti che in modo instancabile chiamano all’appello la vita. Titolo: “La Vita”. Ed è così che il prologo si confonde con l’epilogo attraverso un piccolo dettaglio, che genera una ciclicità all’opera che si fa molto apprezzare. Dettaglio che, in questa sede, non trovo onesto svelare, ma che a parer mio, è una trovata prossima al geniale. Fossi al bar a parlar con amici, direi che è un ottimo disco, consigliandone l’acquisto (consiglio che, scoprendo gli altarini, dispenso anche a me stesso). Ma qui siamo alla correzione dei compiti di inizio anno e la severità non può essere opzionale. Il paroliere Paolo “Bandit” Bandirali meriterebbe senza dubbio un voto alla portata dei suoi ricercatissimi testi, ma il consiglio ha deciso di provocare la sua vena artistica, portandolo appena oltre la sufficienza. In rosso sul compito ho dovuto segnare le troppe ispirazioni mal celate. La musica è un tema, non un testo di reportistica.