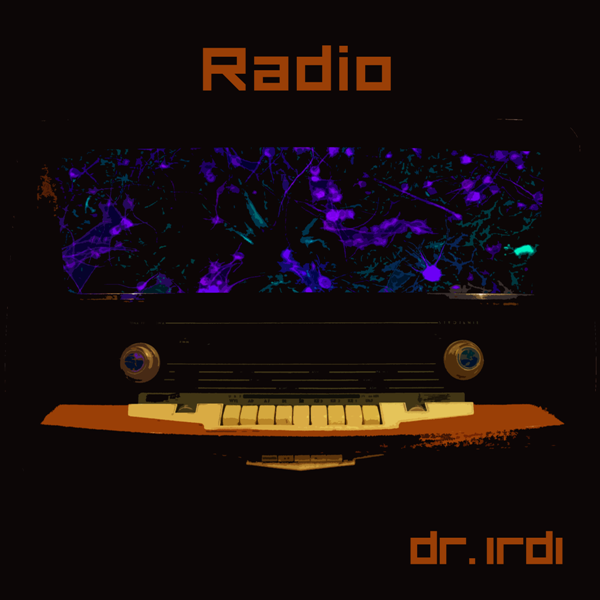Il titolo del primo disco solista di Federico Bagnasco, diplomato in contrabbasso, esecutore militante in orchestre e formazioni di vario genere, arrangiatore, compositore, è una metonimia: il legno altro non è che il contrabbasso stesso, emanazione diretta, in questo caso, della fisicità dell’autore e del suo spirito. Il disco, interamente musicale, è una sperimentazione incessante di tutte le potenzialità fonico-timbriche del contrabbasso, potenziate e amplificate con l’ausilio dell’espediente elettronico. Si va da echi più classici, a tratti puntellati di contrappuntismo bachiano, come in “Spire” e “Apnea”, si passa per sonorità quasi etniche che rimandano ai didjeridoo in “Tempo al Tempo”, fino a successioni scalari dal sapore debussiniano di “Coincidenze Combinate”. Il suono del contrabbasso, in realtà, è meno elaborato elettronicamente di quanto l’incipit possa lasciar intuire. Le tracce successive, infatti, non sono che un’esplorazione timbrica delle diverse altezze che lo strumento può intonare, conducendo l’ascoltatore in una specie di trance estatica che si risveglia al settimo brano, “Velato”, con dissonanze struggenti che aprono a solari accordi maggiori inaspettati. Intensa è “AbIpso”, in cui addirittura si può sentire il respiro di Bagnasco che accompagna il gesto musicale in un crescendo agogico, dinamico e patetico che non può lasciare indifferenti. L’arrangiamento elettronico – più una modifica dell’onda che una vera e propria manipolazione tout cour – si percepisce in “Sterpi e Frattaglie”, dove echi delay e distorsioni creano un’atmosfera paurosa: l’impressione è di essersi realmente persi in un bosco fitto e insidioso da cui non c’è scampo alcuno. Con “Legno Pesante” si torna a sonorità tribali ed etniche, che proseguono, per certi versi, in “In Vano”, la traccia forse più sperimentale di tutto il cd, che sfocia in un atteggiamento chitarristico – se mi concedete il termine – nella successiva “Comunque”. Un certo Noise orchestrale regola e anima “Residui”, mentre il disco va a chiudersi in una marina e onirica “Lunari di Giada”. Il rischio di cadere nella noia – mai nello scontato, questo no – è altissimo per un lavoro del genere, eppure Federico Bagnasco riesce a catturare l’attenzione dell’ascoltatore traccia dopo traccia. Un disco da meditazione, di quelli da accompagnare con una buona grappa e una certa quantità di sigarette e pensieri. Mai banale e davvero consigliato.
Ambient Tag Archive
Intervista a Mario Sp
Mario D’Angelo, in arte Mario Sp, è un Dj producer di ultima generazione che, nei recenti mesi, sta provando a emergere nel panorama Deep Techno grazie anche a diverse collaborazioni con etichette di rilievo quali Klop Music, Bosom, Cubek Label e Klaphouse Records. Lo abbiamo incontrato per parlare del ruolo dell’Elettronica oggi e di quello che può esserne il suo futuro.
TreesTakeLife – Sounds From Today
TreesTakeLile è un progetto musicale nato nel 2009, un trio di ragazzi romani con un approccio musicale trasversale, focalizzato sui suoni e sul loro utilizzo. I progetti che li vedono coinvolti, sono tanti e per lo più prevedono l’uso della musica come sostegno e supporto alle immagini, ma non mancano le vere e proprie produzioni strettamente discografiche, e infatti dopo un EP e un primo album esce, a tre anni di distanza dal precedente, Sounds From Today. Sei tracce autoprodotte, che racchiudono in sé la sostanza dei TreesTakeLife, musica, emozioni e immaginazione. I suoni sono moderni, elettronici, universali e contemporaneamente portatori di piccole cose, facile lasciarsi trasportare dal flusso di connessioni e immagini. “Alym” e “Neptunes”, sono le tracce più ricche di Elettronica e di beat, hanno una natura duplice che si destreggia tra morbidezza e algidismo, la prima più aliena e distante, un ricco e brulicante mondo sotterraneo in fermento; la seconda gioiosa, ritmata, acquatica, gentile con chi vi s’immerge. “Space”, pulsante e ripetitiva è la cosa che più si avvicina a un brano strumentale Post Rock, ma in versione più asciutta e minimalista. “Come Back” è calda e avvolgente, soprattutto grazie alla chitarra acustica e ai cori, è la traccia più terrena di tutte, il suono di un’ancestrale festa contadina. Chiude l’EP “Outro” la più breve e primordiale, che attraverso riverberi profondi e basso sembra lasciarci con un mantra viscerale. Sound From Today è album intenso con una portata ampia e un grande potenziale interpretativo da parte di chi ascolta. I TreesTakeLife dimostrano con questo nuovo tassello di essere un progetto olistico nell’accezione più pura, quella da “Treccani”, che li rende una realtà che nel suo complesso presenta delle caratteristiche proprie che vanno aldilà della somma delle sue parti. Un ascolto per chi ama lasciarsi trasportare dalla musica e immaginare quale forma potrebbe assumere, come quando da bambini si giocava con le nuvole.
TreesTakeLife _ Come Back from Renato Muro on Vimeo.
Takaakira “Taka” Goto – Classical Punk and Echoes Under The Beauty
Takaakira “Taka” Goto è conosciuto per essere il chitarrista dei MONO, band strumentale giapponese che miscela Shoegaze e musica classica, minimalismo e Rock sperimentale. Questo Classical Punk And Echoes Under The Beauty è il suo primo album solista, scritto e registrato nel 2003 ma mai completato, e ora pubblicato così com’era, grezzo e poco rifinito. Sette tracce di archi e pianoforti che creano soundscapes da colonna sonora, con andamenti larghi e che qua e là fanno spazio a batterie semplici e ruvide, dai suoni sporchi e approssimativi, in un connubio che si può definire al massimo “curioso”. Le chitarre sono rare: qualcosa in “Isolation”, poi soprattutto rumori, distorsioni, ma senza esagerare, solo sullo sfondo. Un disco abbastanza innocuo: le singole tracce si lasciano ascoltare come un piacevole sottofondo, ma non hanno un’identità abbastanza forte per appassionare o convincere al riascolto. Sorprendentemente poco interessante.
Cravagoide – Empty Frame
Empty Frame dei Cravagoide, duo di Elettronica strumentale da Brescia, parte dall’artwork per suggestionarci e lanciarci nello spazio vuoto di un abbacinante quadro bianco, che sale oltre le montagne come un sole o comunque un’apparizione, da accettare così com’è, senza troppe spiegazioni. E così sono i dieci brani che compongono il disco: Elettronica suadente, rilassata, con ritmiche sommesse e soffuse, che avvolge come luce. È musica albeggiante, emotiva ma soffocata, che intrattiene sullo sfondo, che non distrae e non colpisce duro: accarezza. Pregio e difetto di un disco che non stupisce ma forse incanta, che non inventa ma suggerisce. Ci si perde dentro Empty Frame, come in un labirinto fresco, un giardino celeste. Ma quando ne si esce si è esattamente come prima.
Chelidon Frame – Framework
L’esperienza Chelidon Frame nasce nell’autunno dello scorso anno ma muove i suoi passi e affonda le radici molto più in là negli anni, negli albori della Musica Concreta e negli studi di Pierre Schaffer che, nel 1948, teorizzò una nuova consapevolezza sonica basata su effetti acustici esistenti successivamente elaborati, generando musica tendenzialmente elettronica ma partorita da elementi concreti.
Riprendendo in mano quest’idea e passando attraverso Pierre Henry e John Cage, Chelidon Frame confeziona un’opera che miscela l’Ambient dei Prospettiva Nevskij, al minimalismo di Alessio Premoli, nome che si nasconde dietro al progetto. Tutto questo con occhio rivolto al futuro, grazie ad un uso comunque mai eccessivo di droni e divagazioni Noise. Nelle cinque tracce più “Intro” dell’esordio Framework, ci sono le fondamenta della musica Elettronica, la storia stessa del suo autore, le opere più eteree di Brian Eno, la spigolosità di Kevin Drumm e la sensibilità Modern Classical di matrice nordica di Jòhann Jòhannsson, cosa suggerita già dalla lettura celere dei titoli di taluni brani (“JikSven”, “Antartica”).
Dopo la gelida opening che sferza l’atmosfera come freddo polare, sale un’inquietudine oscura, fatta di grevi note ripetitive come tempo scandito da ritmiche minimal e sottilmente celate dietro rumori vaghi, quasi a disegnare l’aurora boreale, tinta solo di tutte le tonalità del grigio (“Taikonauta”). Ancor più conturbanti e impalpabili i quasi otto minuti di “JikSven”, nei quali si scorge una debole sensibilità Rock dentro un cosmo elettronico, in grado di dare forza da Film Score all’album. Nonostante queste prime intuizioni, non esiste un vero filo conduttore, una precisa chiave di lettura che leghi la tracklist, trattandosi di un insieme di brani originali e altri già pubblicati e qui soltanto remixati. È la musica stessa a fare da trait d’union, il legame simbiotico tra le terre più fredde del pianeta e lo spazio siderale è la musica (“Cosmic Hypnosis”). In “Nvs_k3” l’ aria torna pulsante di rigida introspezione mentre a chiudere l’album, i quasi dodici minuti della minimale “Antartica”, la quale, nella seconda parte e in conclusione, regala cenni di Neo Classical gonfi d’una speranza e positività mai ascoltata nei minuti antecedenti, pur mantenendo ferma una certa ambiguità emotiva. Framework è uno straordinario lavoro di un musicista poliedrico e coraggioso che non mira certo all’originalità ma riesce comunque a pizzicare le corde dell’anima e farci sognare, fosse anche un sogno da cui svegliarsi in tutta fretta.
Dr. Irdi – Radio
Dopo l’EP d’esordio ironicamente titolato 2 tornano col full lenght i Dr. Irdi, e no, non si chiama 1. Radio (questo il titolo) è composto da dieci pezzi elettronici che si dipanano tra synth e campioni, voci distanti e citazioni, giocosità combinatoria ed emotività trascinante. L’ho ascoltato in stato di semi-incoscienza, prima e dopo il sonno, e mi ha regalato sguardi su mondi lontani, dalle oscillazioni di “Trapano” alle scalinate a spirale di sintetizzatori e tastiere in “Temporale”, dal Pop sbilenco e altalenante di “Airone” (meticciato di scuola Blur) allo spazio aperto dell’Ambient meditativo in “Euridice”. Potrei anche andare avanti, tra gli scratch Electro Funk di “George Clinton”, il pianoforte saltellante e caleidoscopico di “Weltschmerz” o la sporcizia distorta di “Scimmia”… ok, l’ho fatto, scusate. Quello che volevo dire è che il punto di forza del lavoro è certo il suo saper essere eclettico, e trascinarti per mano intorno al globo, sotto i mari, nello spazio e dentro la tua testa, senza mai fermarsi. Si fa ancora fatica a sentire un’identità precisa nei Dr. Irdi, ma ora è chiaro che questa sia una loro caratteristica peculiare, l’altra faccia della medaglia della libertà di poter andare ovunque, essere chiunque. Radio scivola via tranquillo, dieci pezzi per trentanove minuti, un ottimo condensato di Elettronica casereccia e Pop nel senso più alto del termine, psichico quanto basta per non essere musica da ascensore ma comodo abbastanza per goderselo senza intellettualismi. Unico neo l’utilizzo della voce, nel timbro, nella ritmica, nella cadenza. Tendeva a riportarmi coi piedi per terra, mentre volavo alto nella mia testa e mi sembrava di essere chissà dove. Tutto sommato un disco da riascoltare più volte, per scavarci dentro.
Plus Plus – Psycho
Decisamente non artisti di primo pelo questi Plus Plus, che con Psycho giungono al terzo disco dopo Evils del 2010 e Game Over del 2011. Nella loro biografia si legge che hanno origini inglesi ma che attualmente risiedono in Giappone. E certo è che la loro ultima fatica risente di un certo sapore internazionale, declinato lungo tutte le otto tracce interamente strumentali. Il disco, tutto sommato di durata contenuta, si apre con “This is Based Upon a True Story”, raffinata e solare, dettaglio che contrasta subito con la mia aspettativa, del resto assolutamente ingiustificata, di toni sommessi e atmosfere cupe. La sensazione prosegue con “Jail”, un richiamo all’Alternative Rock romanticone stile Coldplay, etereo e impalpabile, nel quale forse solo la reiterazione di una brevissima cellula melodica dà l’impressione di essere imprigionati. “Piano Song”, vuoi per il nome, è vagamente debussyniana. Ma non solo. Impossibile non ricordarsi subito del leggero tocco Pop pianistico di Yann Tiersen, ad esempio. Le sonorità cambiano leggermente, pur restando acustiche, nella successiva “Dieter Rams”, introdotta dalle corde pizzicate, incaricate di marcare il ritmo e definire la condotta armonica, ricreando un tappeto sonoro adatto ad ospitare, nuovamente, il timbro del pianoforte. Atmosfere visionarie, suggestioni più lisergiche che psicotiche, come vorrebbe invece suggerire il titolo, caratterizzano la traccia che dà anche il nome all’album, “Psycho”: espedienti strumentali che sembrano essere impiegati come musica colta descrittiva, finendo con pochi mezzi esaurienti, per costruire una perfetta scena sonora notturna.
E con la traccia numero sei, “Gentle Man”, la più lunga di tutto il disco, con i suoi cinque minuti e più, capiamo di essere davvero di fronte a fortunati e talentuosi eredi di artisti come Mogwai o Explosion in the Sky. “Plantopia”, a dispetto del nome, ha un non so che di marino: le sonorità sono ovattate e dilatate allo stremo, il tempo si congela in un vuoto capace di circondare e avvolgere l’ascoltatore, esattamente come ritrovarsi immersi nell’acqua circondati dal nulla, eppure sfiorati da tutto. Psycho chiude con “The Rolling Hills of England”, che forse è un richiamo alla terra natia, al passato epico e glorioso e dignitoso dell’Inghilterra che il titolo cita, come si percepisce dai movimenti melodici medievaleggianti che puntellano l’intero brano. Nel complesso è un album davvero ben fatto e che vale la pena ascoltare. Consigliatissimo.
Unalei – A sua Immagine
Vi siete mai chiesti come possa essere un disco che unisce il sound e lo stile degli Opeth e dei Novembre con quello degli Alcest o magari degli October Falls? A sua Immagine è la risposta alla vostra domanda. Il disco è nato dalla mente di Federico Sanna, un polistrumentista cantante che, con l’aiuto di Federico Antonio Petitto, ha creato gli Unalei. La prima cosa da evidenziare in questo lavoro sono, senza dubbio, le sensazioni suscitate dai quattro piccoli requiem: un po’ cupe, un po’ romantiche, spesso riflessive. Non sarà difficile farsi travolgere dalle note di “Senhal”, la traccia d’apertura, come non ci sarà da meravigliarsi se durante l’ascolto di “Fattezze Di Rosa” si rimarrà fermi in silenzio, a fissare il vuoto per perdersi nei propri pensieri. Insomma, parliamo di un disco composto con il cuore, senza troppi tecnicismi e realizzato dai sussulti dell’anima. D’altro canto con delle muse ispiratrici così (sono i mostri sacri citati prima) difficilmente non si è deboli di cuore e A sua Immagine ti mette alla prova. Passiamo alle ultime due canzoni: “Della Carne” che tra tutte è quella più armoniosa e la conclusiva “Il Valzer Della Giovinezza” che mette a nudo la vena classica di Federico. Quest’ultima traccia gioca principalmente sulle tastiere, solo alla fine c’è un piccolo accompagnamento da parte della batteria, si tratta di un dolce e soave finale. Un occhio di riguardo va anche alla limpidezza del sound nonostante il disco sia effettivamente un’autoproduzione. C’è veramente un invidiabile impegno dentro A sua Immagine, il giusto slancio che rende fiducia all’operato degli Unalei. Insomma, il consiglio è di ascoltarli con attenzione, i due ragazzi ci sanno fare e come se non bastasse hanno le idee chiare. Il prossimo passo spetta agli ascoltatori