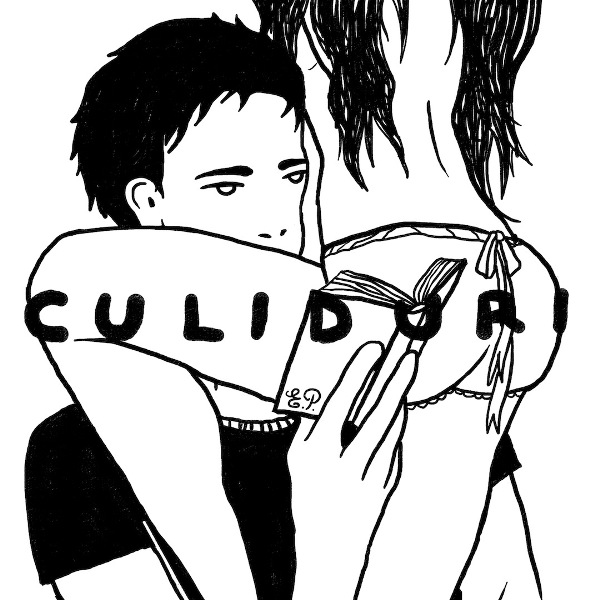2 maggio 2014, tutto è pronto per riportare su foglio un Primo Maggio del tutto alternativo. Fermi tutti! C’è un errore! Il mio pc segna la data sbagliata o sono io che son nuovamente desto? Urca! Questo Primo Maggio è durato un po’ troppo mi sa! “Questa vita mi distrugge”…
Sono le ore 12 in punto. La macchina è carica. Pieno di benzina. Pieno di birra. Pieno di adrenalina. Manca nulla? Destinazione Taranto! Ad accoglierci all’ingresso del parco un ospite del tutto eccezionale, degno del migliore dei Jovanotti: si chiama fango…questo però è reale. Avanzo lentamente alla ricerca di un posto dove adagiare il mio telo, al solo scopo di capire chi sono e perché sono lì. Poi il miraggio. La laguna mi saluta e dona spazio ad una distesa erbosa. Verde. Il mio posto è qui! Ma intanto Caparezza è salito sul palco, io sono distratto e le mie scarpe sono luride. Beh, siamo qui per questo. Il buon vecchio capellone si esibisce a pochi passi dalla sua dimora molfettese e la cosa non passa affatto inosservata. Vuoi che io possa sorvolare e fingere di non aver notato l’infinita platea accorsa a Taranto per l’occasione, vuoi che io possa sorvolare il fatto che siano appena le 15, ma proprio non riesco a sorvolare e far finta di nulla quando mi accorgo che un’elevatissima percentuale degli accorsi sta intonando i testi del ricciolone fuori moda. È inutile a dirsi, qui il Caparezza gioca in casa. E lo fa con immenso stile, donando un’esibizione degna del nome che porta. Un ottimo inizio, azzarderei. La giornata si prospetta interessante.

Vorrei tornare alla mia erbetta e, in effetti, sono lì lì per farcela quando il mio sguardo si posa nuovamente sul palco. Vedo volti noti: sulla sinistra un uomo familiare se la gode, sulla destra una donna dai capelli blu. Sono Fabrizio Pollio e Ketty Passa e si stanno per esibire i Rezophonic. È la prima volta che vi assisto, vediamo come se la cavano i ragazzi. Tutto fila giusto, l’audio è un po’ compromesso e male afferro le parole, ma i ragazzi sanno muoversi e coinvolgere il pubblico (e forse anche loro stessi) con estrema semplicità. Il Pollio (frontman degli Io?Drama) scatta con il suo iPhone foto al pubblico ed agli artisti e chissà perché mi tornano alla mente quei bravi ragazzi degli Offlaga Disco Pax, alla vecchia macchina a rullino di Max, alle foto che ha scattato. Le conserva o le getta via? L’esibizione è già terminata. Poco spazio per così tanti artisti (oltre i 30, mi dicono dalla regia).

Mi allontano e torno al mio posto mentre la voce di Luca Barbarossa (che veste i panni del presentatore) fa un discorso rosso ed invita il pubblico a visionare il prossimo video. Il primo di una lunga serie. Molto lunga. Troppo lunga. Ho tutto il tempo per stravaccarmi sull’erbetta umida e sorseggiare un po’ di sano luppolo, mangiare un che di salutare e navigare in giro per il parco di stand in stand. Che roba! Qui fanno persino lo zucchero filato! Con il palloncino bianco, morbido e appiccicoso torno alla tana e stavolta la voce annuncia la prossima esibizione: si tratta degli SLT Family (acronimo di “Sotto Le Torri”), ragazzotti locali che rappano, strappano, straziano, rompono e si giocano l’unica chance di far sentire cos’hanno da raccontare ad un pubblico ben più vasto del loro uso comune. Cito ancora una volta una frase che mi è rimasta: “Il Rap è come il porno: ci si nasce!” [J-Ax].

Gli Après la Classe (pugliesi anche loro) ristabiliscono l’ordine, riportando la musica sul palco. Poi cedono il microfono ad un gruppo di sofisticato intelletto: i Nobraino. Kruger si presenta vestito al solito modo: alla cazzo. Hanno poco tempo a disposizione per mostrare la loro follia e lo sfruttano al massimo spaziando da tracce proprie (come “Bigamionista” o “Record del Mondo”) a tributi ad artisti di elevato spessore, quali Manu Chao (“Desaparesido”) o Cotugno (“L’Italiano Vero”). La scaletta prosegue, il caro Lorenzo si spoglia della giacca (che stavolta non è quella di Ernesto), si fa spazio e scende dal palco. Lascia che i seguaci assetati gli carezzino mani, corpo e viso. È l’unico a cercare un simile contatto in tutto il festival. Elevatissima umiltà o banale appariscenza?

Le band sono tante, il sole è stanco di sorgere ogni giorno e stenta ad uscire. D’altronde è la festa dei lavoratori anche per lui. Le nubi minacciano pioggia e il fango se la gode. Poi un colpo di corda scaccia via ogni cattivo pensiero ed attrae il mio sguardo sul palco. Direttamente da Roma, i Rubbish Factory se la menano sfoggiando un Metal nuovo di zecca. Risale a novembre del 2013, infatti, il loro album d’esordio The Sun ed in appena cinque mesi ‘sti due romanacci sono riusciti a condividere il palco con nomi quali Afterhours, Caparezza, Capossela, Mannoia e altri a seguire, che tanto la sorpresa è già bella che rovinata. Inutile a dirsi, mi colpirono allora e mi colpiscono adesso. Esibizione degna di nota, nonostante la giovane età del duo.

Fra un Diodato che a Sanremo sta da dio (ma che qui proprio non l’ho capito), un po’ di Municipale Balcanica che fa ballare tre quarti di piazza (ma che alla terza traccia fa ballare ben altra cosa), una Mannoia più rossa della festa dei lavoratori ed una Paola Turci che cantare “Fuck You” senza gli Articolo 31 è stato un azzardo fallimentare (e di questo non mi riesce di perdonarla), la lista si accorcia e si avvicina uno dei momenti pià attesi ti tutta la giornata. Vinicio Capossela si mette comodo sul palco e si gode per un attimo le urla in suo favore. D’altronde sa perfettamente di essere chi è e lo sa a giusta causa. Spazia a lungo attraverso ballate popolari ben acclamate, facendo tappa su una “L’Uomo Vivo” cantanta ad occhio e croce da tutta la platea. Un’esibizione interessante quella del Capossela, come al solito, d’altra parte.

Mancano pochi nomi e quelli di scarso interesse son già passati tutti. È sera ormai e tutti i video che ci hanno proposto (o propinato) hanno stancato ancor più del ballare e delle birre. Rivoglio il fango! Torno al mio posto? Non è il caso, ormai siamo agli sgoccioli e non voglio perdermi un finale tanto atteso. Ed intanto che mi concedo qualche riflessione, Mama Marjas ci riporta per un attimo nell’Africa felice attraverso un Raggamuffin che in realtà sa più di Reggaeton. Il pubblico balla ed i volti sono sorridenti. Non apprezzo il genere, ma riconosco il talento nella sua voce e la sua capacità di scena. D’altra parte la giovane Maria Germinario ha un punto a suo favore: si esibisce in madreterra. Cerco di abbandonarmi al ballo collettivo stile centro sociale che ormai dilaga fra il pubblico e mi accorgo che siamo giunti alla a tale fase della serata. La Mama abbandona il palco e, con grandissima angoscia, i Sud Sound System salgono su accompagnati da una fittissima nube di fumo che oscura il lato est della piazza. L’odore è quello tipico: ‘sti tali hanno confuso la Germinario con la Giovanna! I ragazzotti salentini aprono con una prevedibilissima “Le Radici ‘ca Tieni”, cui non posso negar l’efficacia. Mi abbandono e la canto. Son bravi. In fondo piacciono persino a me. Avanzano con una “Sciamu a Ballare” standard, il che mi porta a pensare che i talentuosi ragazzi marcino oramai da anni sulla scia dei loro successi. Ma non mi va di disprezzare, in fondo l’esibizione è degna di nota ed il pubblico canta. Come se non bastasse sono ospite in casa loro e non mi va di fare il maleducato. È indiscutibile: i Sud Sound System sono una band che funziona, nei centri sociali si, ma funziona (e a quanto pare funziona anche a Taranto al Primo Maggio, com’è lecito attendersi). Dopo l’esibizione, torna la Mama Marjas sul palco, al suo fianco due napoletani belli grossi grossi e mi sento di nuovo a casa. I 99 Posse non se la lasciano cantare dai salentini e rispondono a tono con i loro successi. In Puglia “Curre Curre Guagliò” la conoscono proprio tutti e la giovane barese si esibisce al loro fianco intonando i successi napoletani degli sfegatati comunisti. Da “Antimafia” a “Rafaniello”, passando per “Vulesse”, i 99 Posse prendono l’uscita di scena acclamati e cantati dalla Puglia intera. Complimenti anche a loro, lo ammetto.
Sono esausto. L’odore di marjuana mi distrugge e voglio bere. L’acqua è finita, ma il concerto no. Ora tocca ai Tre Allegri Ragazzi Morti. Conquisto un posto in prima fila e me li godo. “Mio Fratellino ha Scoperto il Rock’n’Roll” mi gasa abbastanza e su “Occhi Bassi” mi fiondo nel pogo. Il colpo basso tirato da “Il Mondo Prima” mi strema ed i jeans si infangano quanto basta. Poi il classico “vaffanculo” chiamato dal palco e gli allegri ragazzi (erano un tempo) si dileguano, lasciando spazio agli operatori di scena. L’esibizione è stata ottima, come al loro solito. Scaletta incredibilmente breve, quanto sapiente. Ma loro sono oramai professionisti e ad inciampare non sono più capaci. Magari con un po’ di impegno potrebbero riuscire anche nel fallimento. Ma per ora ce li conserviamo abili e artistici, nonostante la critica negativa. Una snervante attesa precede il miracolo: Manuel Agnelli appare sorridente sotto gli occhi increduli di tutti. Fa casino, gioca con il cavo del microfono, se la gode. Forse la nebbia di poc’anzi mi ha appassito i neuroni. Poi attacca con una “La Verità che Ricordavo” del tutto inaspettata direttamente da uno dei dischi di maggior spessore, quale Non è per Sempre (annata 1999). La scaletta prosegue e l’Agnelli ancora se la gode. Tocca buona parte dei lavori degli Afterhours, navigando attraverso una “Male di Miele” (in diretta dal 1997), una “1.9.9.6” (alla quale il nostro milanesotto provinciale è particolarmente affezionato) e “Non è per Sempre”. Poi un fonico gli dice qualcosa, Manuel scazza e torna ad essere l’asociale di sempre. Smette di essere allegro, intonandosi perfettamente con “Ballata per la mia Piccola Iena” che segue. Al pubblico, tuttavia, questa nuova (solita) versione del frontman piace uguale. Nonostante la formazione fin troppo dinamica negli anni, i ragazzi sembrano sapere il fatto loro ancora una volta, mostrando capacità di collaborazione ed un’organicità interna degna dei più grandi nomi della storia (ci sarà un motivo eh?) e gasano il pubblico con un’antica, quanto funzionale, “Lasciami Leccare l’Adrenalina”. Di traccia in traccia l’evento scorre rapido e mi accorgo che non è un breve intervento, ma un vero e proprio concerto. Ospiti d’onore, non si lasciano sfuggire una “Padania” recente quanto sottilmente satirica ed una “Bye Bye Bombay” con la quale salutano un pubblico infervorito dal pogo e dal delirio. Inutile a dirsi, la critica stavolta ha ragione: “una delle band italiane di maggior spessore degli ultimi 20 anni” (e a parer mio di sempre).
Sono soddisfatto! L’evento è stato grandioso e, “aggratis”, ho visto ancora una volta gli Afterhours su un palco che sembrava allestito apposta per loro. Di tutto l’evento ho trovato due sole pecche, a parer mio, eccessivamente gravi. La prima è un commento di Luca Barbarossa, secondo il quale a Roma festeggiano il Secondo Maggio, perché il Primo Maggio è qui. Bravo, Luca. Buttar fango sull’evento parallelo è molto molto professionale. Complimenti al “genio” della musica italiana. La seconda va sotto il nome di protesta: troppe chiacchiere, troppi video e troppe persone sul palco a raccontarci storie che abbiamo già sentito e in cui non credono più neppur loro stesse. Siamo al Primo Maggio e qui la gente (forse ignorante?) viene per la musica, non per i convegni. Le otto ore lavorative sono passate di moda, inutile appendersi a lampioni fulminati. Oggi i problemi sono ben altri!