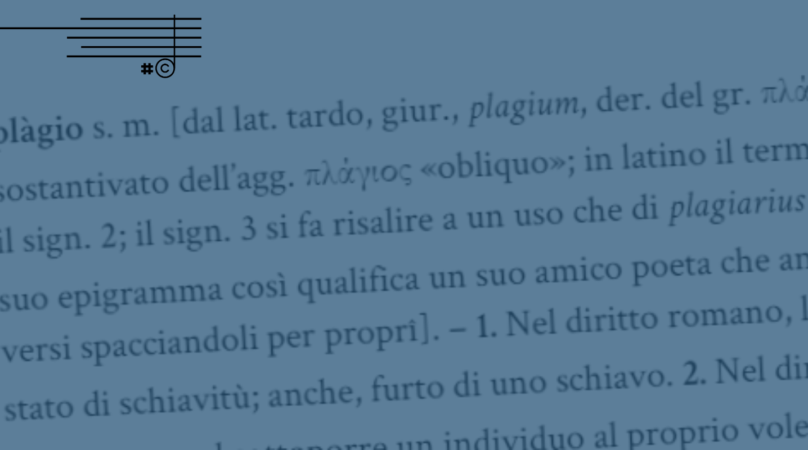Coldplay Tag Archive
Turin Brakes in Italia per 4 date
Quattro date in Italia per la band di culto inglese col nuovo album Invisible Storm, uscito il 26 gennaio scorso per Cooking Vinyl. Il tour è partito dall’Inghilterra e giungerà da noi la prossima settimana. Ad aprire le date italiane, il rock venato di blues e soul di Dog Byron.
L’Introverso – Una Primavera
“Mi rialzo da me, mentre affondano i marciapiedi”. L’Introverso da Milano stanno per dare alle stampe il loro primo album, Una Primavera, lavoro che parla di sconfitte incassate e di immediate resurrezioni con un taglio Brit Pop, Indie Rock. Dall’opener “Tutto il Tempo”, gradevole presa di coscienza di stampo Coldplay (anche se a loro piacciono gli Oasis) si passa a “Manie di Grandezza”, pezzo con volontà catchy dal ritornello orecchiabile che risulta essere il brano centrale del lavoro ma che non riesce a pieno nell’intento del singolo spaccatutto, vittima di un eccessivo controllo e determinismo. D’improvviso però ci troviamo di fronte ad un calo, un freno a mano fisiologico poco motivabile che una band apparentemente “macchina da guerra dal vivo” non può di certo permettersi: “Il Finestrino” parla (anche) di sesso in macchina ma non percepiamo nulla di un momento così intimo; “Uguali” sceglie un arrangiamento irritante di stampo sanremese come anche “Prima o Poi”. Cosa succede, quindi? I quattro di Milano, e questa è una nota di gran merito, hanno ascoltato, studiato e fatto proprie molte formule tipiche del Brit Pop senza però, e questo è il problema, riuscire a plasmare un prodotto nuovo e fresco e rimanendo spesso aggrappati a un certo Pop melodico italiano da (bassa) classifica. Ma non tutto è perduto, un disco va ascoltato fino alla fine per dare un giudizio. Sai che c’è, potrebbe andare meglio e credimi avrei diritto al meglio. Sento di rinascere, da oggi voglio una primavera per me: questo estratto dalla traccia di chiusura “Primavera” racchiude l’essenza di ciò che L’Introverso vuole esprimere. Semplicità, molto contenuto e una poetica diretta e precisa che, insieme a “Estranea” (dentro c’è tanto Marlene Kuntz) va a risollevare le sorti di un lavoro indubbiamente sopra la sufficienza ma a tratti incomprensibilmente tedioso. L’introverso ha idee, know-how e voglia ma per arrivare dritti al cuore dell’ascoltatore (come afferma lo stesso Nico Zagaria, voce della band), magari proprio come un “Pugno allo Stomaco”, bisogna liberarsi dalla gabbia virtuale e cercare di osare sempre di più.
Duran Duran – Paper Gods
Tornano i Duran Duran con il loro quattordicesimo disco in studio, Paper Gods, un disco in cui sono i sintetizzatori a fare da padroni ma in cui non mancano buoni spunti chitarristici (fra gli ospiti c’è anche John Frusciante, ex Red Hot Chili Peppers) e ritmi ballabili. Sì, perché questo è probabilmente l’album più Dance mai pubblicato sinora dal gruppo inglese, che alcuni giorni fa ha avuto anche l’onore di introdurre il nostro Giorgio Moroder premiato con l’Inspiration Award ai GQ Men of the Year Awards 2015. Tuttavia attenzione: Paper Gods non è una copia di nessuno dei suoi predecessori perché è sempre stato così in fondo. I Duran Duran preferiscono rinnovarsi, aprirsi a nuove sonorità e soprattutto sperimentare senza mai eccedere nell’eccentricità. Chissà che quegli Dei di carta non siano proprio loro che sono ormai sulla cresta dell’onda da quasi quarant’anni. Attraversare cinque decadi non deve certo essere stato facile, come non deve esserlo stato non cedere alle mode del momento quali il Grunge, ma i quattro di Birmingham hanno sempre tenuto duro, resistendo persino agli avvicendamenti in formazione. Oggi non hanno più un chitarrista “fisso” ma hanno in Dom Brown un valido collaboratore che li assiste ormai da dieci anni e che firma persino alcuni brani del disco. Già dalla copertina, in cui sono presenti i simboli di alcuni lavori passati, i Duran Duran hanno tenuto a indicare che Paper Gods è quasi una sorta di breviario del gruppo, utile a conquistare nuovi fan, ma che forse ha indispettito alcuni tra quelli più fedeli che dopo cinque anni di assenza dal mercato discografico (se non si considera il live A Diamond in the Mind) pretendevano qualcosa in più. Tuttavia Paper Gods suona come un disco “maturo”, perfetto per il 2015, un po’ meno se fosse stato prodotto negli anni Ottanta. La mano dei produttori (Mark Ronson, Mr. Hudson, Josh Blair e Nile Rodgers) è evidente e le collaborazioni di lusso non mancano; in una bonus track, presente solo nella deluxe edition, “Planet Roaring”, c’è persino Steve Jones dei Sex Pistols a dare un sentito apporto, ma le più “inusuali” sono certamente quelle di Lindsay Lohan che presta la sua voce per un parlato in “Danceophobia” e di Jonas Bjerre dei Mew in “Change the Skyline”. E poi ci sono anche Mr. Hudson, Davide Rossi (in passato già al fianco di Coldplay e Goldfrapp), Kiesza e Janelle Monáe che non fanno altro che dare un valore aggiunto al disco. Tuttavia l’album più che al passato e al presente guarda al futuro, quello dei suoni sintetici, che a volte hanno sì un sapore vintage ma che potrebbero essere di ostacolo al successo del disco. Manca un singolo di forte impatto dal ritmo inconfondibile e “Pressure Off” è forse troppo poco per scalare le classifiche. Tuttavia in Italia la canzone è già usata come sigla per la Serie A Tim e come sottofondo per gli spot Tim (proprio come accadde anni fa con “(Reach Up for the) Sunrise”) ed è facile prevedere che almeno nel nostro paese venderà molto bene (posizione massima raggiunta finora: #2). Altrettanto sta già facendo nel loro paese natio dove è già in cima alle classifiche di Amazon; rimane invece qualche perplessità per il mercato statunitense e per quello giapponese dove un sound più “heavy” avrebbe giovato molto. I Duran Duran però ci hanno abituato negli anni alle sorprese e quindi staremo a vedere cosa succederà. La prova definitiva sarà certamente quella del live, dove sarà difficile riprodurre certe atmosfere, ma anche lì forse le tecnologie moderne daranno una piccola mano. I punti di forza (o di ripartenza per un eventuale futuro) sono certamente da ricercare in “What Are the Chances?” e in “Garage Days”. Intanto provate a godervi questo Paper Gods che in fondo rispetto a quanto si sente in giro è un gradino più su.
Plunk Extend – Prisma
All’apparenza un Ep di cinque pezzi, nella realtà un vero e proprio disco quello d’esordio dei Plunk Extend, artisticamente vario e imprevedibile, mi concentro ed inizio ad ascoltare Prisma. Le canzoni prendono il nome di cinque colori (Blu, Nero, Bianco, Rosso, Verde), cinque colori che rappresentano le diverse personalità della band stessa, Prisma non vuole assolutamente seguire una linea, vuole mostrare ogni volta una facciata differente, non vuole mai dissiparsi nella convenzionalità. “Blu” apre il disco con una chitarra capace di rapire le papille gustative, la ritmica tiene alta la tensione, il testo tiene impegnata l’attenzione. Insomma, parte molto bene Prisma, nella maniera in cui speri possa sempre iniziare un disco. Avete presente quando una giornata parte nel migliore dei modi? “Nero” cambia completamente aria, certo che rimaniamo sempre sul Pop Elettro Acustico, ma il cantato nelle strofe assume tonalità prettamente Hip Hop, le chitarre a tratti trasudano Folk, una cosa tanto nuova quanto inaspettata. I Plunk Extend decidono di non dare mai niente per scontato, questa caratteristica riesce a renderli in un certo senso controcorrente, non amano troppo catalogarsi nella definizione di un genere. “Bianco” è dolcemente cantautorale, della classica scuola italiana dei cantautori, una perla carica di sentimento, le emozioni iniziano ad intrecciarsi indissolubilmente. Potrei urlare tutto l’amore che ho dentro quando un finale tipicamente Coldplay inizia a far cavalcare gli strumenti verso una trionfale conclusione. Poi arriva “Rosso” e non poteva essere altro che potenza, rabbia e passione. I riff in progressione volteggiano in stile Ska, qualche lontano riferimento al Metal Hc (ma solo i profumi più nascosti, sia chiaro). “Verde” è la speranza, la speranza di portare un nuovo modo di comporre musica, i Plunk Extend suonano musica di un’altra galassia, una roba ancora sconosciuta al comune mortale. Dietro Prisma c’è tecnica, sperimentazione e soprattutto tanta voglia di stupire. Io vedo questo album come una mano di poker, cinque carte da spizzare lentamente, una per volta. Dopo i precedenti lavori in lingua inglese i Plunk Extend dimostrano largamente di saperci fare anche con l’italiano, sono una band innovativa a cui andrebbero rivolte tutte le migliori attenzioni del settore. Io un disco del genere potrei ascoltarlo in qualsiasi condizione emotiva, riesco sempre a trovare quello di cui ho bisogno. A voi sembra poco?
Plus Plus – Psycho
Decisamente non artisti di primo pelo questi Plus Plus, che con Psycho giungono al terzo disco dopo Evils del 2010 e Game Over del 2011. Nella loro biografia si legge che hanno origini inglesi ma che attualmente risiedono in Giappone. E certo è che la loro ultima fatica risente di un certo sapore internazionale, declinato lungo tutte le otto tracce interamente strumentali. Il disco, tutto sommato di durata contenuta, si apre con “This is Based Upon a True Story”, raffinata e solare, dettaglio che contrasta subito con la mia aspettativa, del resto assolutamente ingiustificata, di toni sommessi e atmosfere cupe. La sensazione prosegue con “Jail”, un richiamo all’Alternative Rock romanticone stile Coldplay, etereo e impalpabile, nel quale forse solo la reiterazione di una brevissima cellula melodica dà l’impressione di essere imprigionati. “Piano Song”, vuoi per il nome, è vagamente debussyniana. Ma non solo. Impossibile non ricordarsi subito del leggero tocco Pop pianistico di Yann Tiersen, ad esempio. Le sonorità cambiano leggermente, pur restando acustiche, nella successiva “Dieter Rams”, introdotta dalle corde pizzicate, incaricate di marcare il ritmo e definire la condotta armonica, ricreando un tappeto sonoro adatto ad ospitare, nuovamente, il timbro del pianoforte. Atmosfere visionarie, suggestioni più lisergiche che psicotiche, come vorrebbe invece suggerire il titolo, caratterizzano la traccia che dà anche il nome all’album, “Psycho”: espedienti strumentali che sembrano essere impiegati come musica colta descrittiva, finendo con pochi mezzi esaurienti, per costruire una perfetta scena sonora notturna.
E con la traccia numero sei, “Gentle Man”, la più lunga di tutto il disco, con i suoi cinque minuti e più, capiamo di essere davvero di fronte a fortunati e talentuosi eredi di artisti come Mogwai o Explosion in the Sky. “Plantopia”, a dispetto del nome, ha un non so che di marino: le sonorità sono ovattate e dilatate allo stremo, il tempo si congela in un vuoto capace di circondare e avvolgere l’ascoltatore, esattamente come ritrovarsi immersi nell’acqua circondati dal nulla, eppure sfiorati da tutto. Psycho chiude con “The Rolling Hills of England”, che forse è un richiamo alla terra natia, al passato epico e glorioso e dignitoso dell’Inghilterra che il titolo cita, come si percepisce dai movimenti melodici medievaleggianti che puntellano l’intero brano. Nel complesso è un album davvero ben fatto e che vale la pena ascoltare. Consigliatissimo.
U2 – Songs of Innocence
Martedì nove settembre è arrivata in mondovisione una fucilata. Uno apre iTunes e si trova davanti il nuovo disco della band più polare al mondo (sì, non sono The Beatles perché non fanno più dischi dal 1970 e non voglio credere che siano gli One Direction!). Io, tolto lo stupore iniziale, me ne sbatto della markettata soprattutto perchè non ci ho capito mai una mazza delle manovre di marketing. Quindi, che me ne frega se la Apple ha sborsato cento milioni di dollari? E allo stesso modo non mi tocca se ora gli U2 sono in vetta alle classifiche con le vecchie glorie mentre la gente punta il dito contro la mossa eccessivamente mainstream.
Attenzione, però, che qui la critica ci sta tutta, per altri motivi e non sarò certo io ad esimermi. Veniamo al dunque: questo disco è brutto! O meglio, insipido. Il più piatto e prevedibile di sempre della carriera del quartetto irlandese. Per quanto mi riguarda le aspettative nei confronti di un loro nuovo disco sono sempre esagerate e effettivamente parzialmente deluse da Zooropa in avanti eppure, in ogni caso, sono riuscito a trovare uno spiraglio, un ornamento che donasse nuova linfa a un vestito reso così sempre diverso, nuovo e sgargiante, sebbene con gli anni sia più plastico e meno colorato. Qui però l’abito è sbiadito, sgualcito, appiccicato con pezze sberluccicanti ma raffazzonate. L’inizio promette grandi cose ma il pretenzioso e divertente titolo sfoggiato in “The Miracle (of Joey Ramone)” crolla immediatamente all’arrivo degli inutili coretti “ooooh ooooh”, così inspiegabilmente Coldplay. Non bastano le rare pennate del chitarrone di The Edge a distogliermi dalla rilettura incredula di quel nome immenso: Joey Ramone; e dove sta l’antica anima Post Punk degli U2? La produzione di Dangerous Mouse (che per altro è affiancato da altri supernomi come Paul Epworth, Ryan Tedder, Declan Gaffney e Flood, sembrano messi lì quasi per il gusto di riempire la bocca) è sicuramente forte, presente, massiccia, moderna ma non porta in nessuna direzione, se non a una sterile autocelebrazione e ad un timido tributo alla musica Pop che passa dalle citazioni dei Police in “Every Breaking Wave” (una via di mezzo tra “With or Without You” e proprio “Every Breath You Take”) agli echi di “California”, che rimandano diretti a “Barbara Ann” dei Beach Boys.
Poi dopo aver scomodato senza successo l’eroe del Punk americano, viene chiamato in cattedra pure il Punk anglosassone. Ed ecco “This is Where You Can Reach Me Now” dedicata a Joe Strummer; ritmiche in levare da manuale e tastiere che rimandano ai primi anni 80. Finalmente un pezzo degno di nota nonostante i suoni lontani di una produzione che meno Rock’N’ Roll di così non poteva essere. Anche nei timidi tentativi di “Volcano” e “Raised by Wolves” la vena più elettrica fa fatica ad uscire. The Edge ne soffre, le sue parti alcune volte appaiono spinte a forza dentro i brani. Pure la coppia d’oro Clayton-Muller pare distante, persa nelle atmosfere una volta create dai loro tocchi magici e ora affidate ai guru del suono digitale. L’unico che pare essere a suo agio in questo marasma è Bono. Con grande classe salva un paio di pezzi con la sua voce che ancora fa rizzare tutti i peli che ho in corpo. “Songs for Someone” è spudoratamente ruffiana e già trita e ritrita, ma Bono, sornione, la asseconda regalando una prestazione vocale magica. Poi nel finale del disco intreccia le sue inequivocabili corde vocali con quelle mistiche e misteriose di Lykke Li, ospite azzeccatissima in “The Trouble”, danza Trip Hop ben governata da un pungente giro di basso e concluso da uno sbalorditivo (seppur purtroppo brevissimo!) assolo di The Edge. Mi spiace però, a questo giro non mi farò illudere da trucchetti. Questo album rimane privo di idee e, inutile colpevolizzare scelte di suoni o pompaggi digitali, mancano le canzoni. Manca quel senso di rivoluzione che è passato dalle scorie Punk di “Boy” fino alla Disco Music chitarrosa di “Pop”, ma manca anche una stupida canzonetta canticchiabile alla “Beautiful Day” o le prove Rock’N’ Roll di “Vertigo”, e non scomodiamo i capolavori. Spero davvero che tutto questo non si sia perso in mezzo a palchi 3D e occhiali da sole, perché forse sono troppo romantico, ma credo che il mondo della musica abbia ancora bisogno di questi quattro ragazzi. Sicuramente più di quanto la Apple abbia bisogno di farsi pubblicità con l’uscita di un loro disco.
MasCara – LUPI
La prima cosa da dire di questo LUPI by MasCara sono belle parole relativamente all’artwork. Pulito, classy, semplice ed efficacissimo. Sorvoliamo giusto su qualche errore nella composizione interna, dove i testi di alcuni pezzi vengono scambiati di posto, e dove un paio di refusi disturbano la lettura delle liriche. Passiamo poi alle liriche, o meglio, per l’appunto, alla lettura delle stesse. C’è un gusto narrativo palpabile nelle dodici tracce del disco: la storia scorre fluida, e già dai titoli le visioni urbane quasi oniriche (“Macchine da Guerra”, “Cattedrali al Neon”, “Graffiti”, “Barricate”, “Gocce di Benzina”) si mischiano a tonalità più primitive e leggendarie (“Dei per Sempre”, “Isaac” – che echeggia vibrazioni bibliche -, “Falsa Età dell’Oro”, “Riti Ancestrali”), dandoci l’idea di un’epica distopica dalle sfumature varie e dai sapori intensi. All’ascolto i MasCara sorprendono per la fluidità e lo spessore della pasta sonora (aiutati al mix anche da un nome di punta quale Tommaso Colliva): chitarre, synth, bassi e batterie si fondono in soundscape estremamente riusciti ed affascinanti. Si rischia giusto qua e là un effetto già sentito (qualcosa alla Coldplay, qualcosa alla Ministri, per citare giusto le apparenze più facilmente intercettabili), ma è il rischio di andarsi ad infilare in questo tipo di proposta musicale.
La pecca maggiore di LUPI, a parer mio, sta però nella voce, e non tanto nel timbro o nelle capacità vocali di Lucantonio Fusaro, ma nella metrica, sghemba e scalena, claudicante. I testi vengono snocciolati sui brani in modi spesso storti, disequilibrati, qualche (rara) volta con risultati imbarazzanti, più spesso semplicemente facendo apparire i testi disorganici rispetto alle musiche, ai ritmi, alle fasi del pezzo. Questo non toglie certo al disco i suoi meriti, ma ne penalizza l’ascolto – o almeno così è accaduto al sottoscritto. Concludendo, LUPI è un disco maturo, di una band interessante, narrativamente e musicalmente. Per raggiungere le vette mi sento di consigliare una personalizzazione maggiore della proposta sonora e una cura dei testi che riesca a coniugare linea melodica e cuore pulsante delle canzoni senza affossare né l’una né l’altro. Ascolto consigliato in attesa di prove future, si spera più decisive.
Dropeners – In the Middle
Lo ammetto, sono partito con il piede sbagliato. Lo ammetto, mi aspettavo altro. Lo ammetto, sono senza parole. Lo ammetto: i Dropeners hanno letteralmente vinto!
I Dropeners nascono nel lontano 2008 e, dopo aver accumulato un incredibile quantitativo di esperienze (soprattutto estere), tirano fuori il lavoro di cui sto per dire: In the Middle. Il disco d’esordio si fa vivo nel 2009, sotto il titolo di Drops of Memories e fra questo ed il capitolo oggetto di discussione, s’intermezza un EP risalente a ben quattro anni fa: Silent Sound (EP). Si sono fatti parecchio attendere a quanto pare, ma il motivo lo scoviamo in breve ed è nascosto dietro ognuna delle dieci tracce che formano il loro secondo disco. Il sound, complice dell’inglese adottato in ogni parte del lavoro, lascia fraintendere l’interlocutore medio e fa sì che si attribuiscano i meriti dell’opera ad esperte menti anglosassoni. Ma qui siamo innanzi a tutta roba made in Italy: vengono da Ferrara, sono autoprodotti e non hanno nulla da invidiare al meglio delle band internazionali. You won’t get a second chance to make an extraordinary firts impression, diceva qualcuno e i Dropeners dimostrano di saperlo bene, curando l’aspetto di In the Middle in ogni minimo particolare. Il packaging è leggerissimo, minimale ma efficace (ammetto anche questo: ho un debole per il packaging). La copertina lascia intendere un egregio lavoro introspettivo, confermato ottimamente dal contenuto del disco, attraverso una musica penetrante, grazie ad un New Wave ben articolato ed a sonorità molto lente e buie. Lo confermano i Dropeners stessi in “Western Dream”, che fa da titoli di coda al film surreale che i registi ci propongono: in the middle of western dream, there’s a light that comes from the east, recitano per tutta la durata della traccia. Il theremin in questo capitolo gioca un ruolo essenziale, evidentemente. Penetrante. Ossessivo. Possessivo. Ipnotnico.
All’interno di questo straordinario lavoro troviamo spunti di verde invidia per il migliore Dave Gahan, quello che si cimentò nell’incredibile opera di “Saw Something”. È come se i Dropeners avessero preso spunto da questa singola traccia, depurandola dall’eccessiva vena elettronica per poi ampliarla, estenderla e costruirci su un intero album. Ma non è tutto. Lo spazio artistico toccato è incredibilmente vasto: si sfiorano le corde dei Coldplay in “Lead Your Light”, appesantendole con i migliori Radiohead di OK Computer. Nel secondo capitolo (“You Don’t Know”) è possibile persino scovare un nonsoché di Gothic, di scuro, che lascia sovvenire alla mente vecchi ricordi di HIM e The Rasmus, light version. Ma i Dropeners non amano paragoni e non vogliono di certo essere la copia di mille riassunti e, nonostante riportino in vita questa scia di fine anni Ottanta, sanno bene come rinnovarla. Sfruttando, infatti, la propria conoscenza musicale e strumentale, si trasformano in polistrumentisti, riscoprendo in un’ottica del tutto nuova il sound sopra citato. Così, la voce e chitarra Vasilis Tsavdardis si cimenta in eccezionali imprese al synth e la chitarra di Francesco Mari sperimenta trombe e theremin (che gioca il ruolo di psicanalista nell’analisi introspettiva condotta dal disco), accompagnando perfettamente il basso di Enrico Scavo e le batterie di Francesco Corso. L’armonia è inevitabile, essendo che lo strumentale poggia direttamente sulla melodica voce di Tsavdardis, lunga, bassa e sempre in perfetto tono, accompagnandola lungo la stesura di ogni capitolo. Insomma dieci tracce di puro intelletto ed organicità, con tanto di ghost track, come non se ne vedevano da un bel po’. Potremmo andare avanti per ore, il disco fa parlare di sé come fosse parte di noi stessi. Penetra letteralmente nel più profondo dell’inconscio e ci lubrifica l’animo. È un lavoro che vale l’attesa, tutta. Signori, siamo innanzi ad un ottimo allievo. Stimolarlo a far di meglio potrebbe essere controproducente. Conosce i suoi obiettivi, sa chi è e sa dove vuole arrivare: nell’io di ognuno di noi. Nel mio ci ha messo le radici e nel vostro?