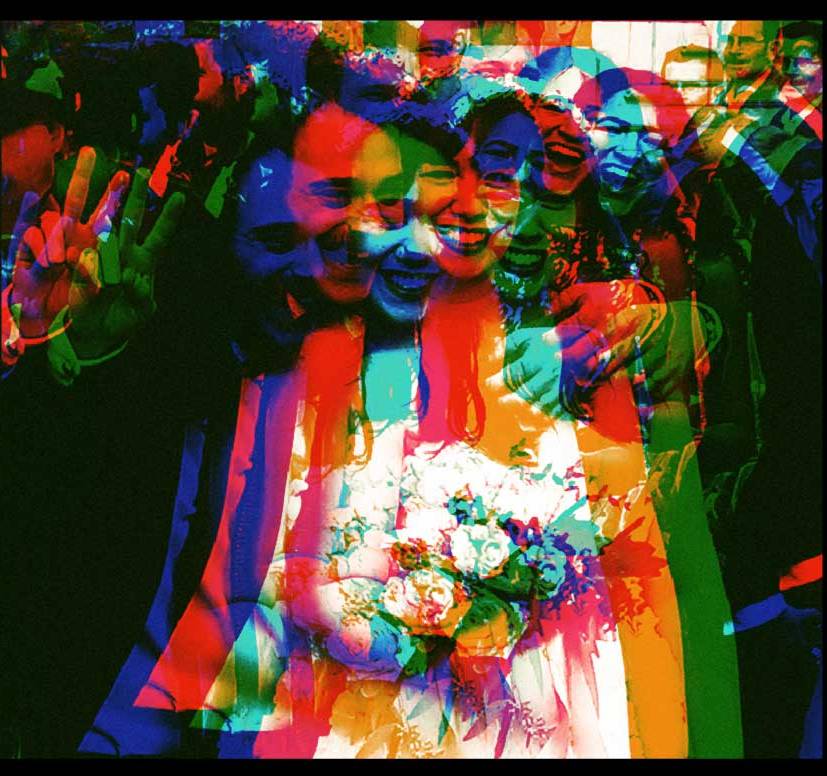È difficile scrivere una recensione di questo disco. Forse perché non stiamo parlando davvero di UN disco, ma di dischi, al plurale. E poi stiamo parlando di Vasco Brondi, che, volenti o nolenti, è stato considerato una voce di punta della fantomatica leva cantautorale degli anni zero. Da questo disco (il terzo) ci si aspetta qualcosa, fosse anche il proseguimento della continuità che c’era tra i primi due, ma più realisticamente si spera in un’evoluzione, un passo avanti nel percorso artistico de Le Luci della Centrale Elettrica. E quindi? Andiamo con ordine. Prima di tutto va detto che il disco è un disco denso. Non è un disco facile da esplorare. Alcuni episodi sono magari più accessibili del solito, ma si ha bisogno di tempo per entrare in tutti i dettagli, e anche scrivendo questa recensione continuo a scoprire cose e a rendermi conto di particolari prima inosservati. Questo fatto è strettamente collegato a ciò che accennavo più sopra: I dischi, non IL disco. Costellazioni (così ammette lo stesso Vasco) ha avuto una genesi travagliata, prima scritto e arrangiato “al computer” con Federico Dragogna dei Ministri, poi registrato in studio con una pletora di (peraltro ottimi) musicisti, ottenendo in pratica due dischi distinti, che in seguito sono stati “fusi” per creare questo prodotto ibrido, che Vasco sente suonare come “canzoni dalla pianura padana lanciate verso la galassia, storie piccole ma che si vedono anche dalla luna”. È un disco in cui convivono tante anime diverse, dove Vasco si è divertito a inseguire i tanti suoi gusti e punti di riferimento (CCCP e Battiato su tutti), dove ha sperimentato cose mai tentate prima (testi narrativi, più focalizzati; il cantato, che prima era esclusivamente parlato o urlato, diventa in alcuni casi più melodico; la chitarra viene spesso relegata in secondo piano, e sostituita con pianoforti, beat elettronici, oceani di synth, archi, fiati). Abbiamo quindi “I Sonic Youth”, una dolce ballata per pianoforte, elettronica e voce, ma anche “Firmamento”, elettrica e aggressiva, dove Vasco riprende “lateralmente” i generi che suonava nella sua adolescenza; c’è “Le Ragazze Stanno Bene”, scritta con Giorgio Canali, più classica, con voce e chitarra acustica a giostrare il marasma, ma anche “Ti Vendi Bene”, che è in pratica un pezzo sfigato dei CCCP (ma non per colpa di Vasco, sono i CCCP che sono inarrivabili).
Insomma, Costellazioni è un pastiche, è caos, è confusionario e sfilacciato, però è anche un disco coraggioso, perché darà nuovo materiale critico ai detrattori, scontentando al contempo quella fetta di seguaci affezionata allo stile sempre identico che Le Luci della Centrale Elettrica aveva reso quasi materiale di barzellette o di generatori automatici di canzoni di Vasco Brondi. In questo io ci vedo coraggio, perché Vasco ha saputo inseguire alcune ispirazioni che lo tentavano, lasciando i lidi comodi e sicuri della sua solita solfa, sperimentando, incastrandosi, cucendo, scucendo e ricucendo i brani. In alcuni casi questo coraggio ha pagato (il primo singolo, “I Destini Generali”, è luminoso e leggero, cosa che non gli era mai riuscita bene in passato, e rappresenta bene il filone di speranza, di “musica sotto le bombe” che attraverso il disco come una lama di luce nel buio; in “Un Bar Sulla Via Lattea” e in “La Terra, l’Emilia, la Luna” è riuscito a rendere bene l’idea di musica rurale e spaziale” tra la provincia, a cui tiene tantissimo, lui emiliano di Ferrara, e le stelle), in altri casi rischia molto di più di spiazzare l’ascoltatore (“Padre Nostro dei Satelliti”, “40 Km”, “Macbeth Nella Nebbia”, per alcuni versi “Uno Scontro Tranquillo”) e di sembrare perso, smarrito nel disorientamento causato da un overload di informazioni, idee, spunti. Il disco, insomma, è un mezzo fallimento, ma al contempo una mezza vittoria: porta Le Luci della Centrale Elettrica fuori dal pantano, verso le stelle. È vero, lo fa spesso con ingenuità e con poca chiarezza del percorso da fare, ma mi sento di dire che ascoltando Vasco parlare durante la presentazione del disco ho percepito che questo, lui, lo sa. Sa che il disco è il risultato di tentativi, di prove, di colpi di reni disperati e molto, molto necessari. E sa (e lo ammette) che il futuro sarà scegliere, tra le numerose vie che questo album-crocicchio ha aperto, quella che saprà convincerlo di più, e prenderla e percorrerla fino in fondo.
Per finire, due considerazioni: la prima è che non scherzavo quando dicevo che il disco è un mezzo fallimento, ma anche una mezza vittoria. Sono I dischi, ricordate? Quindi il mio consiglio per l’ascolto è di approcciare Costellazioni col cuore aperto, e di saper riconoscere quali canzoni riescono a parlarvi, e quali no. C’è per forza qualcosa per voi, lì dentro. Io, per esempio, sono stranamente stregato da “Blues del Delta del Po”, da “Uno Scontro Tranquillo”, da “Le Ragazze Stanno Bene”… insomma, io mi sono creato una sorta di Costellazioni privato, che mi parla in prima persona, lasciando fuori ciò che non mi arriva. In questo senso, l’avere perso focus in favore della varietà e della sperimentazione anche “strana” è stata una mossa vincente. Pezzi così, nel bene e nel male, difficilmente li incontrerete altrove. La seconda considerazione è su Vasco Brondi. In questo disco è chiaro come non mai che definirlo cantautore, se non un errore, è quantomeno un understatement. Vasco fa Punk, fa Rock, ha nelle orecchie gli anni 80, l’elettronica, i sintetizzatori, le distorsioni. Le Luci della Centrale Elettrica può diventare, ancora di più, un progetto trasversale, aperto, capace di tutto. Questo disco è un azzardo, è, se vogliamo, uno sbaglio, ma è dagli sbagli che nascono le emozioni vere. E quindi ascolto questo delirio di disco immaginandomelo con la metà delle canzoni e con una concentrazione più affinata, e so (e spero) di stare ascoltando il prossimo disco, Le Luci della Centrale Elettrica di domani, ed è un bel sperare.