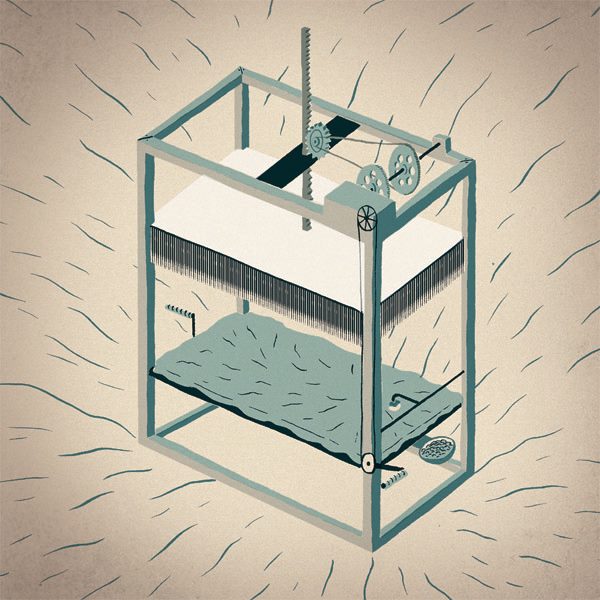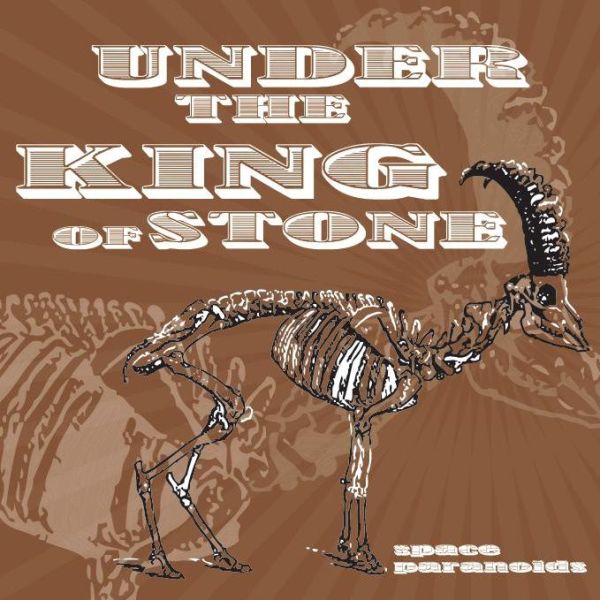Nati nel cuneese nel 2006, l’attuale compagine degli Space Paranoids prende forma solo lo scorso anno, dall’incontro tra Simone Rossi (voce e percussioni), Cristiano Rossi (basso), Luca Bruno (batteria) e Andrea giostra (chitarra e voce). Da quel momento in poi, lo spirito dei quattro li porterà verso la ricerca di un possibile futuro per certe sonorità in fondo forse anche troppo datate per le orecchie di noi divoratori di dischi. Partendo dall’universo Stoner che fu terra di grandi quali Kyuss, Queens of the Stone Age e Clutch e dal mondo psichedelico e spaziale di Monster Magnet, Colour Haze ed Earthless il loro obiettivo sembra essere quello di trovare la strada per unire il passato con i luoghi del loro presente fatto di scabri territori di montagna, pinnacoli imbiancati, macchie inviolabili, specchi d’acqua tersi e culture morenti, con l’unico scopo di cercare la catarsi attraverso la decantazione spirituale. Una sorta di viaggio allucinogeno nei deserti della California trasportato nei territori del nord dell’Italia. Il tutto registrato in presa diretta per dare maggiore convinzione alla durezza del suono.
I sette brani che compongono Under The King Of Stone sono un tripudio alle contaminazioni, ai rimandi, alle citazioni (spudorata quella in “Called Goblins Haze”. Avete indovinato?) eppure il loro non è per niente un lavoro spiacevole. Trasuda la consapevolezza di un background culturale musicale di un certo spessore e l’esecuzione dei quattro è impeccabile (senza dimenticare la partecipazione di Tommaso Fia e la sua Hammond nei brani “Under The King Of Stone” e “Blind Cyrus”) oltre che energica e potente, come si conviene per il genere, pur senza l’apporto della seconda chitarra (se non in casi rari). I quattro riescono a produrre esplosioni sonore imponenti che non sfociano mai in distorsioni eccessive e l’ampio spazio lasciato alla strumentazione di contorno, basso e batteria su tutti, non fa altro che intensificarne la furia. Veramente interessante il lavoro alle quattro corde di Cristiano che riesce a reggere le ritmiche anche nei momenti di pausa necessari alla fluidità della narrazione sonora.
Non si può non applaudire inoltre la voce di Simone Rossi che per quanto manipolata, detto tra virgolette, riesce pienamente a rendere l’idea di quello che è l’obiettivo della musica degli Space Paranoids e soprattutto riesce a evocare paesaggi torridi e gelidi nello stesso tempo e a saltare dalle diverse variazioni sul tema con estrema convinzione senza mai diventare prevaricatrice nei confronti del resto.
Tra i sette passaggi del viaggio, parecchio avvincente è “Black Salamander”, in cui la chitarra di Andrea Giostra si presenta acidissima e pesante nello stesso tempo, quasi sfiorando giri funky.
Il mio brano preferito (di questi primi ascolti) è invece “Blind Cyrus”, il meno Hard e più Blues del disco, soprattutto per il suo ritmo soffocante e ossessivo in contrapposizione con la voce carnale, calda, spirituale e profonda di Simone. Interessanti anche i passaggi di chitarra e Hammond, che danno al brano un senso di esplorazione psichica molto sixties.
Chiarito che non ritengo un problema, la scarsa originalità quando il lavoro è ben fatto, ci sono alcuni punti però che non convincono. Per prima cosa, credo che sarebbe stato opportuno dare un’impronta ancora più acida e lisergica al sound dell’album. I passaggi psichedelici di vecchio stampo sono molto pochi e non riescono a dare quel necessario senso di completezza. Molto più marcata, è la natura Hard Rock che, in combutta con le ritmiche e il cantato Stoner, finisce per tagliare fuori quegli aspetti psico-space, oltretutto richiamati evidentemente già dal nome stesso della formazione, che avrebbero certamente dato maggiore corpo a Under The King Of Stone. Penso ad esempio alla title track, che per quanto eseguita con una certa intensità, finisce per durare fin troppo (oltre sei minuti annoiano senza opportuni cambi di ritmo) in relazione all’idea di base del pezzo.
Molto più interessante invece, sotto quest’aspetto, “Electric Rotor Crossroad”, che col suo intro strumentale e il muro di chitarre che segue, finisce per ricordare anche un tipo di Post Rock stile Mogwai, anche se presto reindirizzato verso i lidi bollenti dello Stoner.
Un altro problema che ho trovato troppo seccante e vitale per essere ignorato è quello della registrazione. Preciso che registrazione e mixaggio sono opera di Massimiliano “Mano” Moccia al Blue Records di Mondovì e la masterizzazione di Niklas “Mr. Dango” Kallgren al Bombshelter Studio di Orebro. La cosa è evidenziata soprattutto dal brano “Deadmouth Monk” che oltretutto presenta un ritmo di chitarra tanto semplice quanto straordinario. Rispetto ai primi brani, il suono sembra farsi ancora più fumoso e i toni della registrazione sembrano perdere colore, tanto che, se ascoltati attentamente, alcuni pezzi non sembrano poter far parte dello stesso album. L’effetto non è, evidentemente, voluto.
Ultimo necessario riferimento al brano che chiude l’album, “Ordesa Sky Hunters”, il momento più soffice, intimo, rilassante, narcotico, anche se l’impeto torna prepotente già dalla fine del secondo minuto.
Under The King Of Stones è l’album perfetto per chi ha amato quei gruppi cui ho fatto riferimento nella prima parte, perfetto per chi non guarda di buon occhio chi esagera ed esaspera le innovazioni, per chi ama la musica ben fatta, possente, impetuosa e vigorosa, per chi ama il South statunitense, i suoi deserti e la sua magia.
Gli Space Paranoids, decidono di puntare sulle loro origini per arrivare a voi. Origini territoriali, montagne, freddo e alberi e origini musicali, soprattutto anni novanta. E poi, pura e semplice espressione artistica. Sono questi gli ingredienti di Under The King Of Stones. Origini ed espressione artistica. Solo da qui è possibile raggiungere se stessi.