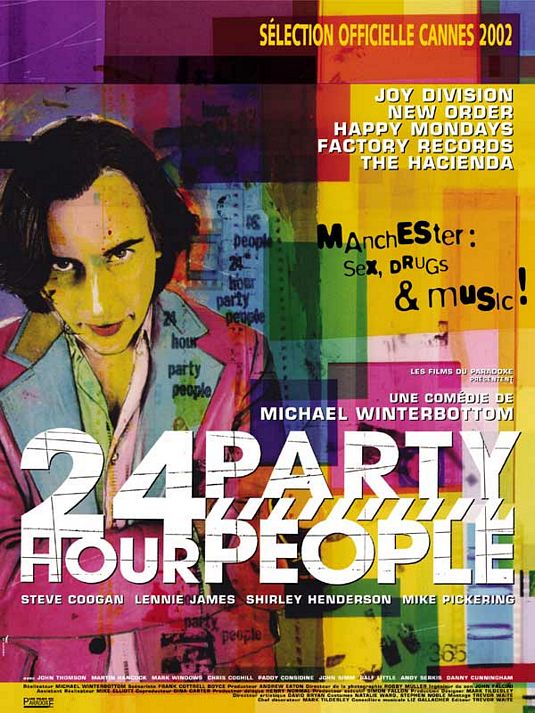Scegliere un gufo come immagine simbolo per l’omonima opera di Kaouenn è opzione che, se da un lato permette di utilizzare tutta una serie di simbologie per spiegare la propria musica, dall’altro rischia di trasformarsi in una banalizzazione della stessa, visto l’eccessivo e talvolta superficiale uso che si fa di questa effigie. Il gufo, in un passato remoto associato al male, la morte, la sventura e l’oscurità è anche il simbolo della saggezza, a seconda di quali tradizioni si vadano a scandagliare e dunque, in una visione d’insieme, ha la forza di evocare una duplicità di allegorie, positive e negative, di rappresentare la complementarità dei contrari, che, nel caso specifico di questo disco, vogliono essere realismo e misticismo, auto distruzione e speranza. Come riesce Kaouenn a rendere, con la sua musica, tutto questo? A dirla tutta, semplicemente non ci riesce, perché il timore che questa simbologia fosse il pretesto per dare profondità a qualcosa che non riesce ad acquistarne con mezzi propri diventa una concreta realtà una volta passati all’ascolto. L’Electronic di Kaouenn è massimalista e protesa ad un Synth Pop senza troppe pretese, con sparute apparizioni di rimbombi Blues, tanta New Wave, Future Pop ed Electro Industrial come certi Covenant (“Black Owl”) e pochissime incursioni nelle asperità sperimentali del Trip Hop o nelle teutoniche atmosfere seventies. C’è qualche buona idea, soprattutto quando la voce cupa è accompagnata da ritmiche poderose e suoni grevi ma è la stessa voce uno dei primi problemi di quest’opera. Non convince e con lei non convincono le scelte di suoni e melodie, che per un genere di Elettronica che vuole mettersi addosso l’abito elegante della Pop star, la cosa diventa un problema enorme. Gli echi acuti ed elettrici dei Kratfwerk, le armonie vocali in stile Depeche Mode, l’offuscamento wave dei New Order, la severità Pop dei Pet Shop Boys, le stranezze rumoristiche e tribali stile The Knife (“Dog vs Fox”), diventano non tanto un dichiarato punto di partenza, una moltitudini di radici dalle quali innalzarsi per creare altro ma piuttosto uno scomodo metro di paragone che pesa come un macigno sulle spalle di un bambino. Non è certo tutto da buttare, diversi sono i passaggi in cui Kaouenn mostra di avere la possibilità di andare oltre quello che ha messo oggi sul piatto e la speranza è che sia capace di superare questa fase fin troppo confusa, magari lasciandosi alle spalle onanismi simbolistici e puntando dritto su una più coraggiosa e concreta scelta di suoni e melodie.
New Order Tag Archive
Francesco Gabbani – Eternamente Ora
Lo ammetto: ho ascoltato in primis il cd Eternamente Ora di Francesco Gabbani con un po’ di pregiudizio in quanto prodotto uscito dal Festival di Sanremo, manifestazione a cui ammetto di non aver dato mai troppo peso. Personalmente non ho mai seguito più di tanto gli artisti che vi partecipano ma ho voluto provare ad ascoltare il giovane cantautore di Carrara spinto anche dalle polemiche susseguite alla sua sfida con Miele e al suo consecutivo ripescaggio che lo ha portato in seguito anche a trionfare nella categoria “Nuove Proposte” e ad ottenere il premio della critica “Mia Martini” e il premio “Sergio Bardotti” come miglior testo del Festival. Tuttavia dopo aver riascoltato il disco diverse volte devo ammettere che il ragazzo ha delle qualità che speriamo possa mettere in risalto anche in futuro. Variegato negli stili, Francesco Gabbani fa uso esagerato dell’elettronica in bilico continuo fra gli anni Ottanta e la Dance anni duemila. Mi verrebbe quasi facile accostarlo ai prodotti più recenti dei New Order, ma tra il gruppo inglese e il giovane toscano ci sono ancora molte distanze da colmare. Ci sono infatti pezzi quali la title track che forse è più vicina al songwriting di Max Pezzali e dei suoi 883 e ciò non può giovare all’economia del disco. Nulla contro Pezzali, sia chiaro, ma forse sarebbe stato più logico rispettare un filo logico piuttosto che attingere da fonti differenti e cercare di personalizzare il tutto. Canzoni come “Amen” e “Software” sono certamente molto radiofoniche e conquistano facilmente il podio di migliori fra le otto presenti in scaletta scatenando un meritato ex aequo. Da segnalare una produzione pressoché perfetta ad opera di Patrizio “Pat” Simonini che mixa e masterizza il tutto al Kaneepa Studio di Milano. Lo stesso dà il suo grande supporto contribuendo anche in fase di composizione musicale su tre quarti dei brani presenti e in qualità di coautore del testo de “La Strada” insieme allo stesso Gabbani e a Fabio Ilacqua, che invece firma e cofirma tutte le liriche tranne in “Il Vento s’Alzerà”.
Gradevoli anche l’artwork generale a cura del graphic designer Sirio Fusani e le foto di Daniele Barraco che immergono Francesco Gabbani in un contesto naturalistico. Eternamente Ora mi ha insegnato che non sempre (forse) si può fare di tutta l’erba un fascio. Intanto lo inserisco nel mio lettore cd per l’ennesima volta, cercando di cogliere anche quelle piccole sfumature che mi sono sfuggite nel precedente ascolto.
We Are Waves – Promixes
Provano a mostrare l’altra faccia della luna, i torinesi; tentano di palesare il proprio alter ego e tirano fuori un Ep che vuole evidenziare l’aspetto sintetico ed elettronico della loro miscela di Wave e Post Punk che ci ha entusiasmato in passato tanto da farci gridare al miracolo per aver scovato finalmente una band italiana valida, capace di rileggere il passato in maniera attuale e convincente e pronta per sfondare il muro dell’anonimato. Promixes è l’altra faccia del loro secondo album Promises, quello che più dell’esordio è stato capace di elevare i We Are Waves sugli altri. La copertina stessa non è altro che il negativo di quella che rappresentava l’album precedente, il titolo, una storpiatura che si lega al termine remix e i brani non sono altro che riletture del passato o meglio un diverso modo di esporre i propri brani giacché le tracce non sono semplicemente dei remix ma piuttosto le versioni risuonate di quei brani così come gli stessi We Are Waves le hanno portate in giro per l’Italia, nelle performance in formazione ridotta, con set electro composto di voce/chitarra basso ed elettronica/synth/drum machine. Spariscono, dunque, le influenze più evidenti nel sound We Are Waves ma ne compaiono di nuove, dai Depeche Mode a Trentemoller, da Gas a Plastikman, da The Faint ai New Order, passando per un’attitudine Pop, questa sempre presente, che richiama alla mente un certo Morrisey e non solo per la cover di “How Soon Is Now?” che chiude l’Ep stesso. Tuttavia, nonostante Promixes sia presentato come una necessità espressiva per la band, non resta molto ad ascolto concluso se non l’impressione che questo sia piuttosto un regalo buono per i più affezionati e non certo un nuovo biglietto da visita. I brani già noti perdono completamente quel fascino e quelle sonorità che ci avevano fatto innamorare senza acquistare davvero nuova linfa vitale, anzi, andandosi a ficcare in vicolo cieco di banalità Synth Pop che francamente avremmo volentieri preferito evitare. I We Are Waves sono una grande band, continuo a ripeterlo, in studio e live soprattutto. Ascoltate Promises, l’album uscito a maggio del 2015, e vi renderete conto da soli di trovarvi davanti a qualcuno che di strada ne farà tantissima. Se invece non avete mai sentito quel disco, non lasciatevi trarre in inganno da questo Promixes, i We Are Waves sono molto di più.
Ascolta la cover di “Ceremony” suonata dai Morning Tea
“Ceremony” è un pezzo scritto dai Joy Division prima che Ian Curtis morisse. E’ stato successivamente pubblicato dai New Order nel 1981 come singolo di debutto. In questa inedita versione suonata dai Mornig Tea (Sherpa Records).
Cold Cave a Roma il 17 ottobre
I Cold Cave sono un progetto di Wes Eisold, già cantante di Some Girls e Give Up the Ghost. Volendosi allontanare dalle sonorità Hardcore, incomincia a suonare vecchi sintetizzatori e pedali degli effetti, creando così materiale per il suo primo lavoro, la raccolta di demo Coma Potion, pubblicata nel 2008 in sole 100 copie dall’etichetta Heartworm Press. Dopo un paio di Ep, nel 2009 esce il primo disco, Love Come Close. Nel 2011 c’è stata la loro ultima pubblicazione, Cherish the Light Years, che riprende sonorità del passato come quelle di gruppi come Depeche Mode e New Order.
VENERDI’ 17 OTTOBRE Circolo degli Artisti Roma
COLD CAVE
porte/botteghino 21:00
concerti 21:30
ingresso 10 euro + d.p. / 12 euro al botteghino
Musica e Cinema: Control
Control (UK, USA, Australia, Giappone)
Anno 2007
Durata 122 min
Regia Anton Corbijn
La vita del frontalist dei Joy Division Ian Curtis (Sam Riley), tratta dal libro biografico “Touching from a Distance”, in italia pubblicato da Giunti editore con il titolo “Cosi vicino, cosi lontano” (permettetemi un off-topic, tradurre “toccandosi da lontano” con un titolo che richiama in modo palese un film di Wenders, è semplicemente senza senso) di Deborah Woodruff Curtis, moglie di Ian (Samantha Morton), è descritta, almeno all’inizio, come quella di un adolescente normale. Va, abbastanza svogliatamente a scuola, ha un migliore amico, a cui frega la ragazza che poi diventerà sua moglie, è fruitore dei concerti delle allora emergenti band britanniche Alternative, la sua camera è piena di dischi e di poster dei suoi idoli ed è tifoso del Manchester City. Si sposa, ha una bambina e un lavoro, in un grigio ufficio di collocamento, canta nel suo gruppo per locali e pub di Manchester e dintorni, via via più importanti, fino alle soglie di una tournèe negli Usa che potrebbe consacrarlo.
Come ogni opera biografica che si rispetti, il film rappresenta uno spaccato di quei anni (fine anni Settanta inizio anni Ottanta britannici). Ma a differenza di altre opere del cinema inglese anche recente, non ci sono riferimenti politici e/o sociali in quella che resta uno dei periodi più tumultuosi della storia inglese, ossia l’ascesa della Thatcher e del neoliberismo che tanti squassi provocarono, soprattutto nel nord-ovest dell’Inghilterra da dove Curtis veniva. Invece gli accenni a quell’epoca riguardano solo l’ambiente musicale underground del tempo. E non potrebbe essere altrimenti dato che la sua vita e il suo mondo, la sua arte e la sua estrema sensibilità sono al centro di tutta la pellicola. Il rapporto con la moglie e l’amante Annick (Alexandra Maria Lara) rappresenta in modo molto chiaro e paradossale l’affresco di questo poeta maledetto moderno; cioè il non sapersi staccare da nulla che lui ama, quasi in maniera spasmodica, dai suoi affetti. Ai più, un tale comportamento sembrerebbe egoistico ma qui viene descritto come un estremo gesto di ipersensibilità che lo porterà alla fine all’autodistruzione.
Cosi come per l’ambiente che lo circonda, anche gli altri personaggi risultano schiacciati dalla sua figura: il suo gruppo quasi scompare, Tony Wilson è trattato come una comparsa, i genitori sono dipinti in modo anonimo e asettico. L’unico che emerge un pochino è il manager dei Joy Division, ma forse più per la bravura dell’attore che lo intrpreta (Toby Kebbel) che per altro. Il rapporto con la malattia, incontrata casualmente e che sarà fonte del brano “She Lost Control” e l’abuso di psicofarmaci per curarsi, anche in questo caso, quasi non traspaiono nel film, quasi come scelta di far emergere ancor di più le sue debolezze e i suoi tormenti. La sua musica, poi, è l’elemento centrale del film. Non a caso la regia è curata da Anton Corbijn, qui al suo primo lungometraggio, che proviene dai video musicali (“Atmosphere” dei Joy Division, “Heart-shaped Box” dei Nirvana e “Straight to You” di Nick Cave and Bad Seeds, sono solo alcuni dei video che ha diretto), dal già citato sonoro (i brani sono realmente suonati e cantati dagli attori, escluse le sole “Love Will Tear us Apart” e “Atmosphere”, mentre sono presenti, nella colonna sonora, brani di The Killers, Bowie, Sex Pistols e New Order, spesso risalenti, quando possibile, all’epoca dei fatti), alla scelta del bianco e nero, fino alla lentezza della regia, non fa altro che amplificare il senso di cupezza del personaggio Ian Curtis.
Il regista sceglie di far passare l’ultima notte di Ian , ascoltando l’album The Idiot di Iggy Pop e soprattutto vedendo il film “La Ballata di Stroszek” di Hezog che ci sentiamo vivamente di consigliare. Control è quindi come un bel film, che sicuramente piace e piacerà ai fan dei Joy Division o degli ambienti musicali alternativi, ma sarà difficilmente apprezzato da chi certi ambienti non li conosce non li frequenta o non li ha mai frequentati.
Il film completo in lingua originale
“Una Vita Diversa” è il nuovo singolo dei VELVET
A distanza di pochi mesi i VELVET tornano con un nuovo singolo e un nuovo disco. Il primo brano estratto è “Una Vita Diversa”: chitarre spigolose, grandi Basslines e suoni che rimandano alla migliore tradizione Electro Wave dei New Order e dei Placebo, band che hanno segnato una parte importante nella formazione musicale dei Velvet. L’apporto melodico di Federico Dragogna dei Ministri si fonde alla perfezione con la naturale predilezione della band romana verso emozionanti aperture melodiche regalando al pubblico una nuova grande canzone.
Oltre al contributo di Federico Dragogna, nell’album STORIE, che sarà in vendita nei negozi di dischi e nei principali digital store dal 4 marzo, saranno presenti collaborazioni con Alberto Bianco e Fabrizio Bosso.
Un vecchio famoso video.
No Love Lost
Come ci piace fare spesso, Rockambula è stato media partner dell’evento organizzato questo dicembre a Sulmona (AQ) denominato Soundwave Christmas Nights, festival dedicato alla musica originale indipendente. Pur non trattandosi espressamente di un contest, Rockambula ha voluto comunque istituire un piccolo premio che consiste in un mini pacchetto promozionale comprensivo di recensione e/o intervista più banner pubblicitario sul nostro sito per circa un mese. La band che abbiamo scelto in quanto protagonista con il progetto più interessante e originale anche solo in ottica potenziale è stata quella denominata No Love Lost. In questa intervista cerchiamo di capire meglio di che progetto si tratta, quale possa esserne il futuro e cercheremo anche di ragionare su alcune tematiche care sopprattutto alle scene di provincia.
Iniziamo da una domanda ovvia. Il vostro nome richiama alla mente la grande band capitanata da Ian Curtis e voi avete iniziato la vostra avventura proprio come cover band dei Joy Division. Aver fatto cover è più utile a scrivere e proporre pezzi propri o più un ostacolo dovuto al rischio “imitazione”?
Aver iniziato come cover band dei Joy Division ha sicuramente contribuito a creare amalgama e affiatamento nel gruppo. Il rischio imitazione volontaria non c’è mai stato perché in fase compositiva seguiamo le nostre idee e l’istinto del momento senza doverci preoccupare di imitare qualcuno o assomigliargli. Se ci sono delle affinità con altre band non sono volute e cercate ma sono solo frutto dei nostri ascolti e gusti giovanili. Quando abbiamo deciso di cominciare a proporre un nostro repertorio abbiamo iniziato come nuovi No Love Lost e non come costola della cover band che eravamo prima.
Perché avete scelto di iniziare con le cover e perché avete scelto di passare a proporre pezzi vostri? Suonate ancora brani dei Joy Division dal vivo?
Il gruppo inizialmente è nato come una sfida a proporre una band poco conosciuta ai più e comunque poco coverizzata. L’idea era di fare alcune esibizioni in pubblico e divertirci a suonare una musica che aveva sempre esercitato un certo fascino su di noi. Abbiamo deciso di cominciare a proporre brani nostri perché da sempre noi tutti abbiamo avuto un approccio compositivo alla musica, ci viene naturale. Ognuno di noi tre normalmente compone in proprio e a maggior ragione trovandoci tutte e tre insieme, idee vecchie e nuove si sono accumulate con una certa rapidità dandoci la possibilità di scegliere tra un materiale numericamente consistente ancora in fase di definizione e composizione. In eventuali serate dal vivo in cui avremo la possibilità di suonare per più di un’ora sicuramente riproporremo dei brani dei Joy Division.
La vostra formazione attuale non prevede batteria, o meglio batterista. Il suo ruolo è affidato all’elettronica. Quanto la batteria elettronica può essere un vantaggio (Albini ci ha costruito una carriera, passatemi il termine, con una certa Roland) e quanto un limite per la vostra proposta? E perché avete fatto questa scelta?
La batteria elettronica (ma le basi in generale) per noi e per il nostro sound è un vantaggio in quanto la nostra musica necessita di ritmi definiti e ben schematizzati; ci da la possibilità di far lavorare il basso in modalità non usuali (uso di ottave alte quando lavora in contemporanea con un basso synth) mantenendo una certa corposità del suono e avendo virtualmente una sorta di seconda chitarra. Inoltre la batteria elettronica permette al basso di esprimersi liberamente con riff definiti e di effetto e permette al cantante/tastierista di dedicarsi totalmente al canto. Attualmente non vediamo svantaggi nell’utilizzarla e non escludiamo neanche il ritorno di una batteria acustica in futuro quando e se necessario.
Vi ho ascoltato dal vivo durante l’esibizione a Sulmona (AQ) al Soundwave, un piccolo Festival di cui Rockambula è stato media partner (ndr I No Love Lost hanno vinto qui il premio Rockambula). Perché avete scelto di parteciparvi? È questa la strada migliore per la musica emergente? Cosa non vi è piaciuto?
Abbiamo scelto di partecipare al Soundwave Christmas Night per avere una vetrina e far sentire i nostri brani inediti a un vasto pubblico. Per i gruppi della scena Indie la via migliore per farsi conoscere è comunque soprattutto quella di partecipare a manifestazioni ad hoc come questa e ovviamente utilizzare la rete nei suoi numerosi canali e avere tanta voglia di mettersi in gioco credendo a quello che si fa. Più di quello che non ci è piaciuto, preferiremmo invece mettere in rilievo il fatto che questa manifestazione non era un concorso ma appunto una rassegna. È stata un’ottima idea in quanto nei concorsi è molto facile che a vincere sia la band raccomandata o che porta più pubblico; diverso è stato invece creare un premio per il progetto e l’idea espressa da una band come ha previsto il Soundwave con Rockambula.
Una cosa che, ad esempio, mi pare di aver notato è che, specie nelle piccole realtà cittadine, mancano vere e proprie scene e ognuno tenda a fare musica inseguendo, spesso scimmiottando, i propri idoli, senza alcuna voglia di sperimentare, osare, innovare. Uscire da questo tunnel credete sia possibile? Come?
Uscire dal tunnel delle imitazioni è possibile ma richiede apertura mentale, un discreto background culturale, creatività e voglia di mettersi in gioco. Il problema principale è che si tende, soprattutto nelle nostre realtà, a giudicare l’operato di un musicista solo ed esclusivamente dal punto di vista tecnico senza mettere in rilievo che la creatività costituisce un elemento fondamentale per chi fa musica.
Una delle soluzioni potrebbe essere una certa apertura (date, concerti, festival, contest) alle band, anche poco note, che vengano da fuori (vedi il Progetto Streetambula di cui siamo co/organizzatori). Ma il pubblico dei piccoli centri è pronto a questa sorta di “rivoluzione”? Sembra piuttosto disposto ad ascoltare solo i propri amici, di là dell’interesse ridotto verso la musica.
Finché i piccoli centri ragioneranno con la logica bigotta e culturalmente ristretta, non ci sarà alcuna rivoluzione. La rivoluzione va stimolata e secondo noi, molti in questa valle (Valle Peligna, provincia de L’Aquila ndr), a partire da chi organizza eventi musicali e si occupa di band emergenti come voi di Rockambula, stanno lavorando bene per creare un circolo virtuoso in tal senso.
Cambiamo discorso ma non troppo. Perché i musicisti vanno con tanta fatica ad ascoltare i colleghi?
Molti musicisti (non tutti), disertano le serate dei loro colleghi, semplicemente per mancanza di umiltà, attenzione, informazione e forse anche invidia. È una costante fra colleghi, Morrisey ci ha scritto anche una canzone.
Passiamo a voi. La vostra musica è fortemente influenzata dal Post Punk dei Joy Division. Quali altre influenze vi si possono ascoltare?
La nostra musica è influenzata da diversi artisti del passato e del presente. Sicuramente i Joy Division hanno avuto un’influenza importante ma non principale. Prima di loro vorremmo citare Gary Numan, Depeche Mode, New Order, Asylum Party, Pj Harvey e Massive Attack senza dimenticare le forti influenze Punk che arrivano dalla nostra chitarrista Francesca Orsini e in particolare in brani come “Closer”, “Torture” e “The Party’s Over” che speriamo avrete presto la possibilità di ascoltare su disco.
Che progetti avete per scoprire il vostro peculiare sound e renderlo più moderno?
Premesso che oggi parlare di suono vecchio e nuovo risulta un po’ difficile in ambito Indie, vista la varietà e le molteplici combinazioni sonore tra i vari decenni e tra i vari generi, stiamo valutando di “svecchiare” il suono cercando, in fase di registrazione, di applicare con astuzia quelle caratteristiche sonore che possono far risultare il prodotto più moderno e muovendoci all’interno di questo impianto sonoro per mantenere il nostro suono volutamente vintage.
Oltre al limite dovuto dall’ovvia somiglianza con i padri del genere, ho notato che, dal vivo, c’è ancora qualche imprecisione soprattutto in chiave vocale e andrebbe attuata anche una più attenta ricerca melodica. Come pensate di muovervi in tal senso? Credete di dover lavorare ancora anche sulle canzoni ormai già ascoltate live?
Per ciò che riguarda la voce stiamo lavorando continuamente per perfezionare quanto già ascoltato dal vivo. Sicuramente un paio di brani richiedono una maggiore attenzione melodica e rivisitazione da parte nostra, per molti pensiamo che la soluzione attuale sia soddisfacente ma sappiamo che un gruppo deve essere sempre alla ricerca di novità’ e aperto a rivedere le soluzioni già date per stabili se necessario e se rispondono a una reale esigenza dei compositori. Pertanto anche le versioni live che avete ascoltato sono suscettibili di qualche cambiamento in fase di registrazione.
Uno dei modi migliori per superare i propri limiti è distruggere quelli mentali che ci portano ad ascoltare sempre le stesse cose. Per questo credo che per tutti, e ancor più per i musicisti, sia importante ascoltare tanta musica, vecchia e nuova, e sempre molto diversa. Qual è il vostro modo di approcciare alle nuove sonorità, alle nuove band? Chi vi piace tra le nuove proposte italiane e straniere e consigliateci un paio di dischi di questo ormai andato 2013?
È essenziale uscire dagli schemi mentali acquisiti, pertanto ci poniamo sempre con grande interesse all’ascolto di quanto di nuovo viene proposto dal mercato discografico soprattutto indipendente. Del 2013 ci sono piaciuti il nuovo dei Soviet Soviet e degli Arcade Fire senza dimenticare The National ma anche in ambito Pop ci sono molte produzioni di valore.
Sul palco si nota una certa spensieratezza alle chitarre (basso incluso) mentre Fabrizio D’Azzena (voce) mantiene un’aria seriosa, tesa, quasi preoccupata e ansiosa. Studiate attentamente le vostre performance, anche per quanto riguarda l’immagine oppure suonate cosi, come viene?
Sinceramente abbiamo ancora forse poca attenzione per l’immagine globale del gruppo ma ciò’ deriva principalmente dal fatto che per ora non è la priorità e pensiamo che sia la nostra musica a dover trasmettere sensazioni emotive a chi ci ascolta. Indubbiamente il nostro cantante è tipo ansioso ma la sua espressione seriosa è risultato di forte concentrazione e passione.
Per ora non avete nessun album pronto. Tra le varie motivazioni che ci hanno spinto a dare a voi il premio Rockambula c’è: “una delle band di cui ascolteremmo molto volentieri il prossimo disco”. Ce n’è uno in cantiere?
Attualmente stiamo per entrare in studio per registrare il nostro primo cd; vi diamo qualche anticipazione, si chiamerà Lust e sarà composto di otto o nove brani, sette li avete già ascoltati live e due che stiamo selezionando tra il corposo materiale a nostra a disposizione.
Vi faccio il nostro “in bocca al lupo”.
John Grant – Pale Green Ghosts
“L’abito non fa il monaco”, recita un vecchio adagio popolare. Infatti, a giudizio esclusivo della front cover – non eccezionale, ammettiamolo – il secondo appuntamento discografico di John Grant (già leader dei Czars), Pale Green Ghosts, si configura a prima vista come il solito e dozzinale prodotto Country statunitense, elemento che ben si accorda con l’estrazione geografica del soggetto in questione (la cittadina di Parker, Colorado). Ed invece no. Pale Green Ghosts é tutta un’altra storia. ”Non é lo stesso fottuto campo da gioco, non é lo stesso campionato e non é nemmeno lo stesso sport”, affermerebbe seccato Samuel Lee Jackson nei panni del sicario filosofo Jules Winnfield.
L’esordio solista di Grant si concretizza in Queen of Denmark, dato alle stampe nel dicembre 2010 ed accolto nel panorama discografico internazionale con il plauso unanime di critica e pubblico (album dell’anno secondo l’influente rivista specializzata Mojo). Il cantautore di Denver, dopo la militanza decennale negli Czars e la malinconica esperienza Folk Rock dei Midlake, persevera nel proprio percorso artistico dando libero sfogo al lato più sintetico della sua indole creativa, riportando alla luce (soprattutto nelle bonus tracks della versione deluxe) le fredde e marziali partiture elettroniche di New Order, Ultravox e Depeche Mode, straordinarie colonne sonore di una generazione indomita e ribelle che affollava i club Synth Wave sul finire dei mitici anni ottanta.
Tutto sembra girare per il meglio, quando… deus ex machina. Grant viene a conoscenza di una realtà infausta e terribile: la positività al virus HIV. A questo punto bisogna ricomporre con lucida pazienza i frammenti di un’esistenza trascorsa tra follie ed eccessi di ogni genere, archiviare definitivamente il passato nell’angolo più remoto della coscienza per cavalcare, ancora una volta, la cresta più alta dell’onda. Un bisogno impellente di tranquillità, da raggiungere ad ogni costo, con ogni mezzo. Il cantautore statunitense sceglie la via dell’esilio, emigrando tra i solitari ghiacci d’Islanda dove, nel celebre studio Oroom di Reykjavik, viene alla luce Pale Green Ghosts, con il fondamentale contributo artistico di Chris Pemberton (il tastierista che da tempo accompagna Grant nei suoi tour), Birgir Þórarinsson dei Gus Gus, Paul Alexander e Mckenzie Smith (rispettivamente bassista e batterista dei Midlake, presenti in due ballate ortodosse come “Vietnam” e “It Doesn’t Matter to Him”), il sassofonista Óskar Gudjónsson e la celeberrima Sinead O’Connor nell’inedita e compiaciuta veste di backing singer (autrice di una splendida performance in “Why Don’t You Love me Anymore”). Il multiforme e tormentato Pop/Folk Rock targato Czars/Midlake viene ripetutamente filtrato attraverso un flusso elettronico malsano, percussivo e minimale (particolarmente evidente nella title track “Pale Green Ghosts”), vero e proprio marchio distintivo del talentuoso Birgir Þórarinsson a.k.a. Biggi Veira, partorito attraverso l’ausilio di drum machine e sintetizzatori dal sapore squisitamente ottantiano. Troneggia su tutto il sorprendente registro baritonale di Grant, in grado di regalarci, per l’ennesima volta, liriche estremamente pungenti e sarcastiche (assolutamente fantastico in “GMF”: “sono il più grande figlio di puttana che potrai mai incontrare”); esperienze di vita vissuta, cronache di prostrazione e rivalsa, omosessualità ed omofobia, fino alla sconvolgente rivelazione della positività all’HIV, affidata al sax tenore di Óskar Gudjónsson nel brano “Ernest Borgnine” (“dad keep looking at me says I got the disease…”).
Per i feticisti del dettaglio: lo stesso John Grant, rievocando con una certa dose di malinconia gli anni ruggenti della gioventù, rivela che all’epoca era solito percorrere l’interstate 25 per raggiungere i vari club Synth Wave della zona; nei quaranta chilometri del tratto Denver – Boulder l’autostrada era fiancheggiata da numerose piantagioni di ulivi russi, le cui piccole foglie argentate acquisivano una particolare luminosità al chiaro di luna (le Pale Green Ghosts del titolo, per capirci). Fenomenologia e poetica dell’immagine, celebrazione tramite emotività e ricordo, rappresentazione figurativa che di per sé vale già il prezzo il biglietto.
Built to Spill
Ci ho messo parecchio a compilare questo report, me ne rendo conto. Non è tanto questione di tempo a disposizione, quanto di riordinare le idee che un concerto ti dà, in un determinato contesto e in un dato periodo della tua vita. Non che i Built to Spill siano il gruppo della mia vita, sono andata al concerto più che per curiosità che per fanatismo o ammirazione, ma la band sa muovere certe corde e se sei in un mood un po’ blu, è fatta. Il sound cupo, rumoroso in modo controllato ed elegante della band di Doug Martsch risuona nel parco del Circolo Magnolia davanti a pochissime persone (pochissime rispetto a quello che mi sarei aspettata, l’area davanti al palco era zeppa di gente, ma pur sempre di dimensioni molto contenute): il concerto si apre con “Goin’Against Your Mind” e insomma, il mio scazzo non sarebbe migliorato affatto. Martsch è nevrile nel modo di cantare, saldo davanti al microfono, un fascio di nervi: crede ad ogni parola che dice e questo rende il messaggio molto più immediato.
Il pubblico è molto attento, silenzioso, concentratissimo. Sembra un concerto d’altri tempi o pare di assistere a un vaticinio. I suoni non sono sempre pulitissimi, forse colpa della location: troppe acute che disturbano. Dopo “In The Morning”, “Revolution” e “Centre of the Universe” ho già le orecchie bollite. I Built to Spill non vantano chissà che presenza scenica, parlano pochissimo, si limitano a ringraziare, in italiano, quando si ricordano. Ma non è certo quel tipo di comunicazione che ricercano, né quel tipo di comunicazione che vuole il loro pubblico. Dopo l’intensa “Get a Life” la scaletta per me scorre abbastanza placida (“Heart”, “Strange”, “Sidewalk”, “Joyride”), fino a “I Would Hurt a Fly” che mi risveglia dalla trance mistica della confusione scazzo-depressiva che mi stavo portando addosso e mi fa godere della bella esecuzione di “Else”, “Fuck 2006” e della mia preferita, “Carry The Zero”. Una bella esecuzione, sì, per quanto Martsch non ce la faccia vocalmente più da almeno cinque canzoni: le frasi vengono troncate prima di quando avrebbero dovuto essere, come se mancasse il fiato e i falsetti sono addirittura stonati in più riprese.
La band rientra per un encore inaspettato e mozzafiato: sta suonando da più di un’ora e mezza consecutiva e se ne ritorna sul palco per lanciare due rivisitazioni molto personali e molto coraggiose di “How Soon is Now” degli Smiths e di “Age of Consent” dei New Order. Qualcuno neanche se ne accorge, qualcuno si gasa per la prima volta dopo un concerto molto intimista, essenziale, impreciso in più punti ma fondamentalmente molto buono per quanto riguarda l’intensità emozionale. Se non ci siete andati, non è che avete perso gran cosa a livello puramente tecnico-compositivo, però avete mancato l’occasione di vedere che la musica è ben altro che note pulite, precisione, grandiosità scenica. E un po’ secondo me ce lo si dimentica che il live è più pancia che dita veloci e frasi a effetto lanciate dal microfono.
New Order – Lost Sirens
Pur nell’evidenza clamorosa di molteplici riferimenti caratteriali, nell’indolenza nevrotico/lunatica che li ha sempre contraddistinti, i “nuovi” New Order di “Lost Sirens”, al di fuori delle contorte code giudiziarie, rimangono sempre sulla linea della sicurezza, ripercorrendo quasi per intero le gittate sonore di ieri, magari con un po’ meno di sgambettamenti dancers, ma da quel versante non ci si muove.
Il casinista e adorabile bassista Hooky se ne è andato sbattendo le porte ma in questo Ep comprensivo di otto brani per un circa quaranta minuti di musica nebbiosa, Ottantiana con tutti i crismi, il suo basso risuona e fa tonfo ancora in maniera impareggiabile, con intatta la fascinazione wave che ha segnato una generazione al completo; tracce estrapolate da sessioni discografiche del 2005, tirate fuori da quel bel “Waiting for the sirens” messo a congelare per vicissitudini e relazioni increspate e che solo ora vengono messe all’aria per la goduria di massa. Dunque una band riformulata nel fisico ma identica nella memoria, un sound totale che ritrova l’equilibrio e l’ostinazione intatta per piacere ancora.
Alcune tracce già sono note, rivisitate con noise “Hellbent”, con l’impronta noir dei Velvet Underground “I Told You So”, un ottimo sculettamento dance “Sugarcane” e qualche lascivia sdolcinata che tra “Californian Glass” e “Recoil” stende una bava amara di nostalgia appassionata, e le atmosfere di contorno? Tecnicismi soffici di elettronica e belle fiammate di chitarra (spesso anche computerizzata) che già sono patrimonio insostituibile per memorabili bridge radio-friendly.
E la storia va, prosegue il suo viatico sommersa da distorsori e foto ingiallite di Joy Division verso un futuro al contrario.