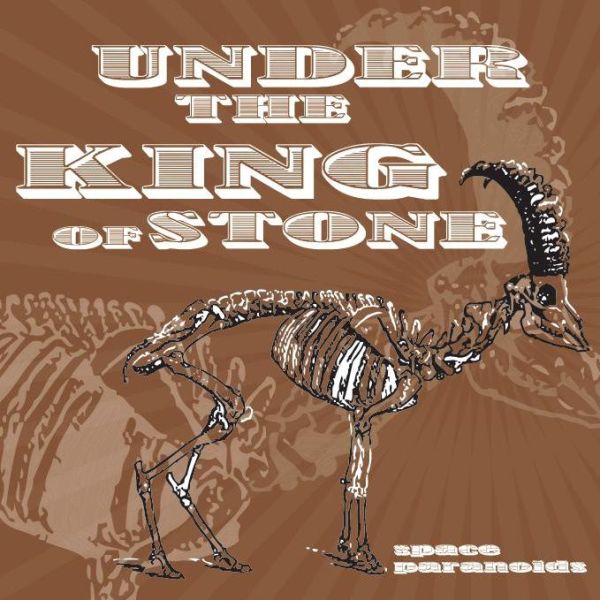Nuova coproduzione per la label europea Fuzz Club Records e l’americana The Reverberation Appreciation Society, fondatrice dell’Austin Psych Fest, e nuova bomba sonica che raccoglie alcuni dei nomi più interessanti della scena psichedelica del vecchio continente. Si parte con lo Space Rock di “No Place to Go” dei londinesi The Oscillation per poi volare in Spagna con “Moon” degli Holy Science. Psichedelia mantrica dal sapore Post Punk stile Soft Moon che è anche il modo più efficace, apprezzabile e diretto per introdurci a questa compilation la quale ci regalerà non poche sorprese. Si cambia completamente sound con “You Now” dei norvegesi Deathcrush; voce femminile cazzutissima e pura potenza Psych Noise per uno dei momenti più rabbiosi e violenti dell’intera raccolta, in totale contrapposizione allo Shoegaze di chiara ispirazione My Bloody Valentine della successiva “Suddenlines”, brano eccelso opera dei berlinesi The History of Colour Tv.
Con “You Drive Me Insane”, torna una nostra vecchia conoscenza, l’islandese Henrik Baldvin Bjornsson, leader anche dei mitici Dead Skeletons e qui con la storica formazione Singapore Sling, del cui ultimo lavoro vi abbiamo ampiamente parlato e tessuto le lodi. “Meltdown Corp.” Dei nostri connazionali Newcandys segna il passaggio più Stoner di questo The Reverb Conspiracy Vol. 3 e si lega perfettamente al suono sabbioso di “Death Is on the Way” dei Sound Sweet Sound e alla successiva “Green Like an Alien” degli Undisco Kidd che figura il punto centrale della tracklist. Sezione ritmica martellante, voce marcissima e riff di chitarra taglienti come rasoi sporchi di ruggine.
La seconda parte si apre con “Ausland” che aggiunge altra carne al fuoco a un’opera la quale ha già messo sul piatto una miscela di Blues, Folk, Rock’n Roll e Krautrock da farvi uscire di testa. Si sente tanto dei Neu! nel brano dei Camera e la sensazione è che si sia davanti ad una sorta di vero e proprio omaggio al capolavoro “Hallogallo”. Prima dei nuovi nomi pesanti che scopriremo in chiusura, è la volta della Darkwave “Side Effects” dei Future la quale, sempre con attitudine Psych, incorpora quel quid sintetico che sembrava essere l’unica effettiva mancanza dell’album. Fatto il giro d’Europa, si vola ancora nel Regno Unito, precisamente a Liverpool, dai grandi Mugstar che, con “Hollow Ox”, faranno traballare le pareti della vostra stanza con un cocktail lisergico di Space Rock e Stoner interamente strumentale.
Distorsioni violente, voce cupa, sommersa, affogata in un Noise aggressivo in “Tungsten” dei sempre britannici One Unique Signal. Siamo in dirittura d’arrivo e manca qualche nominativo spesso. Nessun problema perché prima è la volta di Goat con la sua “Hide from the Sun”, mixata da Anton Newcombe dei Brian Jonestown Massacre, che regala un sapore Apocalyptic Folk a quest’ultima parte e poi ai londinesi Lola Colt con “Away from the Water”, pezzo che fornisce anche il titolo all’album dello scorso anno prodotto da Jim Sclavunos di Nick Cave and the Bad Seeds, il quale ha trovato un discreto favore del pubblico anche in terra italiana. Post Punk psichedelico, vaghi accenni Hard Rock nella sezione ritmica, voce che ricorda i poetici lamenti d’una certa Patty Smith e chitarre evocative, distese ma inquietanti fino alla conclusione devastante con un minaccioso muro di suono, solo a tratti graffiato da una tastiera che ricorda il Blues dei Doors. Ottima la scelta di chiudere la tracklist con “As We’ve Been as One” di François Sky che qui vede il featuring di Jeff Levitz dei Brian Jonestown Massacre.
Il trip su e giù per l’Europa è concluso e le prime sensazioni sono quelle che ti fanno ben sperare e credere che di talento ce ne sia ancora tanto da scoprire. Qualche nome nuovo e vecchie leggende dello Psych Rock si sono alternati in un’opera che a essere sinceri ha poco senso, se si vuole analizzare oltre l’apprezzabilità dei singoli brani, specie per il fatto che siano già editi e quindi poco stimolanti per i più attenti seguaci della scena ma che, presa per quello che è, senza troppi entusiasmi, vi regalerà ore di puro godimento chimico.