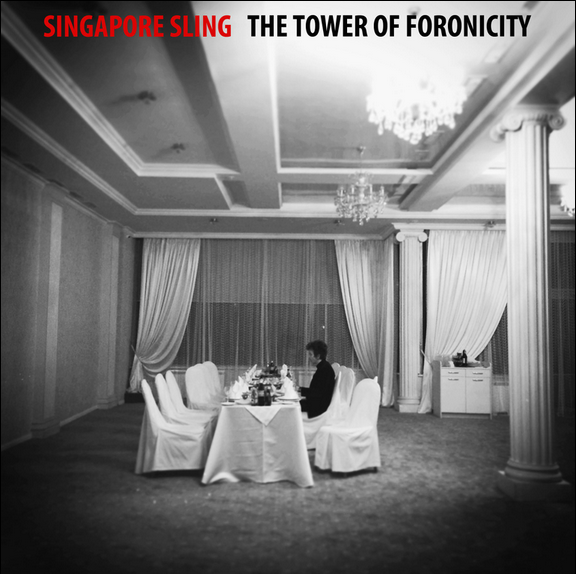“…the road…”
Torna alla carica il sensazionale e italianissimo duo Cristiano Deison e Andrea Gastaldello che, l’anno appena trascorso, ci aveva deliziato con un album capace di travolgere il sottoscritto quasi costringendolo a porlo al vertice assoluto della speciale chart dedicata ai migliori full length 2014 della penisola. Tornano Deison & Mingle con Weak Life e lo fanno nel migliore dei modi, pur non suscitando lo stesso stupore che mi colse ai primi ascolti di Everything Collapse[d]. Riprendono quella strada attraversando il deserto dove tutto è crollato e si perde nell’oblio, guidato da un movimento pigro e costante, alla ricerca di qualcuno o qualcosa ma sempre navigando in quell’oceano di dubbio che solo certa destrutturazione sonica riesce a formare e che sta alla base di ogni nuova rinascita. Gli ingredienti di questo Weak Life sono gli stessi che i più attenti avranno apprezzato nelle precedenti opere del duo. Droni, field recording e loop strappati da ritmiche disturbate e disturbanti, cui si aggiungono beat distorti e avvolti in un’elettronica gonfia di sperimentazione.
“Skeptic Move” apre l’album alla grande, in un’aurea epica che suona come il respiro d’un universo incredibilmente rumoroso. Dopo un’introduzione tanto travolgente, il suono si fa più dimesso (“Tangles”) ma nello stesso tempo claustrofobico e inquietante, grazie ad un uso spettacolare delle basse frequenze (“Osso Temporale”). Cambia nuovamente volto con “Unanimated”; suoni taglienti, confusi, acuti, spostano l’attenzione dal cosmo fino al microcosmo della mente umana, per merito di un sound psicotico, evocativo e introspettivo. Leggeri accenni Glitch aprono “Lost Pieces”, brano che si ricollega al trittico d’apertura e che introduce “Bloody Feelings”, centro fisico dell’opera ed anche il passaggio minuziosamente più minimale del lavoro di Deison & Mingle. Da qui inizia la seconda parte del viaggio che ognuno di voi, secondo le proprie inclinazioni e stato d’animo, potrà scegliere essere un eterno ritorno o un salto nel buio verso l’ignoto.
Il suono si complica (“Circle of Red Drops”), diventa quasi marziale e aggressivo e si sposta su un terreno più concreto, meno etereo. L’inizio di “Him Seite” (quasi?) ricorda il rumore freddo di una chiamata senza risposta ma ancora una volta saranno i bassi cupi a dominare la scena, così come nella successiva “Perfect Huddle”, che riprende la scia di una minimale e rovinata Drum’n Bass. Spezza la catena “Obliquity (Low)” che dilata i ritmi e ci riporta nel vuoto cosmico prima della title track la quale regala lievi note di piano e un’atmosfera nostalgica mai presente concretamente nei brani antecedenti.
“Weak Life” è l’ultimo pezzo ma non distraetevi troppo in chiusura perché, come ormai consuetudine, vi aspetta una cover/ghost track che farà tremare le pareti di casa tanto da farvi nascondere sotto al tavolo. “Circle of Shit”, reinterpretazione del brano dei giganti Godflesh contenuto in Songs of Love and Hate è il modo migliore per chiudere un album che sancisce definitivamente la grandezza di questo duo orgogliosamente italiano.
Deison Mingle Weak Life (teaser) from merisma on Vimeo.