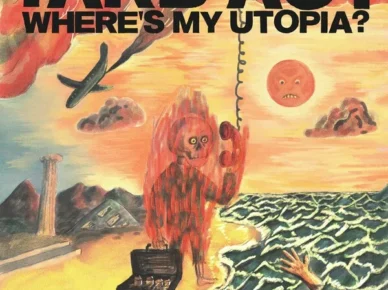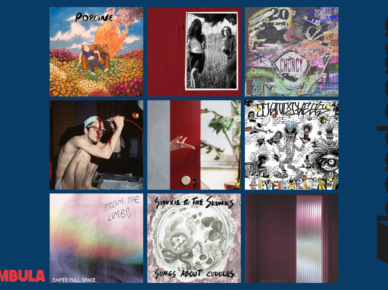Spero che in vita vi sia capitato di vedere quel gran bel film di Alan Ball intitolato American Beauty; se lo avete visto vi sarà facile ricordare lo sguardo nella scena finale del protagonista Kevin Spacey. Avete visualizzato? Ecco, quella è la mia stessa espressione dopo aver ascoltato per novanta minuti il nuovo, doppio album, dei The Wave Pictures. Il gruppo e nella fattispecie il leader David Tattersall si contraddistingue per essere decisamente prolifico in quanto a canzoni prodotte; pensiamo che dal 2004 a oggi, ogni anno ha visto l’uscita di un loro album. Volendo fare i calcoli si perde facilmente il conto e se dovessi fare un paragone di basso respiro, neanche la pizzeria sotto casa, in serata Champion’s, sarebbe in grado di reggere il ritmo. Ma procediamo con calma; come sono arrivata alla morte celebrale dopo novanta minuti di Indie Rock britannico fino al midollo? Ho provato a trovare una risposta che non fosse qualcosa del tipo “signorina lei è troppo stressata”, o “non si ascoltano i dischi dal computer”. Purtroppo la maledetta verità e che David e soci ripetono per venti brani il medesimo schema, basso, chitarra, batteria all’interno di un territorio estremamente definito, sul quale innestano in maniera alternata varianti che toccano il Blues “Chestnut”, il Rock anni 70 “Better to Be Loved”, con un giro ispirato senza dubbio da “Have You Evern See The Rain”, e anche un po’ di Calypso “WhiskY Bay”.
Tra la miscellanea di schemi e varianti sul tema che nemmeno Queneau pensava possibili quando scrisse “Esercizi di Stile”, non tutto è da rifilare nel cassetto dell’oblio; ci sono pezzi toccanti e godibili come la ballata struggente “The Yellow Roses” e pezzi in cui il ritmo diventa trainante e il sound si fa nuovo come in “Shell” e “Narrow e Lane”, anche se quest’ultima viene sporcata dal solito assolone tanto caro al gruppo. L’impressione generale che emerge dall’ascolto è quella di un’urgenza espressiva da parte del leader, che però si concretizza in tante canzoni buttate lì, nel mucchio. La scelta di farsi guidare dall’impeto della scrittura piuttosto che da un desiderio di qualità fa si che testualmente ci sia un buon margine per liriche argute e ironiche che però cede il passo sul piano dell’innovazione e della ricerca musicale, nel quale si vedono solo timidi spiragli.
Nel complesso ogni brano assomiglia sempre a qualcosa di già ascoltato e spesso portato alla ribalta da qualcun altro; un esempio fra tutti sono i brani “ The Ropes” e “All My Friends” rispettivamente e marcatamente simili ai Talking Heads la prima, e ai Dire Straits la seconda. L’impeto, il guizzo, il genio compositore sono tutte cose necessarie per un musicista, senza le quali forse, sarebbe solamente un ripetitore automatico privo d’anima. D’altro canto, questo fuoco vitale dovrebbe essere rivolto verso il dettaglio, la ricerca, la sperimentazione. In due parole, un artista dovrebbe dare in pasto ai propri fan il meglio, non il tutto. City Forgiveness non lo fa, non si sposta di un millimetro dal solco tracciato dal 2004 e tutta la laboriosa attività del gruppo svanisce nel mare magnun delle loro stesse venti tracce. Se si fosse fatta una selezione a monte tra queste avremmo avuto un disco interessante di cui parlare.
City Forgiveness Dire Straits indie-rock Moshi Moshi Records Simona Ventrella Talking Heads The Wave Pictures
Last modified: 20 Novembre 2013